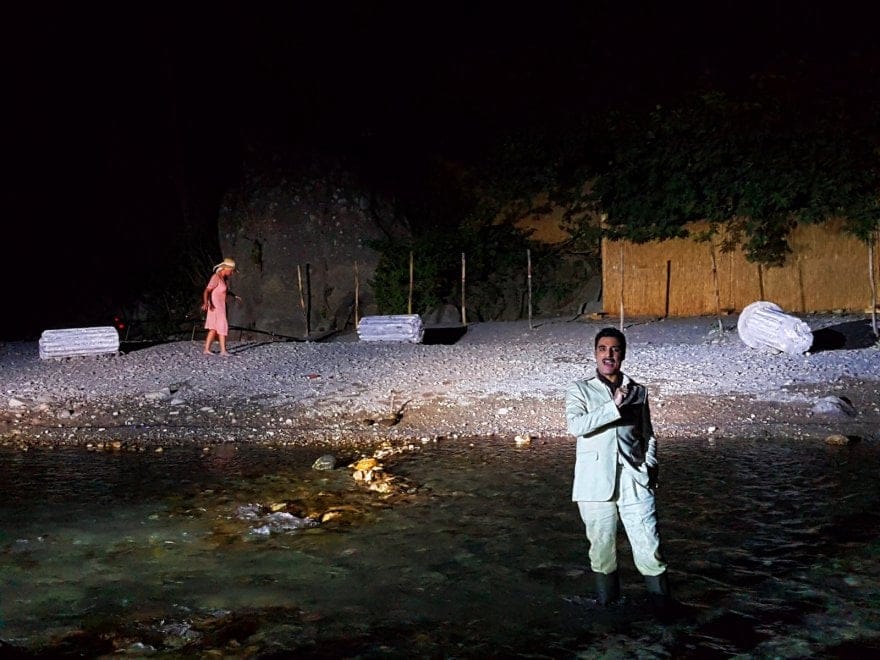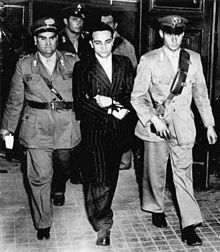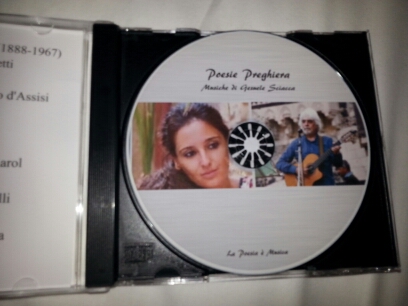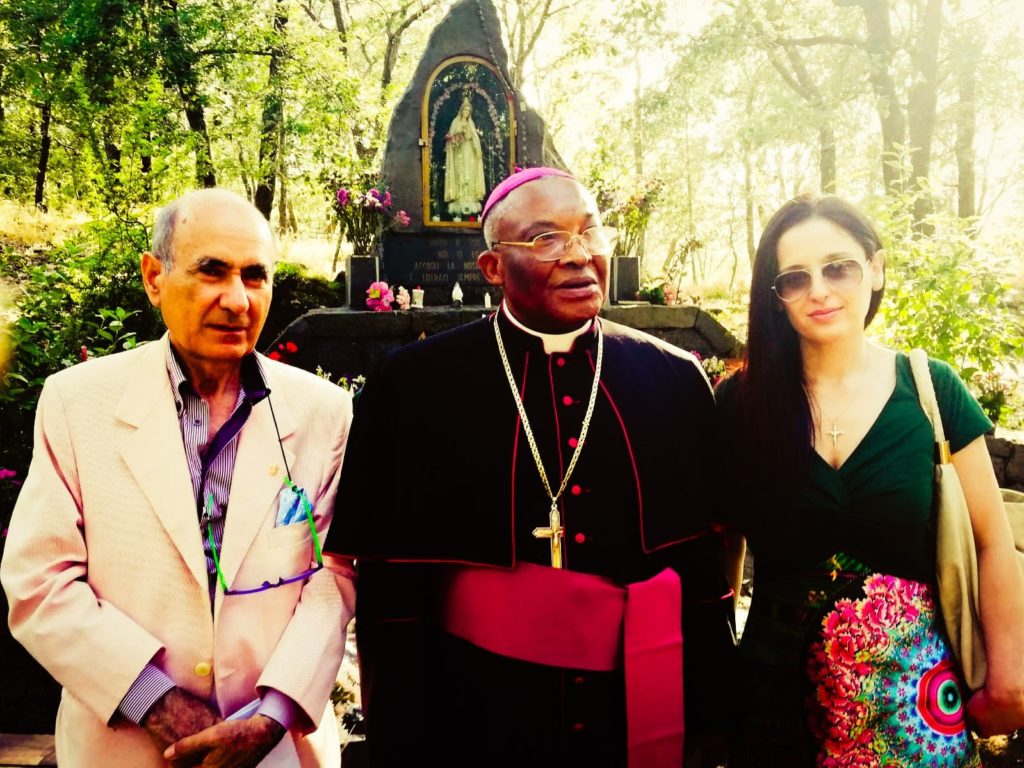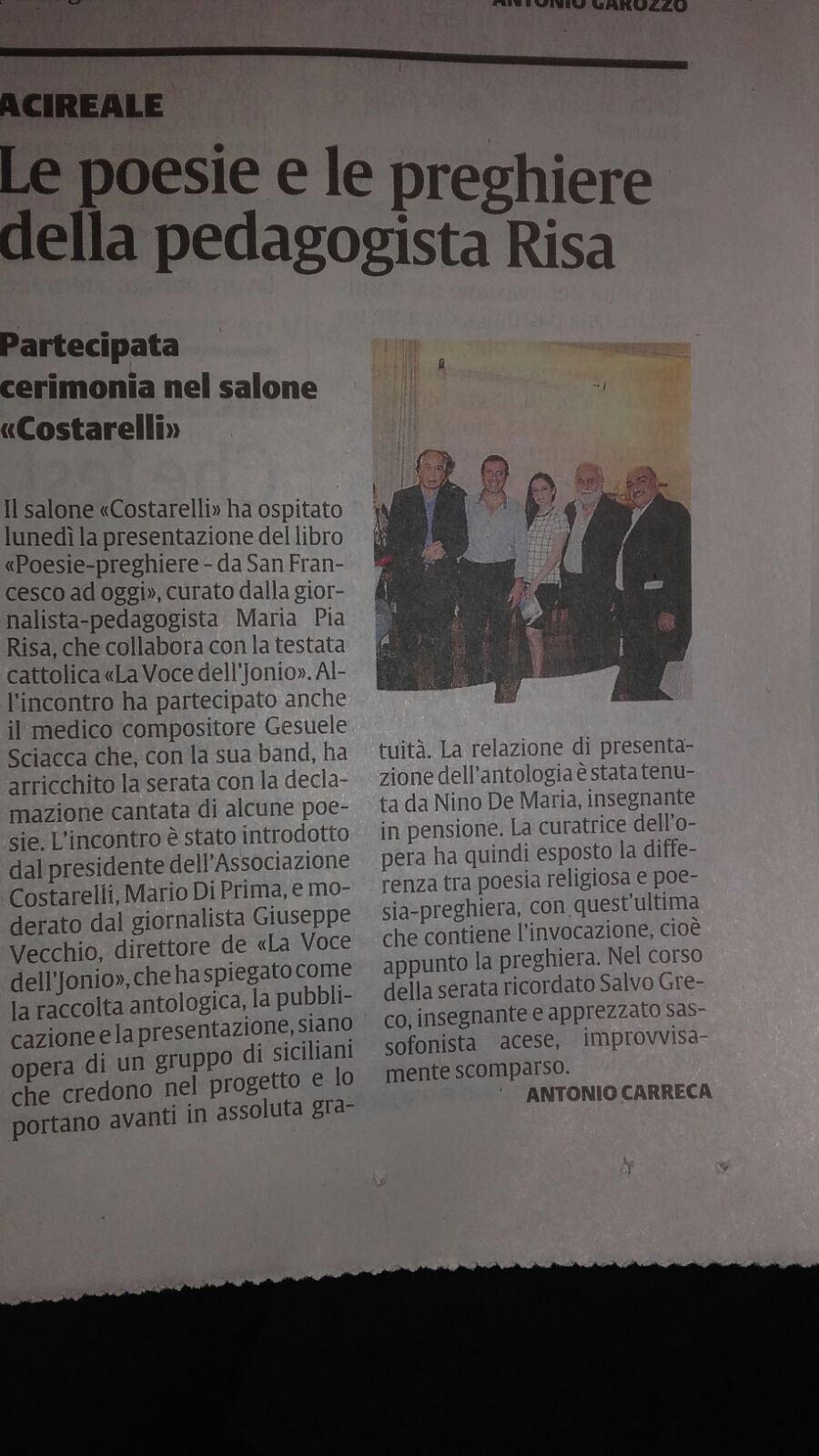Costituzione della Società per Azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale
( ATO CT1 ).
Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.
Atto stipulato in data 30 dicembre 2002 presso lo studio del notaio Carlo Saggio.
I SOCI:
Provincia Regionale di Catania, Assessore Provinciale Salvatore Cristaldi, delegato dal Presidente Sebastiano Musumeci;
Comune di Bronte, Leanza Salvatore Sindaco;
Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore Maccarrone Salvatore;
Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Cardile Concetta;
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Nucifora Sebastiano;
Comune di Giarre, in persona dell’Assessore Vitale Salvatore, giusta delega del Sindaco pro tempore Toscano Giuseppe;
Comune di Linguaglossa, in persona del sindaco pro tempore Stagnitta Antonino Felice;
Comune di Maletto, in persona del Sindaco pro tempore Parrinello Nunzio;
Comune di Maniace, in persona del Sindaco pro tempore Conti Emilio;
Comune di Mascali, in persona dell’Assessore Maccarrone Alfio, giusta delega del Sindaco pro tempore Carota Silvestro;
Comune di Milo, in persona del Sindaco pro tempore Sessa Paolo;
Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco pro tempore Cavallaro Giuseppe;
Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore Del Campo Ernesto Alfonso;
Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore D’Urso Carmelo;
Comune di Sant’Alfio, in persona del Sindaco pro tempore Patti Leonardo;
Componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dai Soci, per il primo triennio:
Spampinato Mario, presidente
Tomarchio Salvatore, vice presidente
Di Maria Orazio, consigliere
Pavone Giovanni, consigliere
Rubbino Francesco, consigliere
Spartà Salvatore, consigliere
Vasta Gianni, consigliere
Componenti il Collegio Sindacale, nominati dai Soci, per il primo triennio:
Bonaccorsi Roberto, presidente;
Barbagallo Salvatore, sindaco effettivo;
Caprino Campana Gaetano, sindaco effettivo
Scaglione Antonio, sindaco supplente;
Caruso Paolo, sindaco supplente.
I Presidenti che dal 2002 ad oggi si sono susseguiti :

Amministratori ATO CT1 Società Joniambiente
Contenzioso con il comune di Randazzo
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe
proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione e per la restante
parte lo respinge, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in
parte il ricorso introduttivo e per la restante parte lo respinge.
data: 7 luglio 2021.
Qui di seguito la sentenza che modifica la parte riguardante la possibilità che il comune potesse uscire dall’ATO CT1 – Società Joniambiente SpA in liquidazione.
Il Consiglio N. 00026/2021 REG.RIC.
N. _____/____REG.PROV.COLL.
N. 00026/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2021, proposto dalla società
Joniambiente s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Agatino Cariola e Fabio Santangeli,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico
eletto presso lo studio Agatino Cariola in Catania, via Gabriello Carnazza, 51;
contro
Comune di Randazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Bronte non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione
staccata di Catania (Sezione Prima) n. 2932/2020, resa tra le parti
N. 00026/2021 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Randazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n.
84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, così come modificato dall’art. 6 del
d.l. n. 44/2021, il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati
Agatino Cariola e Giovanni Parisi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Consiglio comunale di Randazzo (CT), con deliberazione n.10 del 2020 ha
deliberato il recesso dalla società Joniambiente s.p.a. in liquidazione (di seguito:
“Joniambiente”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20 del medesimo d.
lgs. n. 175 del 2016.
2. Detta deliberazione è stata impugnata da Joniambiente, la quale ha proposto
ricorso anche per il “riconoscimento dell’obbligo del Comune di Randazzo a
contribuire alle spese di gestione della Società partecipata Joniambiente s.p.a.
[…], sino alla fine della stessa liquidazione”, per la dichiarazione di inefficacia
della deliberazione impugnata (e del correlato recesso ivi disposto) rispetto alle
obbligazioni nei confronti di terzi che Joniambiente s.p.a. in liquidazione sarebbe
costretta a soddisfare “in dipendenza dei rapporti contrattuali insorti per la
gestione del servizio di igiene pubblica anche a favore del Comune di Randazzo ed
all’esito di tutti i contenziosi pendenti”.
3. Il Tar Sicilia – Catania ha respinto il ricorso con sentenza 9 novembre 2020 n.
2932.
4. La sentenza è stata appellata davanti a questo CGARS con ricorso n. 26 del
2021, corredato da istanza cautelare.
5. Con ordinanza 5 febbraio 2021 n. 69 l’istanza cautelare è stata accolta al solo
fine della fissazione dell’udienza di merito, che è stata fissata il 7 luglio 2021.
N. 00026/2021 REG.RIC.
6. Nel giudizio di appello si è costituito il Comune di Randazzo.
7. All’udienza del 7 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è parzialmente meritevole di accoglimento.
9. Prima di scrutinare il ricorso in appello si rileva che non costituisce un motivo
sul quale questo CGARS è chiamato a pronunciarsi il paragrafo rubricato “In via
preliminare: sull’obbligo degli enti locali soci di rispondere delle obbligazioni
della Società d’ambito e sulle conseguenze che ne derivano a carico degli enti
soci”, nel quale viene esposta la disciplina “circa l’obbligo dei Comuni-soci di
rispondere delle obbligazioni assunte dall’Ato per prestare i servizi di riferimento”,
in quanto non contiene un motivo di doglianza, tanto è vero che
è articolato prima (e separatamente, anche dal punto di vista grafico) rispetto alla
successiva illustrazione delle specifiche censure avverso la sentenza gravata, così
come nel ricorso introduttivo detto paragrafo è articolato prima (e separatamente)
rispetto alla successiva illustrazione delle specifiche censure avverso l’atto
impugnato.
Ciò comporta che non attiene alla presente controversia la questione degli asseriti
debiti del Comune di Randazzo nei confronti della società appellante con
riferimento alla gestione del servizio dei rifiuti svolta dalla stessa società (sui quali
ha interloquito anche controparte e poi controdedotto nuovamente parte appellante).
10. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella
parte in cui il Tar ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso di primo grado per la
“la mancata impugnazione della deliberazione consiliare n.18/2020 in tema di
revisione delle partecipazioni che ha previsto il recesso […] i profili di
inammissibilità che da ciò – pacificamente – discenderebbero”.
Il motivo, ininfluente rispetto alla decisione del Tar, che ha comunque scrutinato il
merito del ricorso, con pronuncia di infondatezza (cui sono rivolte le censure
scrutinate infra), diviene rilevante nel caso di specie in ragione del parziale
N. 00026/2021 REG.RIC.
accoglimento del ricorso.
Esso è fondato.
In primo luogo la deliberazione è stata impugnata con ricorso straordinario al
Presidente della Regione il 21 dicembre 2020.
In secondo luogo, l’eventuale mancata impugnazione della deliberazione consiliare
n. 18 del 2020 in tema di revisione delle partecipazioni, che ha previsto il recesso
da Jonica, non determina l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente
giudizio (avverso la deliberazione attuativa).
La deliberazione n. 18 del 2020 assolve infatti una funzione programmatoria e
compulsiva delle future attività dell’ente in tema di razionalizzazione degli
organismi partecipati.
Essa non rileva nella prospettiva dell’immediata lesività, atteso che quei programmi
possono poi subire delle modificazioni nell’an, nella tempistica e nel quantum e che
comunque scontano la possibilità della mancata attuazione. In termini generali, è
infatti l’atto che esegue le intenzioni dell’Ente che manifesta un’immediata lesività.
Il piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016 trovano la
propria ratio nell’esigenza di incentivare la dismissione delle partecipazioni
societarie antieconomiche o superflue, imponendo agli enti di verificare
periodicamente le ragioni delle partecipazioni detenute. Detta funzione è presidiata
da istituti tipici dell’ordinamento contabile, la previsione di una sanzione per la
mancata adozione del piano e l’eventuale ricorrenza di una responsabilità
amministrativo contabile.
E’ in linea con tale impostazione il fatto che la Corte dei conti, nell’ottica di una
sana gestione finanziaria degli enti, consideri la “revisione delle partecipazioni” un
atto doveroso (“la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte
degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno
eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata
dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”, così la
N. 00026/2021 REG.RIC.
Sezione delle autonomie, delibera n. 22/2018/INPR).
Detta obbligatorietà, infatti, riguarda l’adozione del piano di cui all’art. 20 del d.
lgs. n. 175 del 2016, non la successiva attuazione, ed è presidiata da una sanzione e
dall’eventuale responsabilità amministrativo contabile, così spostando nell’ambito
del particolare ordinamento contabile gli effetti e le conseguenze, oltre che la
rilevanza, dell’adozione dell’atto di programmazione.
In tale prospettiva gli istituti introdotti dal d. lgs. n. 175 del 2016 non possono
essere interpretati in senso ostativo rispetto alla volontà del legislatore di riordino
delle partecipazioni pubbliche (sicché l’omesso inserimento di un’operazione di
razionalizzazione nella delibera programmatoria non può essere inteso come
impedimento alla realizzazione di detta operazione), mentre l’avvenuto inserimento
dell’operazione di snellimento nell’ambito del programma è funzionale a facilitare
la successiva implementazione concreta della scelta amministrativa, scelta che
viene attuata successivamente.
D’altro canto neppure gli esiti del ricorso straordinario avverso la deliberazione
presupposta producono necessariamente riflessi nell’ambito della presente
controversia (dipendendo dal tenore del singolo atto e dai motivi di ricorso), con la
conseguenza che neppure l’annullamento di uno di detti piani (che comporta fa
venir meno lo specifico progetto di dismissione nell’atto di programmazione)
impedisce necessariamente di cedere la titolarità delle quote sociali con un atto
indipendente. Ciò perché altrimenti l’atto programmatorio di cui all’art. 20 del d.
lgs. n. 175 del 2016 (o, meglio, la mancata previsione di un’operazione di
razionalizzazione, o l’annullamento di essa) produrrebbe un effetto contrario
rispetto alla volontà legislativa di incentivare, anche attraverso quel piano, gli
interventi di dismissione di partecipazioni antieconomiche.
E in ogni caso non risulta agli atti che sia intervenuta una decisione sul ricorso
straordinario.
10.1. Il motivo è quindi fondato, con conseguente ammissibilità della domanda
N. 00026/2021 REG.RIC.
introduttiva del presente giudizio.
11. Con il secondo e il quarto motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della
sentenza nella parte in cui il Tar ha dichiarato legittimo il recesso del Comune di
Randazzo.
11.1. Il motivo è meritevole di accoglimento.
Il tema sotteso alla presente controversia necessita di essere affrontato considerando
la prospettiva pubblicistica e la prospettiva privatistica, sia in riferimento all’istituto
del recesso (del Comune di Randazzo), sia in relazione all’istituto della
liquidazione societaria (di Joniambiente).
Con l’atto qui impugnato il Comune di Randazzo ha esercitato il recesso nei
confronti di Joniambiente, società in liquidazione.
In particolare, a tale ultimo riguardo, l’ambito territoriale ottimale per il servizio di
gestione dei rifiuti è stato introdotto con l’art. 23 del d. lgs. n. 22 del 1997.
Successivamente il d. lgs. n. 152 del 2006 ha istituito e disciplinato le Autorità
d’ambito, le quali agiscono attraverso gli ATO, destinatari di alcune prerogative
precedentemente affidate alle regioni e alle province in merito di gestione dei
rifiuti.
Joniambiente s.p.a., che rappresentava l’Ambito Territoriale CT1, è stata costituita
dal Comune di Randazzo, unitamente ad altri Comuni della ex provincia di Catania.
Lo stesso provvedimento impugnato in primo grado riporta che “con deliberazione
del Commissario ad Acta, n.1 del 17/12/2002, il Comune di Randazzo ha aderito
alla società d’Ambito denominata Joniambiente, approvando contemporaneamente
lo Statuto della società d’Ambito” e che “le quote di partecipazione, sottoscritte dal
Comune di Randazzo per l’adesione alla Joniambiente S.p.A., oggi in Liquidazione,
ammontano a 8,19, pari ad € 8.189,00”.
La l.r. n. 9 del 2010 ha posto le società d’ambito in liquidazione (le gestioni da
parte delle s.p.a. ATO “sono cessate dalla data del 30 settembre 2013 e sono state
trasferite in capo alle S.R.R., con conseguente divieto per i liquidatori delle società
d’ambito di compiere ogni atto di gestione”, così l’art. 19) e ha istituito al loro
N. 00026/2021 REG.RIC.
posto le SRR, Società Regolamentazione Rifiuti, le quali hanno progressivamente
assunto il servizio, direttamente o tramite i comuni riuniti in ARO.
Attualmente quindi Joniambiente in liquidazione svolge attività liquidatoria e non
gestisce più il servizio rifiuti.
Il Comune di Randazzo ha motivato il proprio recesso dalla partecipazione in
Joniambiente in liquidazione sulla base delle seguenti considerazioni:
– la razionalizzazione imposta dall’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016 in punto di
partecipazioni societarie da parte degli enti locali;
– lo stato di dissesto del comune di Randazzo (deliberazione 30 maggio 2019 n.
17);
– l’irragionevolezza di pagare i costi di gestione di Joniambiente in liquidazione,
quelli “inerenti il mantenimento di SRR Catania Provincia nord” e “i costi
amministrativi e gestionali per far fronte al servizio di igiene urbana del Comune
di Randazzo, attualmente gestito dallo stesso Comune”.
Tale motivazione non trova corrispondenza nelle fattispecie di recesso previste dal
legislatore.
11.2. Principiando dalla disciplina pubblicistica, il d. lgs. n. 175 del 2016 non
prevede una disciplina derogatoria del recesso del socio, se non in un caso,
ricadendo pertanto la relativa disciplina nella previsione di cui all’art. 1, comma 3,
d. lgs. n. 175 del 2016, secondo cui “per tutto quanto non derogato dalle
disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione
pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di
diritto privato”.
In particolare, il d. lgs. n. 175 del 2016 incentiva la razionalizzazione delle società a
partecipazione pubblica, senza prevedere, salvo specifici casi, modalità di cessione
di società o di quote ulteriori rispetto a quelle ordinariamente consentite in ambito
commerciale (alienazione di quota, cessione, messa in liquidazione, fusione o
soppressione di società).
N. 00026/2021 REG.RIC.
Fra gli strumenti di dismissione introdotti dal d. lgs. n. 175 del 2016 vi è l’ipotesi di
recesso di cui all’art. 24 comma 5, che non si applica al caso concreto perché fa
riferimento alla mancata attuazione di una dismissione prevista nel piano di
razionalizzazione mentre nel caso di specie la dismissione controversa è stata
prevista e attuata (sul punto Corte dei conti, Sez. reg. Lazio, deliberazione n.
35/2020/VSG e Sez. reg. Lombardia 79/2018/PAR).
11.3. Pertanto l’istituto del recesso, cui fa riferimento il provvedimento impugnato,
trova fondamento nella disciplina privatistica.
Inquadrato nella categoria dei diritti potestativi sostanziali, connotati dal fatto che il
titolare è abilitato a produrre una modificazione nella sfera giuridica altrui non
sottoposta a controllo giudiziale, l’art. 2437 c.c. prevede, al comma 1, le cause di
recesso inderogabili, riguardanti la modifica significativa dell’oggetto sociale, la
trasformazione della società, il trasferimento della sede all’estero, la revoca dello
stato di liquidazione, l’eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o
previste dallo statuto, la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso
di recesso, le modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di
partecipazione. Al comma 2 sono indicate ulteriori cause di recesso, derogabili
dallo statuto, quali la proroga del termine di durata della società, l’introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Al comma 3 è attribuita facoltà
di recesso ad nutum al socio di società di durata indeterminata e al comma 4 è
previsto che lo Statuto possa introdurre altre ipotesi di recesso.
Nello statuto di Jonicambiente non sono previste ulteriori ipotesi di recesso mentre
viene effettuato un rimando alle norme del codice civile e alle altre disposizioni in
materia di società (art. 30), in linea con la sopra riferita disposizione di cui all’art.
1, comma 3, d. lgs. n. 175 del 2016.
Il recesso di cui alla deliberazione impugnata, motivato nei termini sopra delineati,
non integra alcune delle ipotesi di recesso previste dai commi 1 e 2 dell’art. 2437
c.c., non potendo essere ricondotto ad una modifica significativa dell’oggetto
sociale, alla trasformazione della società, al trasferimento della sede all’estero, alla
N. 00026/2021 REG.RIC.
revoca dello stato di liquidazione, all’eliminazione di una o più cause di recesso
derogabili o previste dallo statuto, alla modificazione dei criteri di valutazione delle
azioni in caso di recesso, alle modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o
di partecipazione, alla proroga del termine di durata della società, all’introduzione o
alla rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.
Rimane pertanto la sola possibilità di ritenere applicabile al caso di specie il
recesso ad nutum previsto dal terzo comma dell’art. 2437 c.c.
A fronte delle specifiche ipotesi di recesso previste dal codice civile e considerando
la mancanza di previsioni ulteriori di recesso da parte dello Statuto, la
giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto sembra chiudere le porte
all’interpretazione analogica dei casi di recesso ad nutum di cui all’art. 2437
comma 3 c.c., previsto nei casi di durata indeterminata della società, anche al di
fuori di detta ipotesi (dallo statuto di Joniambiente si evince che la durata della
società è fissata per il 2030).
La questione di fondo riguarda la possibilità di equiparare, ai fini di legittimare il
recesso ad nutum del socio, la previsione statutaria di una società per azioni,
contratta per un tempo particolarmente lungo, a quella di società con previsione di
durata a tempo indeterminato.
In disparte ogni valutazione in ordine alla possibilità di qualificare il termine di
durata di Joniambiente, individuato nello statuto nel 2030, come “particolarmente
lungo”, gli indici normativi e sistematici convergono nel non consentire detta
equiparazione (e quindi il recesso ad nutum del socio di società per azioni in caso
di termine non indeterminato della società ma “particolarmente lungo”).
Depongono in tale senso la lettera del comma 3 dell’art. 2437 c.c., che limita
tassativamente la possibilità di recedere ad nutum al solo caso di società contratta a
tempo indeterminato, e la prospettiva sistematica, che deve tenere in considerazione
la disciplina dettata per le società di capitali e le esigenza di certezza che la
connotano, nonchè la tutela dei creditori sociali, i quali, facendo affidamento solo
N. 00026/2021 REG.RIC.
sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.
Sullo sfondo si pone la comparazione tra l’interesse del socio di società per azioni a
dismettere il suo investimento e l’interesse del resto della compagine e della società
stessa a portare avanti il progetto imprenditoriale, facendo affidamento sulle risorse
presenti e sulla certezza delle stesse, connesso all’interesse dei terzi creditori, che, a
loro volta, confidano sulla generica garanzia costituita dall’intero patrimonio
sociale, in una prospettiva che si distingue dalla situazione delle società di persone.
Nelle società di capitali l’interesse della società alla conservazione del capitale
sociale prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio (per la
frustrazione alla volontà di dismettere la partecipazone), che non vede inciso, nè
direttamente nè indirettamente, il suo diritto di partecipazione agli utili e il suo
diritto di voto a causa del mutamento del quorum. “Ciò giustifica – anzi impone –
una interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del
socio di società per azioni” (Cass. civ., sez. I, ordinanza 29 marzo 2019 n. 8962).
Rispetto alle società di persone, invece, il legislatore ha stabilito una diversa
disciplina delle ipotesi di recesso ad nutum (previsto dall’art. 2285 c.c. per le
ipotesi di durata della società indeterminata o pari alla vita di un socio), atteso che,
in esse, prevale l’intuitus personae.
Diversamente, nelle società di capitali, nelle quali il recesso ad nutum è
contemplato solo per i casi di società con durata indeterminata, l’estensione alle
società per azioni della disciplina del recesso del socio trova ostacolo in esigenze di
certezza e di tutela, in particolare, dell’interesse dei terzi creditori: mentre i creditori
di una società di persone possono fare affidamento, oltre che sul patrimonio
societario, anche sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili,
viceversa, i creditori di una società di capitali possono contare soltanto sul primo,
che, in caso di recesso di un socio, subisce una corrispondente riduzione (non
compensata dalla responsabilità personale del recedente).
Considerato che l’interesse della società alla conservazione del capitale sociale
prevale sull’eventuale pregiudizio di fatto subito dal socio e che si impone
N. 00026/2021 REG.RIC.
un’interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del
socio di società per azioni (Cass. civ., sez. I, ordinanza 29 marzo 2019 n. 8962) è
esclusa la possibilità di assimilare la società avente quale termine di durata un
termine “particolarmente prolungato” alla società a tempo indeterminato, per la
quale (soltanto) è previsto il recesso ad nutum quale espressione del principio
generale desumibile dall’art. 1379 c.c. in tema di impegni a tempo indeterminato.
“E’ escluso il diritto di recesso “ad nutum” del socio di società per azioni nel caso
in cui lo statuto preveda una prolungata durata della società (nella specie, fino al
2100), non potendo tale ipotesi essere assimilata a quella, prevista dall’art. 2437,
comma 3, c.c., della società costituita per un tempo indeterminato, stante la
necessaria interpretazione restrittiva delle cause che legittimano la fuoriuscita del
socio dalla società” (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4716).
Esclusa la possibilità di ricorrere al recesso ad nutum, non si rinviene il fondamento
normativo del recesso esercitato dal Comune di Randazzo.
11.4. Non solo. L’art. 2437-bis c.c. esclude espressamente la possibilità per il socio
di recedere nella fase di liquidazione della società (e Joniambiente, come già
ricordato, è in liquidazione).
In disparte ogni considerazione sul fatto che è il recesso può portare, in alcuni casi,
alla liquidazione della società (art. 2437-quater comma 6 c.c.), la previsione è posta
a tutela dei terzi che sono venuti in contatto con un soggetto dotato di autonomia
patrimoniale perfetta, così assicurando che siano soddisfatti prima che venga meno
il soggetto (e l’autonomia patrimoniale perfetta).
Tale previsione si apprezza nella prospettiva della liquidazione societaria.
11.5. Principiando dalla disciplina pubblicistica, il d. lgs. n. 175 del 2016 non
prevede una disciplina derogatoria della liquidazione societaria, ricadendo pertanto
la relativa disciplina nella già richiamata previsione di cui all’art. 1 comma 3 d. lgs.
n. 175 del 2016, che rimanda, per tutto quanto non derogato, alle norme sulle
società contenute nel codice civile e alle norme generali di diritto privato.
N. 00026/2021 REG.RIC.
11.6. In termini generalissimi, il tema della soggettività giuridica, specie se
accompagnata da autonomia patrimoniale perfetta, richiede di essere
adeguatamente attenzionato.
Nelle soggettività ad autonomia patrimoniale perfetta, infatti, i creditori possono
contare soltanto sul patrimonio di detta soggettività, che, in caso di recesso di un
socio, subisce una corrispondente riduzione (non compensata dalla responsabilità
personale del recedente).
Ciò in quanto la personalità giuridica piena consente (e impone) di riconoscere una
piena autonomia al soggetto che ne è dotato, anche rispetto agli enti che vi
partecipano.
Anche allorquando la persona giuridica è posta in liquidazione, il patrimonio
dell’ente continua a costituire l’unica garanzia per l’adempimento delle
obbligazioni e, se del caso, per la proficua attivazione della responsabilità
patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.
Ne deriva che lo scioglimento delle persone giuridiche richiede di essere coordinato
con la responsabilità delle medesime, specie se si considera, quanto alle società di
capitali, che esse trovano la propria ragione d’essere nella necessità di reperire
capitali al fine di compiere iniziative economiche, evitando nel contempo di esporre
a responsabilità personale i soggetti che li conferiscono: in tal senso depone
l’origine storica delle medesime, che si suole ricondurre alla Compagnie des Indes
Occidentales (1664), rispetto alla quale fu sentita la necessità di dotarla di
personalità giuridica al fine di addossare solo alla medesima, e non anche ai
finanziatori, il rischio (alto e imprevedibile) del fallimento delle esplorazioni per
mare.
In detta prospettiva tipicamente connessa alla concezione delle società di capitali in
funzione (limitativa) della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c., il
patrimonio sociale riveste, come già illustrato, una particolare rilevanza,
costituendo una garanzia per i soggetti terzi che sono entrati in relazione, per
motivi economici, con la persona giuridica.
N. 00026/2021 REG.RIC.
Il venir meno della persona giuridica deve quindi essere coordinato e
regolamentato in relazione alle obbligazioni già assunte dalla medesima, sulla base
di una disciplina che, dovendo assicurare la tenuta del mercato, presenta aspetti di
imperatività che la accomunano ad altri settori della responsabilità patrimoniale.
La liquidazione della società ha l’obiettivo di estinguere le passività dell’ente
trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci,
l’eventuale residuo attivo, con la conseguenza che durante la liquidazione la società
continua a esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con
sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cass. civ., sez. I, ordinanza
10 dicembre 2020 n. 28193). Invero, con la deliberazione di liquidazione il socio
perde il diritto di conseguire il valore delle azioni, conservando solo, al pari di ogni
altro socio e in conformità con la disciplina della liquidazione, il diritto di
partecipare alla distribuzione del residuo attivo in misura proporzionale alla propria
partecipazione.
Prioritariamente quindi essa è preordinata al pagamento dei debiti sociali, secondo
l’ordine legale di priorità dei corrispondenti crediti sancito nel piano di liquidazione
e il diritto dei soci alla ripartizione dell’attivo sorge solo se, dopo il pagamento dei
debiti, residui un saldo attivo da distribuire.
La disciplina è volta a garantire massima tutela ai creditori, come si rinviene nelle
norme che disciplinano i criteri di svolgimento della liquidazione, e più
precisamente negli artt. 2487 e 2489 c.c. e nell’art. 2491 comma 2 c.c., ove si
prevede espressamente che “i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti
sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non
incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale soddisfazione del creditori
sociali”.
La cogenza della disposizione si evince anche dalla correlata responsabilità
aquiliana del liquidatore nell’ipotesi considerata nell’art. 2495 c.c., parificabile alla
responsabilità verso i terzi o i soci degli amministratori ex art. 2395 c.c., secondo
N. 00026/2021 REG.RIC.
una concezione classica che vede i creditori sociali come soggetti terzi rispetto alla
società (Cass. civ., sez. III, ordinanza 12 giugno 2020 n. 11304).
Del resto, già da tempo, la giurisprudenza ha avuto occasione di sottolineare la
priorità che assume l’interesse dei creditori, stakeholders della società, soprattutto
nella fase in cui essi non possono più fare affidamento nell’operatività dell’impresa
e nella continuità aziendale, a vedere soddisfatti i propri crediti (Cass. civ., sez. III,
ordinanza 15 gennaio 2020 n. 521), tant’è che sin dal 1980 la Suprema Corte ha
sancito la nullità della convenzione fra i soci di una società per azioni,
amministratori e detentori dell’intero pacchetto azionario, la quale sia rivolta a
trasferire i beni sociali, in favore dei soci stessi o di terzi, senza il preventivo
soddisfacimento dei creditori della società, “per violazione delle norme imperative
che tutelano l’integrità del patrimonio della società a garanzia dei creditori”, e che
ne consentono l’assegnazione ai soci solo nel caso e con la procedura dello
scioglimento e messa in liquidazione dell’Ente (Cass., sez. 1, 18 gennaio 1988 n.
326).
In relazione all’attuale normativa, che espressamente tutela la posizione di creditori
in tale delicata fase, la giurisprudenza ha riconosciuto l’obbligo dei liquidatori,
anche di diritto, di rispettare il precetto della par condicio creditorum (Cass. civ.,
sez. III, ordinanza 15 gennaio 2020 n. 521), sebbene detto obbligo non sia
espressamente menzionato nelle norme di settore ma ricavandolo dalle norme
generali che negli artt. 2740 e 2741 regolano il concorso dei creditori e le cause di
prelazione.
Il dovere del liquidatore di procedere a un’ordinata liquidazione del patrimonio
sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il
principio di par condicio creditorum dà il segno degli interessi cui è preordinata la
fase liquidatoria della società, cioè quelli dei terzi che sono entrati in contatto con
la medesima.
La disposizione, contenuta nell’art. 2437-bis c.c., che esclude espressamente la
possibilità del socio di recedere durante la fase di liquidazione della società, si
N. 00026/2021 REG.RIC.
inscrive nella anzidetta prospettiva della tutela degli interessi dei creditori, dal
momento che il recesso del socio comporta una diminuzione del patrimonio sociale,
non compensata dalla responsabilità personale del recedente.
11.7. A fronte di ciò, la coloritura pubblicistica del caso qui controverso non
consente di incidere nel senso di rendere meno stringente la disciplina della fase di
liquidazione, deponendo piuttosto in senso contrario.
Invero, la circostanza che la società interessata dalla liquidazione sia partecipata da
soci pubblici presuppone che la partecipazione dell’ente risponda ad un
corrispondente interesse pubblico del medesimo, rispetto al quale si impone, nella
gestione della fase di transizione dello scioglimento della società, un’attenzione
ancora maggiore (o comunque non inferiore) a quella rivolta alla liquidazione di
società a capitale interamente privato.
Ne deriva che la disciplina contenuta nel d. lgs. n. 175 del 2016, non solo, come
sopra già si è cercato di dimostrare, non apporta prescrizioni specificamente
derogatorie sul punto qui controverso, ma neppure evidenzia un principio generale
teso a incidere sulle regole liquidatorie previste in generale per le società di
capitale.
11.8. Sicché, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come il socio
privato, non può recedere dal contratto di società, con le conseguenze che ciò
comporta sull’effettiva dismissione della partecipazione societaria, e quindi sul
piano di razionalizzazione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016.
A tale ultimo riguardo il Collegio non ignora che l’ordinamento giuridico incentiva
ormai da tempo forme di razionalizzazione della partecipazione degli enti pubblici
in società aventi forme privatistiche.
In particolare sin dalla legge n. 296 del 2006 il legislatore ha tentato di porre un
argine al proliferare delle società pubbliche, laddove non strettamente necessarie
per il perseguimento delle finalità istituzionali dei singoli enti pubblici, a tutela sia
della concorrenza che della sostenibilità della finanza pubblica.
N. 00026/2021 REG.RIC.
Seguendo questo obiettivo sono stati posti dei limiti alla capacità di diritto privato
delle pubbliche amministrazioni, specie a livello locale, accentuando il profilo del
cd. vincolo di scopo, vietando loro di costituire società e di mantenerne la
partecipazione, ove non strettamente necessario.
Attualmente il d. lgs. n. 175 del 2016 è intervenuto in modo organico prevedendo
una prima revisione straordinaria delle società partecipate nell’art. 24, che
costituisce un aggiornamento dell’analogo piano di razionalizzazione richiesto
dall’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014, e una
razionalizzazione periodica nell’art. 20.
L’art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare, nel disciplinare il procedimento
di revisione straordinaria prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia
direttamente che indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di
entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie elencate
nel precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di
cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo
20, comma 2 (esplicitanti i parametri ed i presupposti in base ai quali deliberare i
piani di razionalizzazione periodica), vadano alienate o siano oggetto delle misure
indicate all’articolo 20, comma 1 (“razionalizzazione, fusione o soppressione,
anche mediante messa in liquidazione o cessione”).
L’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive
che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le
amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento,
un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni,
dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2,
un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla “razionalizzazione,
fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Entrambe le suddette norme, che si inquadrano nell’ambito della finalità di
razionalizzare in funzione di una maggiore efficienza e di una riduzione dei costi la
partecipazione di enti pubblici in società di diritto privato, si riferiscono
N. 00026/2021 REG.RIC.
all’alienazione delle partecipazioni o alla “razionalizzazione, fusione o
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione” (art. 20), con una
formulazione che pone come obiettivo finale (non intermedio) la messa in
liquidazione della società, come si evince anche dall’equiparazione di detta
situazione con la stessa cessione.
Sicché non si ricava dal d. lgs. n. 175 del 2016 alcuna sollecitazione ad intervenire
con un atto di recesso a fronte della già avvenuta messa in liquidazione della
società, che anzi costituisce un obiettivo finale della razionalizzazione.
Il legislatore ha quindi compiuto una scelta in tal senso, contemperando le esigenze
di contenimento della spesa pubblica con le prerogative di certezza dei rapporti
giuridici connaturali a un’economia di mercato, che esigono di preservare la
posizione dei contraenti della società (a partecipazione pubblica), così accettando il
rischio che la razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art. 20 del d. lgs. n.
175 del 2016 non determini, senza soluzione di continuità e con immediatezza,
l’effettiva dismissione della partecipazione, se non al termine delle procedure
ordinariamente previste dall’ordinamento.
Del resto, allorquando il legislatore ha ritenuto di intervenire per assicurare un
immediato (e unilaterale) effetto all’atto di dismissione posto in essere dall’ente
locale, lo ha espressamente disposto: è il caso della cessione di partecipazione, per
la quale era previsto ex lege che, decorso un certo termine, “la partecipazione non
alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto” e “entro
dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della
quota del socio cessato” (art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013, poi
abrogato dall’art. 28 comma 1 lett. t del d. lgs. n. 175 del 2016).
In ragione di quanto sopra, durante la fase liquidatoria, il socio pubblico, così come
il socio privato, non può recedere dal contratto di società. Al riguardo si precisa che
detta statuizione non contrasta con la sentenza di questo CGARS n. 530 del 2019,
richiamata da parte appellata, in ragione del fatto che in quell’occasione i motivi di
N. 00026/2021 REG.RIC.
censura, così come formulati, non hanno richiesto una pronuncia espressa in punto
di rapporti fra recesso e liquidazione della società, atteso che la controversia si è
incentrata piuttosto sull’attualità, o meno, della gestione caratteristica del servizio.
Né depone in senso contrario la circostanza che il Comune di Randazzo versi in
stato di dissesto (deliberato con atto del consiglio comunale 30 maggio 2019 n. 17),
il cui bilancio stabilmente riequilibrato (per gli anni 2019/2023, approvato con
decreto 6 luglio 2020 n. 65991 dal Ministero dell’Interno) prevede espressamente di
“rivedere la partecipazione a consorzi, enti e società di cui l’Ente è attualmente
parte, ai fini della riduzione degli oneri eventualmente a carico, alla luce delle
disposizioni di cui all’art. 259, comma 5, del TUOEL che prevede l’eliminazione, o
quantomeno la riduzione, delle spese che non abbiano per fine l’esercizio di servizi
pubblici indispensabili e, quanto ai consorzi di funzioni, osservare il disposto
dell’art. 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni
dalla L. 26 marzo 2010, n. 42”. L’affermazione infatti non contrasta con
l’impostazione sopra riferita in punto di recesso e liquidazione delle società per
azioni, in quanto la revisione delle partecipazioni può avvenire con gli strumenti
sopra richiamati, fra i quali è appunto contemplata la messa in liquidazione, nel
caso già realizzata.
11.9. Neppure si ritiene contrasti con detta impostazione la circostanza che il
Comune di Randazzo sia soggetto alla procedura di dissesto, che non costituisce
causa di estinzione delle obbligazioni assunte dagli enti dissestati e per la quale non
è prevista una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 72 della legge fall. per
i rapporti pendenti (che consente al curatore di intervenire su alcuni rapporti
contrattuali). Piuttosto, in conseguenza della dichiarazione di dissesto, all’organo
straordinario è affidato il compito, sulla base dei “fatti ed atti di gestione
verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di
bilancio riequilibrato”, di accertare il complesso dei debiti dell’ente locale relativi
al periodo indicato e di determinare l’attivo disponibile per procedere al loro
N. 00026/2021 REG.RIC.
pagamento (“al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla
legge”, così l’art. 245 del d. lgs. n. 267/2000).
11.10. Ne deriva che le censure scrutinate sono meritevoli di accoglimento, atteso
che, durante la fase liquidatoria, il socio non può recedere dal contratto di società.
Nondimeno il Collegio rileva che la situazione che il Comune di Randazzo ha
posto alla base della propria decisione di recesso è attenzionabile attraverso gli
strumenti attribuiti dall’ordinamento al socio della società in liquidazione, non
ultima l’azione di responsabilità avverso l’organo liquidatorio e la denuncia di
danni erariali compiuti da soggetti passibili di detta responsabilità, valutando le
ragioni del protrarsi di una fase liquidatoria, che, impedendo alla società, per le
ragioni sopra esposte, di perseguire lo scopo statutario, quindi la gestione del
servizio, rappresenta un mero centro di spesa (e di duplicazione di costi rispetto a
quelli sostenuti dall’attuale gestore), che si giustifica negli stretti limiti delle
necessità della liquidazione (che deve quindi essere perseguita in tempi il più
possibili rapidi).
12. L’accoglimento dei motivi sopra esposti, aventi portata sostanziale, relativa
all’an del recesso, riveste portata assorbente rispetto alle doglianze (espressione di
un mero interesse strumentale) contenute nel terzo motivo, con il quale l’appellante
ha riproposto il motivo del ricorso introduttivo relativo alla mancata previa
comunicazione agli altri soci pubblici, da parte del Comune di Randazzo,
dell’intenzione di recedere da Joniambiente s.p.a. in liquidazione, e nell’ultimo
mezzo, riguardante un asserito vizio di istruttoria e motivazione.
13. Con il quinto motivo l’appellante ha censurato la sentenza per omessa
pronuncia sulla domanda rivolta a fa affermare l’obbligo del Comune di Randazzo
a contribuire alle spese della gestione liquidatori di Joniambiente.
13.1. Il Collegio si pronuncia su detta domanda nei termini che seguono, così
superando il profilo di omessa pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c., che non
costituisce motivo di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (Ad.
N. 00026/2021 REG.RIC.
plen. 30 luglio 2018 n. 10).
La domanda dell’appellante è rivolta a vedere riconosciuto il generale obbligo del
Comune di Randazzo a contribuire alle spese della gestione liquidatoria, in quanto
derivanti dagli asseriti obblighi di contribuzione alle spese della gestione
caratteristica (che non rientrano, peraltro, nell’oggetto della presente controversia,
come già detto sopra).
La domanda (con la quale è stato chiesto a questo Giudice di accertare un generale
“obbligo del Comune di Randazzo a contribuire alle spese della gestione
liquidatori di Joniambiente s.p.a. in liquidazione”) non è meritevole di
accoglimento, nei termini nei quali è stata formulata.
Detto obbligo non può infatti essere affermato in termini generali, come derivante
senza soluzione di continuità dagli obblighi del Comune in relazione al servizio di
gestioni dei rifiuti.
La formulazione del quesito non tiene infatti in debito conto che la disciplina
generale della fase liquidatoria di una società segue i canoni dettati dal codice
civile.
Osta rispetto a un generale accertamento di detto obbligo ( e della derivazione
automatica del medesimo rispetto agli asseriti obblighi di contribuzione rispetto alla
gestione caratteristica) lo statuto normativo delle società per azioni, che si fonda sul
già richiamato principio dell’autonomia patrimoniale e della distinta personalità
giuridica (persino quando è unipersonale) rispetto ai suoi soci e ai suoi
amministratori, ai quali non è riferibile il patrimonio intestato alla compagine (Cass.
civ., sez. I, ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2280).
Durante la liquidazione infatti la società continua a esistere come centro di
imputazione di rapporti giuridici, con la sola sostituzione dello scopo liquidatorio a
quello lucrativo (Cass. civ., sez. I, ordinanza 10 dicembre 2020 n. 28193).
In tale fase permane pertanto l’attualità dell’obbligo dei soci di eseguire i
conferimenti dovuti (e i corrispondenti poteri compulsivi degli organi societari):
“nel caso di scioglimento della società, e anche nell’eventualità di fallimento della
N. 00026/2021 REG.RIC.
medesima, non pare subire alterazioni sostanziali la parte della norma dell’art.
2446 c.c. che concerne l’esecuzione coattiva dell’obbligo di eseguire i conferimenti
dovuti” (Cass. civ., sez. VI – 1, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4956).
Somme aggiuntive (rispetto ai conferimenti) da parte dei soci vengono erogate,
secondo la giurisprudenza, a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la
società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di
versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita
riserva in conto capitale, o altre simili denominazioni (Cass. civ., sez. I, 20 aprile
2020 n. 7919).
In termini generali, quindi, l’ente non ha, in tale fase, l’obbligo di assumere a
carico del proprio bilancio i debiti della società partecipata in liquidazione, qualora
il patrimonio di quest’ultima non sia in grado di soddisfare le pretese creditorie, o
comunque di corrispondere risorse aggiuntive alla società per azioni in
liquidazione.
Del resto, in base all’art. 14 del d. lgs. n. 175 del 2016 le società a partecipazione
pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo,
nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, con conseguente rilevanza
nel senso anzidetto dello stato di insolvenza, inteso quale incapacità del debitore di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Si aggiunge poi che, in seguito alla riforma del diritto societario, solo dopo
l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese,
il socio risponde, a determinate condizioni e entro certi limiti, per le obbligazioni
della società estinta, e non in quanto successore nel rapporto originario tra il
creditore sociale e la società, ma nella qualità di soggetto terzo rispetto al rapporto
tra società e creditore. Sicchè, in presenza di certi presupposti, quali la
cancellazione della società dal registro delle imprese, l’esistenza di debiti e
l’avvenuto incasso di una quota di liquidazione, viene a gravare ex lege l’obbligo di
N. 00026/2021 REG.RIC.
corrispondere, o meglio di restituire, un importo comunque limitato a quanto
percepito a titolo di liquidazione, in violazione della regola, di cui all’art. 2491 c.c.,
in base alla quale i soci hanno diritto alla quota di liquidazione soltanto allorché
tutte le pretese dei creditori sociali risultino precedentemente soddisfatte o siano
state accantonate le somme necessarie per farlo (Cass. civ., sez. V, ordinanza 15
marzo 2021 n. 7168).
In tale contesto non si esclude che l’Ente si faccia carico dei debiti della gestione
liquidatoria e che questi possano discendere, considerando anche la natura delle
singole spese liquidatorie, dagli asseriti obblighi di contribuzione alle spese della
gestione caratteristica, ma è necessario che non vi siano espressi divieti e che
sussistano adeguate giustificazioni (anche normative).
La giurisprudenza contabile richiede, peraltro, che sia evidenziata, attraverso
congrua motivazione, la sussistenza di un interesse pubblico concreto
all’operazione da intraprendere, valutandone la sostenibilità finanziaria e dando
conto delle ragioni di vantaggio e di utilità che ne derivano, considerato il principio
di economicità che connota l’azione amministrativa e l’autonomia patrimoniale
perfetta che caratterizza le società per azioni (Corte conti, sez. controllo
Lombardia, deliberazione 24 aprile 2017 n. 106).
Non si può peraltro escludere che detto interesse possa derivare, considerando la
specifica natura delle spese liquidatorie, negli asseriti obblighi di contribuzione alle
risorse necessarie per svolgere il servizio di gestione dei rifiuti.
In una tale prospettiva le circostanze addotte dall’appellante, tese a richiamare gli
obblighi del Comune in relazione al servizio di gestioni dei rifiuti, quindi alla
gestione caratteristica, e a far discendere da essi la conseguente debenza
generalizzata delle spese liquidatorie, non sono sufficienti (senza che sia necessario
valutarne la fondatezza, peraltro non oggetto del presente giudizio, come già
puntualizzato in precedenza) ad affermare un generale obbligo di partecipazione
alle spese di liquidazione.
In disparte ogni valutazione in ordine al fatto che i costi della gestione caratteristica
N. 00026/2021 REG.RIC.
trovano titolo nello svolgimento del servizio a vantaggio della collettività di
riferimento dell’Ente locale, mentre le spese di liquidazione trovano la propria
ragion d’essere nelle esigenze di liquidazione tipiche della persona giuridica (che
non necessarimente discendono da quela gestione), la questione che si pone è che
non è consentito affermare in generale un omnicomprensivo obbligo del Comune a
corrispondere le spese liquidatorie quale discendente senza soluzione di continuità
dagli asseriti obblighi di contribuzione alla gestione caratteristica, considerati i
sopra richiamati principi di autonomia patrimoniale.
13.2. Ne deriva che non è meritevole di accoglimento la domanda appena sopra
scrutinata, nei termini nei quali è stata formulata.
14. In conclusione l’appello è parzialmente fondato mentre per la restante parte
deve essere respinto, con conseguente accoglimento parziale del ricorso
introduttivo e reiezione per la restante parte in parziale riforma della sentenza
impugnata.
15. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del
doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede
giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe
proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione e per la restante
parte lo respinge, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in
parte il ricorso introduttivo e per la restante parte lo respinge.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal C.G.A.R.S. con sede in Palermo nella camera di consiglio del
giorno 7 luglio 2021, tenutasi da remoto e in modalità telematica e con la
contemporanea e continua presenza dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
N. 00026/2021 REG.RIC.
Roberto Caponigro, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Maria Immordino, Consigliere
Giovanni Ardizzone, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sara Raffaella Molinaro Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
————————–
La società ATO CT1 Joniambiente in liquidazione ha ottenuto in appello una sentenza favorevole nei confronti dell’ex Provincia Regionale di Catania in merito ai costi di gestione delle attività svolte in questi anni. L’importanza della sentenza non è in quanto deve pagare quasi nove milioni di euro (tanto era il costo addebitatogli), quanto l’aver sancito che la ex Provincia – socio per il 10% della Società, nominava un componente nel comitato di gestione e un componente nel collegio sindacale, partecipava alle elezioni degli altri componenti e (cosa molto strana) incassava il 5% di quello che i comuni soci mettevano a ruolo per la TARSU , quasi un milione di euro l’anno – aveva l’obbligo di concorrere alle spese.
Nessuno delle altre 26 ATO della Sicilia, nonostante le nostre pressioni, hanno voluto intraprendere questa via coraggiosa e anche purtroppo la Regione, dopo aver creato tutto questo pasticcio legislativo, si è tirato ignobilmente indietro.
Di seguito la sentenza.
2116046s

Ato Joniambiente, sentenza della Corte d’Appello: l’ex Provincia competente per la pulizia di spiagge e strade
Costituzione della Società per Azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell’Ambito Territoriale Ottimale
( ATO CT1 ).
Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.
Atto stipulato in data 30 dicembre 2002 presso lo studio del notaio Carlo Saggio.
I SOCI:
Provincia Regionale di Catania, Assessore Provinciale Salvatore Cristaldi, delegato dal Presidente Sebastiano Musumeci;
Comune di Bronte, Leanza Salvatore Sindaco;
Comune di Calatabiano, in persona del Sindaco pro tempore Maccarrone Salvatore;
Comune di Castiglione di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Cardile Concetta;
Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore Nucifora Sebastiano;
Comune di Giarre, in persona dell’Assessore Vitale Salvatore, giusta delega del Sindaco pro tempore Toscano Giuseppe;
Comune di Linguaglossa, in persona del sindaco pro tempore Stagnitta Antonino Felice;
Comune di Maletto, in persona del Sindaco pro tempore Parrinello Nunzio;
Comune di Maniace, in persona del Sindaco pro tempore Conti Emilio;
Comune di Mascali, in persona dell’Assessore Maccarrone Alfio, giusta delega del Sindaco pro tempore Carota Silvestro;
Comune di Milo, in persona del Sindaco pro tempore Sessa Paolo;
Comune di Piedimonte Etneo, in persona del Sindaco pro tempore Cavallaro Giuseppe;
Comune di Randazzo, in persona del Sindaco pro tempore Del Campo Ernesto Alfonso;
Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore D’Urso Carmelo;
Comune di Sant’Alfio, in persona del Sindaco pro tempore Patti Leonardo;
Componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dai Soci, per il primo triennio:
Spampinato Mario, presidente
Tomarchio Salvatore, vice presidente
Di Maria Orazio, consigliere
Pavone Giovanni, consigliere
Rubbino Francesco, consigliere
Spartà Salvatore, consigliere
Vasta Gianni, consigliere
Componenti il Collegio Sindacale, nominati dai Soci, per il primo triennio:
Bonaccorsi Roberto, presidente; Barbagallo Salvatore, sindaco effettivo; Caprino Campana Gaetano, sindaco effettivo Scaglione Antonio, sindaco supplente; Caruso Paolo, sindaco supplente.
Contenzioso con il Comune Socio di Randazzo.
Nel 2016 a seguito di reiterate critiche contro la Società Joniambiente in seno al Consiglio Comunale al fine di poter chiarire la situazione economica e gestionale tra la Società e il Comune Socio Randazzo ( Gli altri Comuni Soci, invece, ci convocavano per un Incontro Istituzionale e in quella sede veniva chiarito l’eventuale contenzioso ) fu inviato il documento che segue:
 Loading...
Loading...
Come per incanto le critiche sparirono. Ci siamo augurati che da parte del Governo della Città si fosse finalmente capito che l’ATO era stata una risorsa e non una negatività. (Certamente cose perfette è difficile che ce ne siano ! ).
Il 20 novembre 2020, a seguito di una sentenza del tribunale di Ct che permetteva al comune di Randazzo di poter uscire dall’ATO e conseguentemente di non più pagare le quote relative alle spese per la liquidazione per il prossimo futuro ( per il passato il Comune resta sempre debitore per quasi 2 milioni di euro), Il sindaco Francesco Sgroi posta sulla sua pagina F.B. :
 
Sconcertati per questo annuncio abbiamo inviato una lettera al Sindaco, agli Assessori e all’intero Consiglio Comunale affinchè fosse rettificato quanto dichiarato perchè palesemente falso e oltremodo ingiurioso per la Società Joniambiente e i suoi Amministratori ( il Collegio dei Liquidatori, il Collegio Sindacale, ed il Revisore dei Conti).
 Loading...
Loading...
La lettera, in breve sintesi, afferma quanto segue:
– Il Comune dal 30 settembre 2013 ad oggi, per le spese della gestione della liquidazione, ha versato alla Società Joniambiente 0 (zero) euro.
– Il 5 dicembre 2014 il Comune ha versato alla Società euro 627.390,10 per il Servizio di Igiene Pubblico effettuato dal 1 febbraio 2006 al 30 settembre 2013. Restano ancora da pagare quasi 2 (due) milioni di euro.
– Per la complessa gestione della Liquidazione ( si gestisce 20 milioni di massa passiva e altrettanti 20 milioni di massa attiva) la quota che il Comune dovrebbe pagare annualmente ai due liquidatori e di euro 2.400,00 (cento euro al mese).
– Dal momento che il Comune non ha versato un euro e quindi avendo la disponibilità di queste somme è lecito chiedersi: quali servizi ha dato ai Cittadini Randazzesi !!??
– La Società Joniambiente nell’espletamento del servizio ha fatto risparmiare al Comune di Randazzo più di 500 mila euro.
Attesi inutilmente oltre 2 mesi e non avendo ricevuto alcuna risposta e costatando che il post non è stato rimosso, siamo stati costretti, nostro malgrado, ad adire per le vie legali.
Una nota personale: da oltre 50 anni espleto attività pubblica con incarichi politici e amministrativi e non ho mai querelato nessuno.
Oggi sono stato costretto a farlo in quanto non si può permettere che il massimo rappresentante della nostra Città faccia dichiarazione pubbliche palesemente false ed ingiuriose nei confronti di una società pubblica e dei suoi amministratori dove il Comune di Randazzo è socio.
STORIA DELLE ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ JONIAMBIENTE SPA ATO CT1
ANNO 2006
L’anno 2006 è stato per la Società quello dell’inizio del servizio e come tale è stato denso di attività che sono state caratterizzate da una serie di vicende importanti per la vita di tutti i Comuni soci.
Il primo elemento importante è stato il passaggio del personale che prestava servizio nelle precedenti gestioni comunali. Con il 1° di febbraio è partito il servizio e la fase successiva di avvio è stata densa di impegni per la Società e per i Comuni stessi, tutti protesi nello sforzo di ridurre al minimo i disagi di una gestione che doveva mettere assieme diversi cantieri di lavoro e diverse abitudini nelle varie realtà del nostro Ambito territoriale
Il cosiddetto “Piano Nido” (una puntuale, minuziosa analisi del servizio, sulla scorta dei primi mesi di lavoro, completa di direttive ed indicazioni per l’espletamento dei vari servizi), ha ottenuto risultati significativi che hanno quasi azzerato i disservizi.
Sono stati curati i vari iter amministrativi dei finanziamenti ottenuti per il completamento delle infrastrutture necessarie all’espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ( CCR nei vari Comuni e finanziamenti per l’acquisto di attrezzature necessarie).
Una serie di azioni importanti sono state intraprese al fine di fornire all’esterno ( agli utenti ) le notizie necessarie per un corretto utilizzo di tutti i servizi offerti e al fine di accrescere all’interno, il “know-how” della Società;
In ottemperanza a quanto previsto dal piano di comunicazione si è proceduto alla realizzazione del logo societario. La formula scelta è stata quella del concorso d’idee.
In esecuzione a quanto previsto dal piano di comunicazione sono stati realizzatati n. 10.000 ecocalendari su carta riciclata con tutte le informazioni necessarie agli utenti per quanto attiene la raccolta differenziata.
E’ stato pubblicato il sito internet societario con il seguente nome di dominio: www.atoct1joniambiente.it.
Si è proceduto a stipulare un’apposita convenzione di Stage con l’Università di Catania. Tale convenzione ha previsto la possibilità per laureandi e laureati di svolgere attività di tirocinio formativo presso le strutture della società.
ANNO 2007
Il 2007 ha rappresentato per la società il II° anno di attività nel settore ed è stato caratterizzato dal consolidamento dell’esperienza acquisita durante il I° anno.
Tale esperienza ci ha permesso di ridurre gli errori dovuti alla inevitabile inesperienza ed alla complessità della gestione di un appalto in 14 Comuni con tipologie diverse sia dal punto di vista architettonico, che urbanistico, che orografico (mare – montagna) con peculiarità proprie e specifiche che vanno dalla vocazione agricolo-naturalistica a quella commerciale-turistica.
Ognuna di queste realtà si è tradotta in richieste di servizio personalizzate che hanno trovato pronta risposta in tutti quei comuni che avevano, ed hanno, personale già abituato ed educato alle abitudini ed alle aspettative della propria comunità.
A complicare fin dall’inizio dell’anno la già difficile situazione, è intervenuta una legge regionale, la 2\07, che ha previsto la riduzione degli ATO essenzialmente su base provinciale ed ha lasciato in un clima di incertezza e di confusione tutti gli ambiti territoriali, chiamati ad una serie di adempimenti e di modifiche, non meglio specificate, che dovevano portare ad una razionalizzazione della spesa con varie misure che poi, sostanzialmente, per noi si sono tradotte nella riduzione del numero dei componenti del CdA.
A seguito dell’annullamento della gara per l’affidamento dei servizi di igiene urbana nell’ATO-CT1 svoltasi nel novembre 2005, con la collaborazione degli altri settori, e senza l’ausilio di collaborazioni esterne, si è proceduto alla redazione del nuovo Progetto dei Servizi di igiene ambientale,con relativo Bando di Gara e Capitolato Speciale di Appalto, da sottoporre all’esame del Cd.A. della Società.
In particolare si è proceduto all’immane lavoro di censimento di tutte le strade, piazze e spazi pubblici di tutti i centri urbani dell’ambito territoriale CT1, alla puntuale analisi della produttività oraria di uomini e mezzi e allo studio di modalità e percorsi per ottimizzare il servizio. Particolare attenzione è stata posta alla redazione del C.S.A. per evitare difformi interpretazioni e future controversie.
E’ stata quasi completata la collocazione dei contenitori e dei cestini gettacarta.
Nel periodo estivo sono stati collocati contenitori per la raccolta differenziata presso i lidi.
E’ stato concordato con la ditta Aimeri il programma definitivo di raccolta differenziata e raccolta beni durevoli ed ingombranti in ogni singolo Comune.
Tale programma è stato propedeutico per la stesura del pieghevole di informazione inviato nel mese di dicembre ai cittadini.
Per ogni Comune sono stati predisposti gli elenchi di tutte le attività non domestiche esistenti sul territorio. Ciò al fine di poter predisporre dei “giri di raccolta” per quanto attiene la raccolta differenziata presso tali attività, attraverso un progetto specifico finalizzato all’incremento delle percentuali di raccolta differenziata.
Dalla fine del mese di Novembre è attivo il numero verde di Joniambiente 800 911 303.
Un servizio utile per i cittadini e anche per l’Ufficio che, giornalmente, prima dell’attivazione del citato servizio, doveva con il poco personale a disposizione rispondere alle telefonate, registrare le prenotazioni e le segnalazioni ed inviarle alla ditta Aimeri.
L’impegno, però, non è finito, in quanto ogni giorno l’Ufficio provvede a scaricare le “e-mail” inviate dal numero verde e controllare che i report sull’espletamento del servizio, trasmessi dalla ditta Aimeri, corrispondano con quelli trasmessi dal numero verde.
Inoltre l’ufficio provvede a verificare che i report mensili di riepilogo siano corretti e corrispondano al servizio realmente espletato dalla ditta Aimeri.
Un momento molto importante, soprattutto in un ottica futura è la sensibilizzazione nelle scuole.
Il progetto “Scuola-isola ecologica” ha coinvolto nel corso dell’anno scolastico 2006-2007 circa 3.000 alunni dei Comuni di Bronte, Fiumefreddo, Giarre, Maletto, Maniace, Mascali, Piedimonte Etneo, Randazzo. Nell’anno scolastico 2007-2008 gli incontri sono continuati presso i Comuni di Calatabiano (novembre), Riposto (dicembre).
Infine, possiamo osservare che le percentuali di raccolta sono notevolmente aumentate (vedi grafico n. 1), soprattutto quelle relative alla frazione secca (vedi grafico n. 2).
A tal proposito si evidenzia che i dati nel 2007 ci hanno consentito di essere inclusi tra i sei ATO più virtuosi della Sicilia da parte di COMIECO.
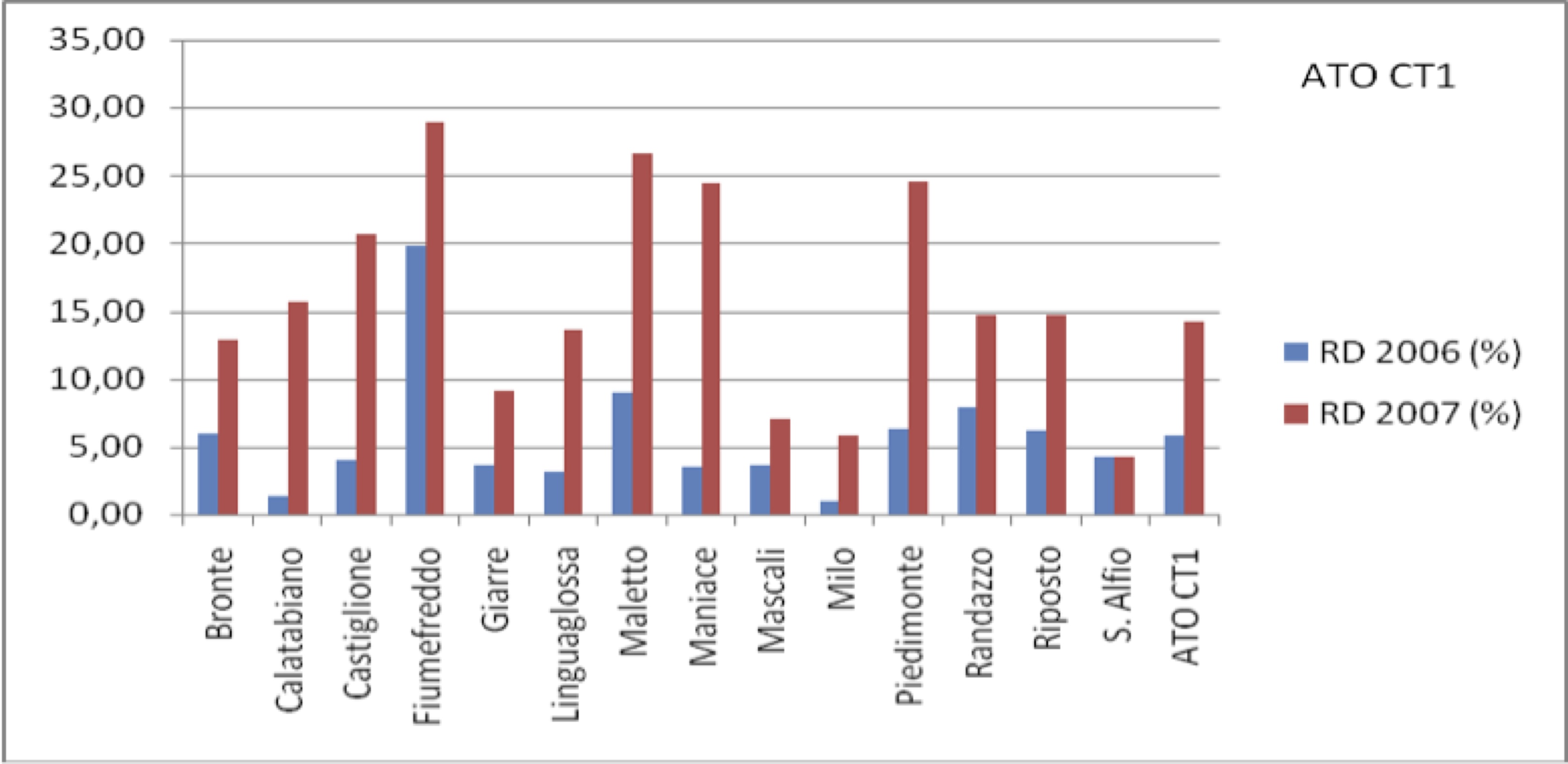
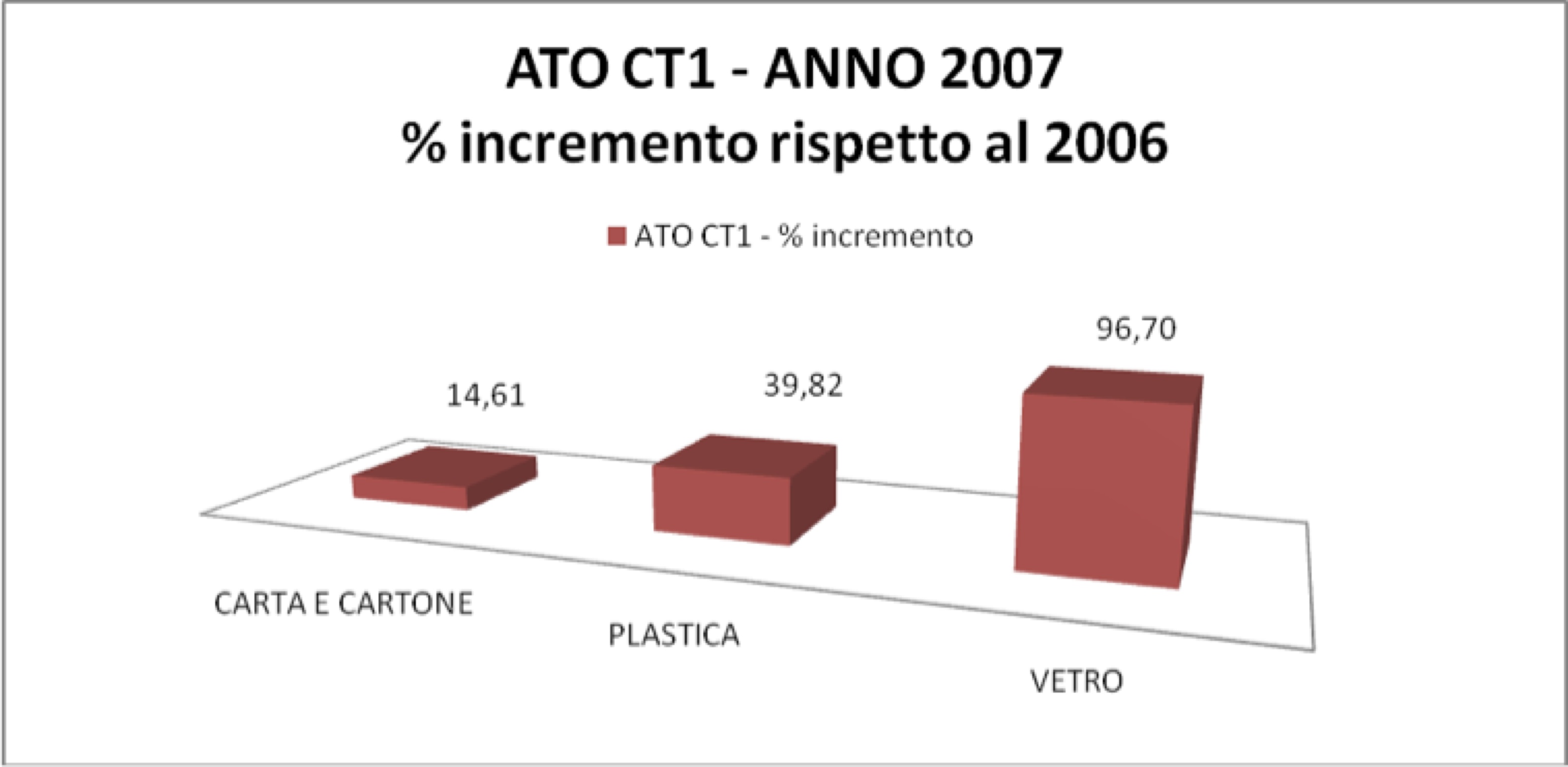
Nel corso del 2007 sono state espletate tutte le procedure per l’affidamento dei lavori di costruzione dei C.C.R. di Maletto e Bronte, si è conclusa con il collaudo finale la fornitura per l’attrezzature per la raccolta differenziata, sono stati rimossi gli ostacoli che impedivano la conclusione dei lavori del C.C.R. di Riposto e si è collaborato con il Comune di Bronte per l’individuazione di un’area per l’insediamento di un impianto per il trattamento della frazione secca e di un area per la costruzione di una discarica comprensoriale per i rifiuti indifferenziati.
Anche il 2008 per il settore degli A.T.O. rifiuti si è assistito ad una serie di iniziative parlamentari e di disegni di legge tendenti a riformare il sistema degli A.T.O. in Sicilia, senza peraltro giungere ad alcuna risoluzione definitiva. Tale atmosfera di precarietà continua ci ha fatto operare con ancora più prudenza e con l’obiettivo di non gravare ulteriormente le casse dei Comuni di alcuna iniziativa che non fosse necessaria e dettata da obblighi istituzionali. Nonostante ciò, il nostro A.T.O. è sicuramente da annoverare tra gli A.T.O. virtuosi della nostra Regione, anche se le modifiche regolamentari dell’Agenzia Regionale, che hanno cambiato in corsa le regole per la classificazione degli A.T.O. virtuosi, ci hanno collocato solo nella fascia dei papabili.
L’iniziativa più importante che i nostri uffici hanno portato avanti, seppur nel clima di incertezza sopra accennato, è la predisposizione di un C.S.A. che mira a consolidare gli standards di servizio fino adesso raggiunti e a non disperdere e a non vanificare il livello di cultura ambientale già raggiunto dalle nostre popolazioni.
Sin dalla sua costituzione, per la Joniambiente S.p.A, le attività di comunicazione hanno assunto una indiscussa centralità, riscontrabile direttamente nel territorio dei 14 comuni dell’A.T.O. CT 1.
Giova ricordare alcune iniziative degli anni precedenti a beneficio degli Amministratori che si sono insediati a seguito delle elezioni del 2008.
Già a partire dal 2006, infatti, sono stati attivati, attraverso l’analisi del contesto socio-economico, processi di verifica tesi alla costruzione di un rapporto diretto e trasparente con l’utenza, e a seguire tutta una serie di interventi quali:
- la divulgazione dei numeri utili della società e l’avvio del servizio informazioni;
- gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole;
- la distribuzione capillare di volantini tesi ad incrementare la raccolta differenziata realizzati ad hoc per ciascuno dei 14 comuni soci;
- la collaborazione con le associazioni di volontariato;
- la realizzazione dei primi gadget (es. EcoCalendario).
A partire dal 2007 si aggiungono, alle precedenti, nuove azioni di sensibilizzazione, in particolare:
- l’attivazione del numero verde e del sito internet;
- l’indagine telefonica di customer satisfaction;
- Il recapito (tramite il servizio di Posta Target) a ben 400 utenze di un depliant sulla raccolta differenziata contenente tutte le istruzioni per differenziare i rifiuti nonché i giorni e gli orari del servizio raccolta porta a porta parallelamente alla distribuzione di un pieghevole analogo rivolto, invece, alle attività produttive.
L’ anno 2008, però, ha registrato una significativa intensificazione delle attività di comunicazione, dal momento che numerose azioni sono scaturite dal lancio di tre importanti iniziative cha hanno trovano ampia pubblicizzazione tramite diversi mass media :
- la I Edizione del Concorso Ricicla in Arte;
- La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate”;
- Il progetto “EcoNatale 2008”.
la I Edizione del Concorso “Ricicla in Arte” si è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale CT1 registrando circa 1.800 adesioni. Il successo dell’iniziativa nel sensibilizzare le nuove generazioni e le famiglie intervenute è stato sicuramente sancito dal record di presenze registrate in occasione delle Giornate Ecologiche, tenutesi nelle piazze dei diversi comuni partecipanti, nonché in occasione della Festa dell’Ambiente che ha visto riuniti a Giarre gli alunni di tutti gli Istituti partecipanti con genitori al seguito per premiare e festeggiare i vincitori del concorso;
La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate” ha promosso la raccolta differenziata sulle spiagge dei comuni etnei dell’A.T.O. CT 1 sensibilizzando e coinvolgendo bagnanti e turisti attraverso una serie di interventi mirati quali: l’installazione di “EcoPoint” (appositi contenitori per la raccolta differenziata) nei lidi, sul lungomare e nelle spiagge libere; la collocazione di n. 5 Infopoint sul lungo mare Riposto – Calatabiano per la distribuzione di sacchetti, gadget e materiale divulgativo (Eco Ventagli e Riciclamente), e l’organizzazione dell’EcoAquilonata, evento che, avendo registrato un considerevole numero di presenze, ha consentito di raggiungere in un’unica soluzione target differenti. Nell’ambito della medesima iniziativa vanno annoverate, inoltre, la presenza di stand informativi in occasione di sagre e manifestazioni (tenutesi nei comuni di Bronte, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Maniace, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo e Riposto) e le manifestazioni itineranti “ArteAmbiente” tenuti da artigiani specializzati sul riutilizzo dei materiali;
L’EcoNatale 2008, progetto dai profondi significati pedagogici e didattici in tema di cultura ambientale, ha avuto come principali destinatari circa 10.000 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’Ambito Territoriale Ottimale CT1, attraverso i quali il le famiglie hanno ricevuto il Kit natalizio, appositamente realizzato da Joniambiente, contenente gadget e materiale divulgativo (Eco Calendario ’09, Depliant sulla RD dei rifiuti umidi organici, l’album da colorare EcoColora, Il Grande Gioco del Riciclo…).
Nel corso della programmazione ordinaria dell’anno 2008, indipendentemente dalle suddette iniziative, meritano inoltre di esser e ricordate :
- la stipula della convenzione (tra le prime su l’intero territorio nazionale) per la raccolta differenziata dei contenitori per bevande in TetraPak;
- la presentazione all’A.R.R.A. del nuovo Piano di Comunicazione per il biennio 2009-2010 (con la richiesta di un finanziamento pari a circa € 1.900.000,00) all’interno del quale è stato riservato un posto di assoluto rilievo a tutti gli interventi destinati a: incrementare le percentuali di RD, ridurre i rifiuti alla fonte, mettere a punto sistemi per il calcolo dei conferimenti nella prospettiva di offrire agevolazioni fiscali ai cittadini virtuosi;
- la richiesta di un contributo all’A.R.R.A. da destinare alla formazione del personale degli Enti locali operanti nel settore ambientale nonché ad interventi di sensibilizzazione ambientale nelle scuole.
L’anno 2008 ha visto l’Ing. Giulio Nido responsabile del Settore Tecnico della Società particolarmente impegnato nella progettazione e gestione dei LL.PP..
Nel corso dell’anno sono stati redatti e presentati all’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque per acquisirne il finanziamento i seguenti progetti:
- Costruzione di un impianto di selezione e pressatura nella contrada Margiogrande presso l’ex discarica dei R.S.U. – Comue di Bronte;
- Importo: €. 3.500.000,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” in collaborazione con i tecnici del Comune di Bronte;
- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’area dell’ex depuratore Comune di Milo;
- Importo: € 237.634,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;
- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti da realizzarsi nel Comune di Piedimonte Etneo;
- Importo: €. 546.000,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” in collaborazione con i tecnici del Comune di Bronte;
- Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento RAEE in Randazzo;
- Importo: € 2.300.000,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;
- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da ubicarsi in via Etna – Comune di S. Alfio;
- Importo: € 501.882,05;
- Progettazione: Tecnici del Comune di S. Alfio assistiti dal settore tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;
- Progetto di adeguamento delle isole ecologiche nell’A.T.O.CT1 (Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Maletto, Mascali, Piedimonte Etneo, S. Alfio);
- Importo: € 99.060,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.”;
- Progetto per acquisto attrezzature raccolta differenziata frazione umida;
- Importo: € 941.840,00;
- Progettazione: Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A;
- Progetto per acquisto attrezzature informatizzazione centri comunali di raccolta;
- Importo: € 538.142,00;
- Progettazione: Germanà Antonino – Funzionario della Società “Joniambiente S.p.A;
In totale sono stati presentati progetti per un importo di € 8.664.558,05, tutti redatti dal Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” e/o da tecnici dei Comuni Soci.
Questa scelta ha permesso a questa Società di presentare un gran numero di proposte a costo zero.
Infatti l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ammette al finanziamento le competenze tecniche nella misura massima del 1,5% dell’importo delle opere, pari a quella che sarà corrisposta a finanziamento ottenuto ai tecnici che si sono occupati della progettazione e che cureranno la direzione dei lavori.
Nel caso in cui si fosse optato per l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a tecnici esterni, le spese per le competenze tecniche sarebbero state di gran lunga superiori, in gran parte a carico di questa Società e da liquidare all’approvazione dei progetti anche in caso di mancato finanziamento.
Oltre alle progettazioni di cui sopra, nel corso dell’anno sono stati svolti diversi incontri con gli uffici tecnici dei Comuni Soci per illustrare il Capitolato d’appalto e tutti gli atti predisposti per il nuovo affidamento dei servizi di igiene urbana nel territorio di competenza dell’A.T.O. CT1. A seguito di detti incontri, per venire incontro alle esigenze esposti dai vari interlocutori, si è provveduto a ben tre rielaborazioni del Capitolato d’appalto fino a giungere alla stesura definitiva sulla quale gli Enti soci non hanno formulato alcuna osservazione.
Sono state inoltre espletate le seguenti gare per la realizzazione di Centri comunali di raccolta e fornitura di attrezzature:
- Costruzione di un centro comunale di raccolta nella c.da SS. Cristo – Area Artigianale – Comune di Bronte;
- Fornitura di attrezzature nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di un complesso di attrezzature per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura di autoveicoli per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura e posa in opera di pesa a ponte per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 autocarro nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di attrezzature di n. 2 cassoni scarrabili nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 nastro trasportatore nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 pressa idraulica continua nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di automezzi e attrezzature per il centro comunale di raccolta di c.da SS. Cristo – Zona Artigianale- Comune di Bronte;
La raccolta differenziata – Responsabile il Dirigente Antonino Germanà – nel 2008 ha conosciuto un consolidamento significativo che ci ha portato a poterci candidare tra i Comuni virtuosi dell’isola e ci ha consentito di riconfermare la “Bandiera Blu” per uno dei nostri comuni soci candidati a questo prestigioso riconoscimento.
Se si analizzano le tipologie di rifiuti “più importanti” della raccolta differenziata (carta e cartone, plastica e vetro), possiamo notare, anche qui, dei risultati in costante crescita.
Se raffrontiamo i risultati a partire dall’anno 2005 (gestione dei Comuni) al 2008, possiamo notare significativi incrementi per tutte le tipologie di rifiuto. (vedi grafico)
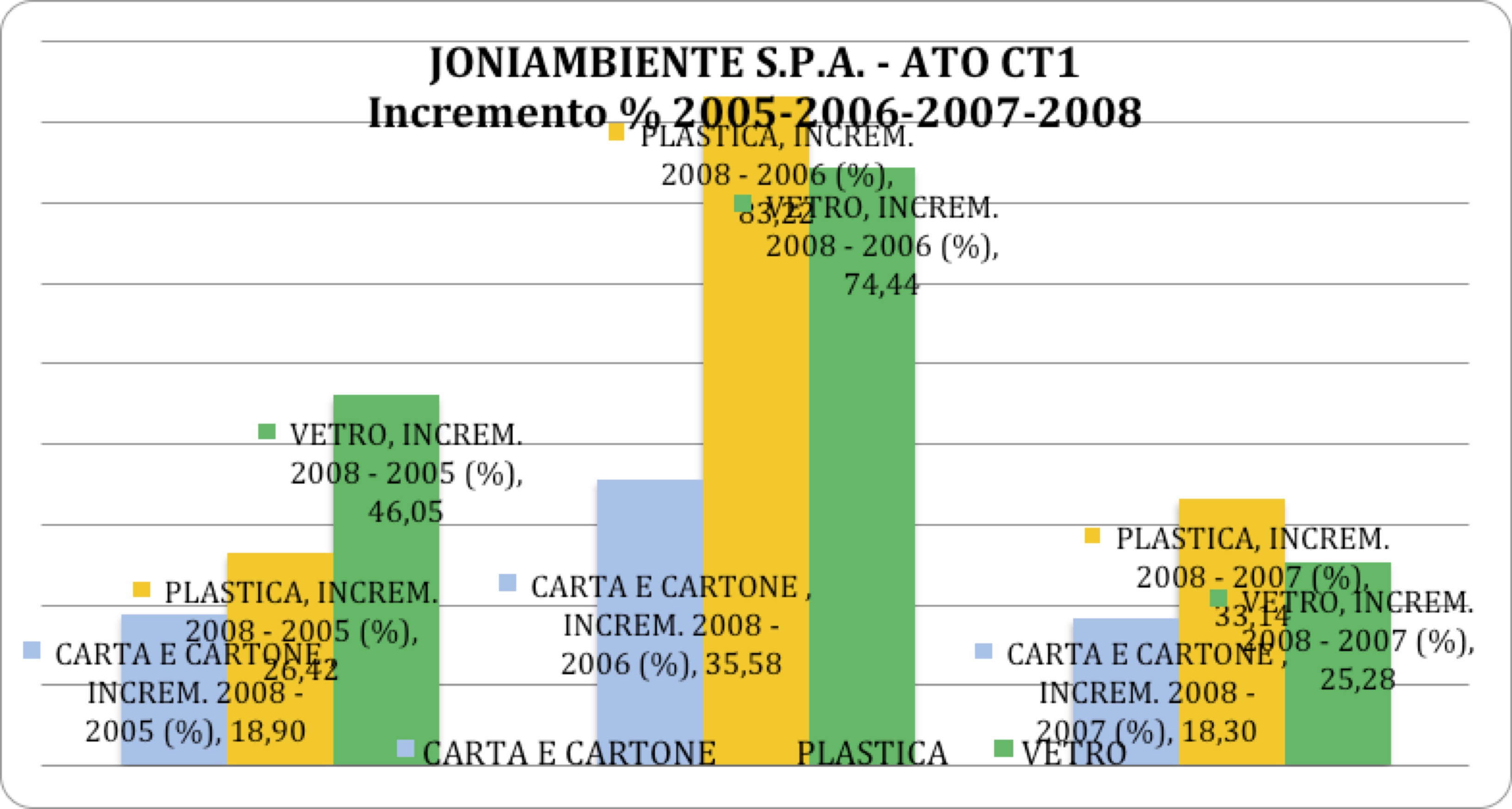
In termini quantitativi nel 2008 sono stati raccolti oltre 1.200 tonnellate in più di imballaggi rispetto al primo anno del servizio da parte di Joniambiente.
Questi risultati hanno portato anche un riconoscimento per 7 Comuni dal nostro A.T.O. che sono entrati a far parte del Club “Comuni Virtuosi”, iniziativa promossa da COMIECO.
Ma i rifiuti raccolti in maniera differenziata non sono stati sono quelli sopracitati.
Infatti nell’anno 2008 sono stati avviati a recupero rifiuti appartenenti a ben 20 codici CER, mentre in passato venivano avviati a recupero mediamente solo 7 codici CER.
Un’azione importante è stata avviata nel recupero dei R.A.E.E. (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche) sia per ottemperare a quanto previsto dal D.L.vo n. 151/2005, ma anche per evitare il loro abbandono indiscriminato sul territorio.
Nel mese di dicembre 2008, inoltre, sono state attivate le procedure per adempiere a quanto previsto dal D.L.vo n. 36/2003 e sue modifiche ed integrazioni (riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili).
E’ doveroso a conclusione dell’anno un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con la Società, dai nostri tre Dirigenti che da soli hanno guidato le linee programmatiche della Società, ai loro collaboratori che li hanno sostenuti materialmente e quotidianamente nelle varie attività.
Sono riusciti a dimostrare brillantemente che in pochi si può gestire una società con coscienza e semplicemente facendo il proprio dovere quotidiano.
Un ringraziamento particolare al Collegio dei Sindaci della Società che ci hanno controllato ma anche guidato e sostenuto nelle nostre decisioni più complicate evitando spesso di spingerci nel terreno dei facili entusiasmi dettati dalla buona volontà e dalla voglia di fare.
Infine sento il dovere di ringraziare anche la ditta che gestisce il servizio che, seppur tra mille incomprensioni e contrasti anche quotidiani, ci ha permesso di garantire una continuità di gestione nonostante alcuni dei nostri Soci non abbiano versato regolarmente le quote di partecipazione per evidenti difficoltà interne, a volte anche storiche.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 30.333,00 (€ 44.868,00 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
| Descrizione |
Costo storico es. pr. |
Rivalutaz. es. pr. |
Svalutaz. es. pr. |
F.do ammort. es. pr. |
Valore iniziale |
| Costi di impianto e di ampliamento |
11.700 |
0 |
0 |
11.700 |
0 |
| Piano Comunicazione “EcoNatale” |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totali |
11.700 |
0 |
0 |
11.700 |
0 |
| Descrizione |
Acquisiz. / Capitalizz. |
Alienazioni |
Riclassif.(a)/da altre voci |
Svalut./Ripr. valore dell’es. |
Rivalutazioni dell’esercizio |
| Costi di impianto e di ampliamento |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Piano Comunicazione “EcoNatale” |
30.333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totali |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Descrizione |
Ammortamenti |
Totale rivalutaz. es. corr. |
Totale svalutaz. es. corr. |
F.do ammort. es. corr. |
Valore finale |
| Costi di impianto e di ampliamento |
0 |
0 |
0 |
11.700 |
0 |
| Piano Comunicazione “EcoNatale” |
0 |
0 |
0 |
0 |
30.333 |
| Totali |
0 |
0 |
0 |
11.700 |
30.333 |
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.641.739,00 (€ 911.442,00 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
| Descrizione |
Costo storico es. pr. |
Rivalutaz. es. pr. |
Svalutaz. es. pr. |
F.do ammort. es. pr. |
Valore iniziale |
| Altri beni |
6.430 |
0 |
0 |
680 |
5.750 |
| C.c.r. ed attrezzatura da Finanz.Reg.le |
1.002.372 |
0 |
0 |
96.680 |
905.692 |
| Totali |
1.008.802 |
0 |
0 |
97.360 |
911.442 |
| Descrizione |
Acquisiz. / Capitalizz. |
Alienazioni |
Riclassif.(a)/da altre voci |
Svalut./Ripr. valore dell’es. |
Rivalutazioni dell’esercizio |
| Altri beni |
87.026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| C.c.r. ed attrezzatura da Finanz.Reg.le |
653.961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totali |
740.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Descrizione |
Ammortamenti |
Totale rivalutaz. es. corr. |
Totale svalutaz. es. corr. |
F.do ammort. es. corr. |
Valore finale |
| Altri beni |
10.690 |
0 |
0 |
11.370 |
82.086 |
| C.c.r. ed attrezzatura da Finanz.Reg.le |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.559.653 |
| Totali |
10.690 |
0 |
0 |
11.370 |
1.641.739 |
| Evoluzione prevedibile della gestione |
Come accennato in premessa il sistema degli A.T.O. in Sicilia è oggetto di una profonda rielaborazione legislativa che porterà a soluzioni diverse dall’attuale sui cui risultati nessuno può oggi pronunciarsi.
La preoccupazione principale, che gli amministratori pubblici del nostro Ambito dovrebbero avere per il futuro, sarà quella di non disperdere il patrimonio culturale di rispetto verso l’ambiente che si è creato nei nostri concittadini e che ha visto una risposta massiccia e convinta alle nostre iniziative nelle scuole e durante l’estate lungo le nostre spiagge.
Fondamentale per le nostre popolazioni sarà il mantenimento dei confini del nostro ambito territoriale per continuare a condividere la cultura e le abitudini di un servizio che sta crescendo di anno in anno.
Anche il 2009 per il settore degli ATO rifiuti si è assistito ad una serie di iniziative parlamentari e di disegni di legge tendenti a riformare il sistema degli ATO in Sicilia, senza peraltro giungere ad alcuna risoluzione definitiva. Tale atmosfera di precarietà continua ci ha fatto operare con ancora più prudenza e con l’obiettivo di non gravare ulteriormente le casse dei Comuni di alcuna iniziativa che non fosse necessaria e dettata da obblighi istituzionali.
L’iniziativa più importante che i nostri uffici hanno portato avanti, seppur nel clima di incertezza sopra accennato, è la predisposizione di tutti gli atti necessari per bandire la nuova gara per l’affidamento del servizio igiene urbana nell’ATO-CT1. Il nuovo CSA posto a base della gara, pur nel rispetto delle direttive ricevute dall’Assemblea dei Soci di contenere i costi, ha previsto modalità innovative di svolgimento dei servizi. La raccolta dei rifiuti in tutti i centri urbani passa al sistema integrato porta a porta con l’eliminazione dei cassonetti stradali. Secondo gli studi effettuati dai nostri uffici, il nuovo sistema di raccolta, farà aumentare decisamente le percentuali di raccolta differenziata.
Sin dalla sua costituzione, per la Joniambiente S.p.A, le attività di comunicazione hanno assunto una indiscussa centralità, riscontrabile direttamente nel territorio dei 14 Comuni con la Provincia Regionale di Catania dell’A.T.O. CT 1.
Giova ricordare alcune iniziative svolte nel corso del 2009:
- La continuità nella divulgazione dei numeri utili della società , nel servizio informazioni e segnalazioni fornito dal Numero Verde, nell’indagine telefonica di customer satisfactione e nell’aggiornamento del sito internet;
- La distribuzione capillare di materiale divulgativo sulla raccolta differenziata alle utenze domestiche (ad hoc per ciascuno dei 14 comuni soci);
- La realizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle scuole, di incontri pubblici e di manifestazioni di sensibilizzazione (EcoPiazze, Festa dell’Ambiente, EcoAquilonata);
- L’affissione programmata di manifesti informativi in tutti gli Enti soci;
- La collaborazione con le associazioni di volontariato;
- La realizzazione e la distribuzione di gadget (es. EcoCalendario, Ecopen, varie edizioni della rivista Riciclamente).
- Il ricorso ad Acquisti Verdi mediante la scelta di prodotti e servizi ecosostenibili.
L’ anno 2009 , inoltre, ha registrato sia la riproposizione di campagne di sensibilizzazione già avviate sia il lancio di nuove.
Tra le prime ricordiamo:
- La II Edizione del Concorso Ricicla in Arte;
- La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate”;
Tra le seconde:
- La campagna di sensibilizzazione “Il Magico Mondo di Verino il Burattino”;
- Il progetto “EcoPresepe 2009”.
La II Edizione del Concorso Ricicla in Arte si è rivolta alle scuole primarie e secondarie di 1° grado ricadenti nell’ambito territoriale ottimale Ct 1 registrando circa 3000 adesioni. Il successo dell’iniziativa nel è stato sicuramente sancito dal record di presenze registrate in occasione delle Ecopiazze e della Festa dell’Ambiente che ha visto riuniti alunni, famiglie e comuni cittadini.
La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate” ha promosso la raccolta differenziata sulle spiagge dei comuni etnei dell’A.T.O. CT 1 attraverso una serie di interventi mirati quali: l’installazione di EcoPoint nei lidi; la collocazione di n. 3 Infopoint sul lungo mare Riposto- Calatabiano per la distribuzione di sacchetti, gadget e materiale divulgativo (Eco Ventagli e Riciclamente) e l’organizzazione dell’EcoAquilonata. Nell’ambito della medesima iniziativa vanno annoverate, inoltre, la presenza di stand informativi in occasione di sagre e manifestazioni (tenutesi nei comuni di Bronte e Randazzo) e il laboratorio creativo sul riutilizzo dei materiali di scarto tenuto da artigiani specializzati.
La partecipazione al tour di sensibilizzazione itinerante “Il Magico Mondo di Verino” promossa da Corepla ha fatto tappa a Fiumefreddo di Sicilia il 16 giungo coinvolgendo i più piccoli in attività di sensibilizzazione al riciclo delle bottiglie in PET.
L’EcoPresepe 2009, ha avuto come principali destinatari circa 10.000 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie dell’ambito territoriale ottimale CT 1, impegnati nella realizzazione di presepi con materiali di scarto. Dall’iniziativa sono risultate vere e proprie opere d’arte frutto della straordinaria creatività dei più piccoli. Contestualmente sono stati distribuiti agli Istituti scolastici, agli Enti soci, alle utenze non domestiche e a tutti i richiedenti gli Ecocalendari 2010.
L’anno 2009 ha visto il Settore Tecnico della Società particolarmente impegnato nella realizzazione e gestione di LL.PP..
Nel corso dell’anno sono stati realizzati le seguenti opere e forniture:
- Costruzione di un centro comunale di raccolta nella c.da SS. Cristo – Area Artigianale – Comune di Bronte;
- Fornitura di attrezzature nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di un complesso di attrezzature per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura di autoveicoli per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura e posa in opera di pesa a ponte per i servizi di raccolta differenziata – Comune di Riposto;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 autocarro nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 nastro trasportatore nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di attrezzature di n. 1 pressa idraulica continua nella piazzola di stoccaggio per la raccolta differenziata e pavimentazione del piazzale – Comune di Randazzo;
- Fornitura di automezzi e attrezzature per il centro comunale di raccolta di c.da SS. Cristo – Zona Artigianale- Comune di Bronte;
- Completamento e adeguamento del centro comunale di raccolta nel Comune di Maletto;
Oltre ai progetti realizzati i nostri uffici hanno lavorato alla stesura dei progetti esecutivi relativi alle progettazioni definitive e di massima presentati all’ARRA negli anni precedenti. Tutti i progetti sono stati redatti dal Settore Tecnico della Società “Joniambiente S.p.A.” e/o da tecnici dei Comuni soci. Questa scelta ha permesso ha questa Società di presentare un gran numero di proposte a costo zero.
Infatti l’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque ammette al finanziamento le competenze tecniche nella misura massima del 1,5% dell’importo delle opere, pari a quella che sarà corrisposta a finanziamento ottenuto ai tecnici che si sono occupati della progettazione e che cureranno la direzione dei lavori.
Nel caso in cui si fosse optato per l’affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a tecnici esterni, le spese per le competenze tecniche sarebbero state di gran lunga superiori, in gran parte a carico di questa Società e da liquidare all’approvazione dei progetti anche in caso di mancato finanziamento.
La raccolta differenziata nell’anno 2009 ha confermato gli stessi dati dell’anno 2008. Oltre alla riconferma della bandiera blu per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, sono entrati a far parte dei Comuni virtuosi, per quanto riguarda la raccolta della carta, ben 7 Comuni del nostro ATO (Bronte, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Maletto, Maniace, Mascali, Sant’Alfio.
Inoltre nell’anno 2009, a seguito attivazione del servizio di raccolta della frazione organica presso le utenze non domestiche, sono state avviate agli impianti di compostaggio 2.031 tonnellate di rifiuti.
E’ continuata la raccolta degli ingombranti, attraverso le prenotazioni presso il numero verde 800 911 303.
Con questo servizio è stato contenuto il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di tali rifiuti sul territorio. Sono stati avviati a recupero circa 1.000 tonnellate di rifiuti.
Complessivamente, escludendo i conferimenti diretti presso i centri comunali di raccolta, nei 14 Comuni facenti parte del nostro ATO, sono stati effettuati nel corso dell’anno 2009 n. 6.499 ritiri.
Vedi tabelle allegate:
Tabella 1^ – “ Dati Riepilogo R.R.U – R.D. 2009”;
Tabella 2^ – “ Raffronto dati ingombranti 2005-2009”.
E’ doveroso a conclusione dell’anno un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con la Società, dai nostri tre Dirigenti:
Ing. Giulio Nido Responsabile Settore Tecnico, il dr. Franco Musso Responsabile bilancio finanze, personale, e affari generali, il Sig. Antonino Germanà Responsabile della Raccolta Differenziata, trasmissioni dati tempo per tempo all’Assessorato Energia ed Ambiente dei dati e contati con i Consorzi di filiera (CONAI – COMIECO – CO.RE.VE. – COREPLA – CIAL – RICREA – RILEGNO ecc….)
che da soli hanno guidato le linee programmatiche della Società, ai loro collaboratori che li hanno sostenuti materialmente e quotidianamente nelle varie attività.
Sono riusciti a dimostrare brillantemente che in pochi si può gestire una società con coscienza e semplicemente facendo il proprio dovere quotidiano.
Un ringraziamento particolare al Collegio Sindacale della Società che ci hanno controllato ma anche guidato e sostenuto nelle nostre decisioni più complicate evitandoci spesso di spingerci nel terreno dei facili entusiasmi dettati dalla buona volontà e dalla voglia di fare.
Infine sento il dovere di ringraziare anche la ditta che gestisce il servizio che, seppur tra mille incomprensioni e contrasti anche quotidiani, ci ha permesso di garantire una continuità di gestione nonostante alcuni dei nostri soci non hanno versato regolarmente le quote di partecipazione per evidenti difficoltà interne, a volte anche storiche.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 30.333 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
| Descrizione |
Costo storico es. pr. |
Rivalutaz. es. pr. |
Svalutaz. es. pr. |
F.do ammort. es. pr. |
Valore Finiale |
| Costi di impianto e di ampliamento |
11.700 |
0 |
0 |
11.700 |
0 |
| Totali |
11.700 |
0 |
0 |
11.700 |
0 |
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.114.230 (€ 1.641.739 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
| Descrizione |
Costo |
| C.c.r. raccolta differenziata finanziamento regionale |
1.324.343 |
| Attrezzatura finanziamento regionale |
992.716 |
| Altri beni |
111.712 |
| Totali |
2.428.771 |
| Fondo ammortamento |
– 314.541 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) |
2.114.230 |
| Evoluzione prevedibile della gestione |
Come accennato in premessa il sistema degli ATO in Sicilia è oggetto di una profonda rielaborazione legislativa che porterà a soluzioni diverse dall’attuale sui cui risultati nessuno può oggi pronunciarsi.
La preoccupazione principale, che tutti gli amministratori pubblici di questo nostro ambito dovremo avere per il futuro, sarà quella di non disperdere il patrimonio culturale di rispetto verso l’ambiente che si è creato nei nostri concittadini e che ha visto una risposta massiccia e convinta alle nostre iniziative nelle scuole e durante l’estate lungo le nostre spiagge.
Fondamentale per le nostre popolazioni sarà il mantenimento dei confini del nostro ambito territoriale per continuare a condividere la cultura e le abitudini di un servizio che sta crescendo di anno in anno.
Si da atto che in ottemperanza al comma 1 dell’art.19 della L.r. 9/2010 del 08/04/2010, la società è stata posta in liquidazione pur continuando a svolgere il relativo servizio, il tutto nelle more di nuove disposizioni che disciplinino il passaggio al nuovo soggetto giuridico.
Nell’anno 2010, finalmente, dopo varie iniziative parlamentari e disegni di legge tendenti a riformare il sistema degli ATO in Sicilia, la Regione ha dato vita alla riforma degli ATO rifiuti.
In particolare l’Assemblea della Regione Siciliana ha approvato e pubblicato la Legge Regionale 8 aprile 2010 n°9, unitamente alle conseguenti Circolari illustrative. Tale novella legislativa, che ha come obiettivo finale generale la riforma del vecchio piano e la introduzione Del Nuovo Piano Regionale Di Gestione Dei Rifiuti, nel disporre la modifica degli ambiti territoriali ottimali esistenti con la riduzione da 27 a 10 ATO (art.5 L.R.9/2010 citata), prevede la cancellazione degli ATO esistenti, attraverso la obbligatoria procedura dello scioglimento e messa in liquidazione delle società d’ambito, con contestuale nomina dei liquidatori (art.19 L.R.9/2010 citata), e la creazione di nuove società consortili di capitale per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, (Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti – in breve S.R.R.) (art.6 L.R.9/2010 citata). Pur tuttavia, come già anticipato sopra, fino all’effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. 9/2010, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dalla stessa , ovvero fino alla soppressione delle autorità d’ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, continuano a svolgere le competenze loro attribuite, (art.19 comma 12 L.R.9/2010 citata).
Nell’ambito delle prerogative e degli obblighi attribuiti ai soggetti liquidatori/amministratori rientra quello primario di provvedere alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d’ambito accertate alla data del 31-12-2010 nonché all’accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti autorità d’ambito, sostenuti dagli EE.LL. In particolare, i liquidatori dovranno certificare la ricognizione dei debiti e dei crediti, asseverando la loro esistenza nell’an e nel quantum, nel rispetto dei principi o postulati di chiarezza, verità e precisione.
A tal proposito, l’arbitrato in corso afferente alle penali per la differenziata 2006 e 2007, nonché tutte le contestazioni in essere tra la nostra società e l’Aimeri Ambiente srl, stridono fortemente con l’obiettivo di determinare con certezza e precisione la massa attiva e passiva,o addirittura confliggono con tale esigenza, rendendola di fatto la superiore quantificazione indeterminabile allo stato degli atti. A tal proposito quest’organo ritiene che una equa transazione non possa non comportare benefici effetti alla società, non ultimo quello di garantire certezza e determinabilità ai rapporti di dare avere fra la stessa e i terzi.
Pur nelle difficoltà inevitabili che il bailamme legislativo ha comportato, l’organo che vi scrive non ha perso di vista quella che dal suo insediamento è stata una sua priorità, ovvero l’affidamento del nuovo servizio, nella forma della Raccolta Integrata Dei Rifiuti, (c.d. “porta a porta”), mediante una nuova gara d’appalto.
Per ben tre volte, sono stati predisposti tutti gli atti necessari, ed è stata bandita la nuova gara per l’affidamento del servizio igiene urbana nell’ATO-CT1. Le prime due volte non sono state presentate offerte; con ogni probabilità, la ragione di tale situazione è da individuare nella brevissima durata prevista, nei primi due bandi, tal che l’economicità della partecipazione era pregiudicata. Nel terzo bando, i cui termini per la partecipazione, alla data odierna sono ancora aperti, il periodo in gara per quanto breve in assoluto, e pur sempre di gran lunga superiore ai primi due, e pertanto speriamo che le valutazioni economiche dei potenziali partecipanti subiscano da tale circostanza positive influenze, che indicano gli stessi a presentare delle offerte.
Sin dalla sua costituzione, per la Joniambiente S.p.A, le attività di comunicazione hanno assunto una indiscussa centralità, riscontrabile direttamente nel territorio dei 14 comuni dell’A.T.O. CT 1.
Giova ricordare alcune iniziative svolte nel corso del 2010:
- La continuità nella divulgazione dei numeri utili della società , nel servizio informazioni e segnalazioni fornito dal Numero Verde, nell’indagine telefonica di customer satisfaction e nell’aggiornamento del sito internet;
- La distribuzione capillare di materiale divulgativo sulla raccolta differenziata alle utenze domestiche e commerciali ad hoc per ciascuno dei 14 comuni soci (ad es. locandine con calendario settimanale di raccolta r.d.);
- La realizzazione di incontri di sensibilizzazione nelle scuole, di incontri pubblici e di manifestazioni di sensibilizzazione (sponsorizzazione progetto “Nell’Alveo del torrente”);
- L’affissione programmata di manifesti informativi in tutti i 14 comuni soci;
- La collaborazione con le associazioni di volontariato (progetto “Un tappo per la solidarietà” – UNITALSI);
- La realizzazione e la distribuzione di gadget (es. EcoCalendario, Ecopen, varie edizioni della rivista Riciclamente).
L’ anno 2010 , inoltre, ha registrato sia la riproposizione di campagne di sensibilizzazione già avviate sia il lancio di nuove. Tra le prime ricordiamo:
- Il progetto “Riciroriandolo” (raccolta della carta delle scuole primarie e dell’infanzia in cambio di coriandoli);
- Il progetto “EcoPresepe 2010”;
- La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate”;
Tra le seconde:
- La campagna di sensibilizzazione “Progetto Futuro”, relativa al progetto pilota di raccolta integrata dei rifiuti a Calatabiano e Maletto (realizzazione di depliant, locandine, manifesti ecc.)”;
La campagna di sensibilizzazione “EcoEstate” ha promosso la raccolta differenziata sulle spiagge dei comuni etnei dell’A.T.O. CT 1 attraverso una serie di interventi mirati quali: l’installazione di EcoPoint sul longomare; la collocazione di n. 3 Infopoint sul lungo mare Riposto- Calatabiano per la distribuzione di sacchetti, gadget e materiale divulgativo (Riciclamente). Nell’ambito della medesima iniziativa vanno annoverate, inoltre, la presenza di stand informativi in occasione di sagre e manifestazioni (tenutesi nei comuni di Bronte – Sagra del Pistacchio e Randazzo – Notte Bianca).
L’anno 2010 ha visto il Settore Tecnico della Società particolarmente impegnato nell’adeguamento dei progetti già presentati all’A.R.R.A. negli anni precedenti. Nel corso dell’anno sono stati riadeguati e ripresentati all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”, i seguenti progetti:
- Progetto di adeguamento delle isole ecologiche nell’ATO-CT1;
- Progetto per la realizzazione di un impianto di smaltimento RAEE in Randazzo;
- Progetto per la realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da ubicarsi in via Etna- Comune di S. Alfio;
- Progetto per la realizzazione dell’isola ecologica per la raccolta dei rifiuti – Comune di Mascali;
- Progetti per l’acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata della frazione organica;
- Progetto per acquisto attrezzature per informatizzazione i Centri Comunali di Raccolta/Isole ecologiche.
Inoltre nel corso del 2010 è stato predisposto ed avviato il progetto pilota per la raccolta integrata dei rifiuti nei Comuni di Calatabiano e Maletto.
La raccolta differenziata nell’anno 2010 ha subito lievi scostamenti rispetto all’anno 2009.
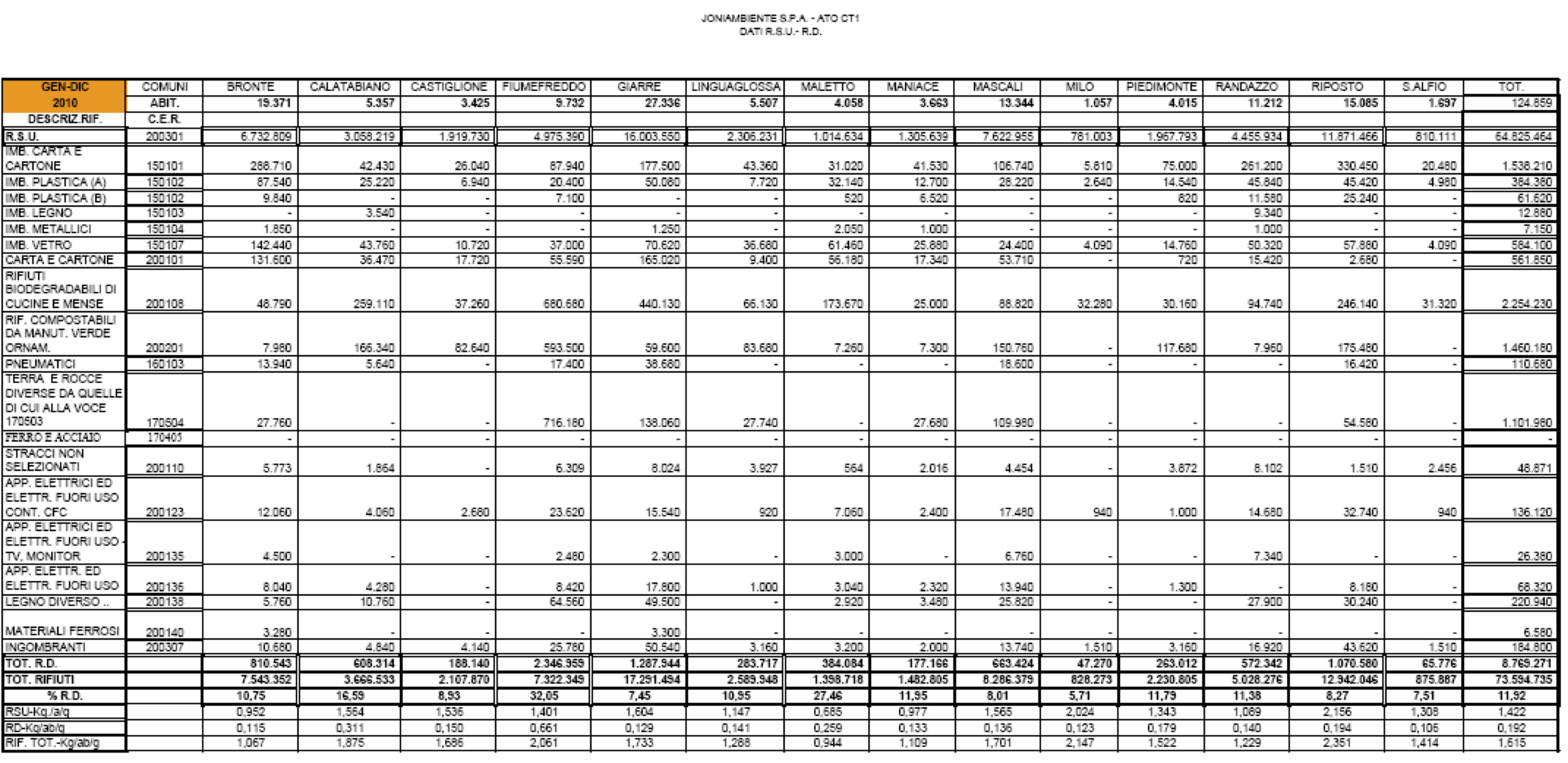
I risultati del 2010, per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi (carta e cartone, plastica e vetro) sono desumibili dal seguente grafico.
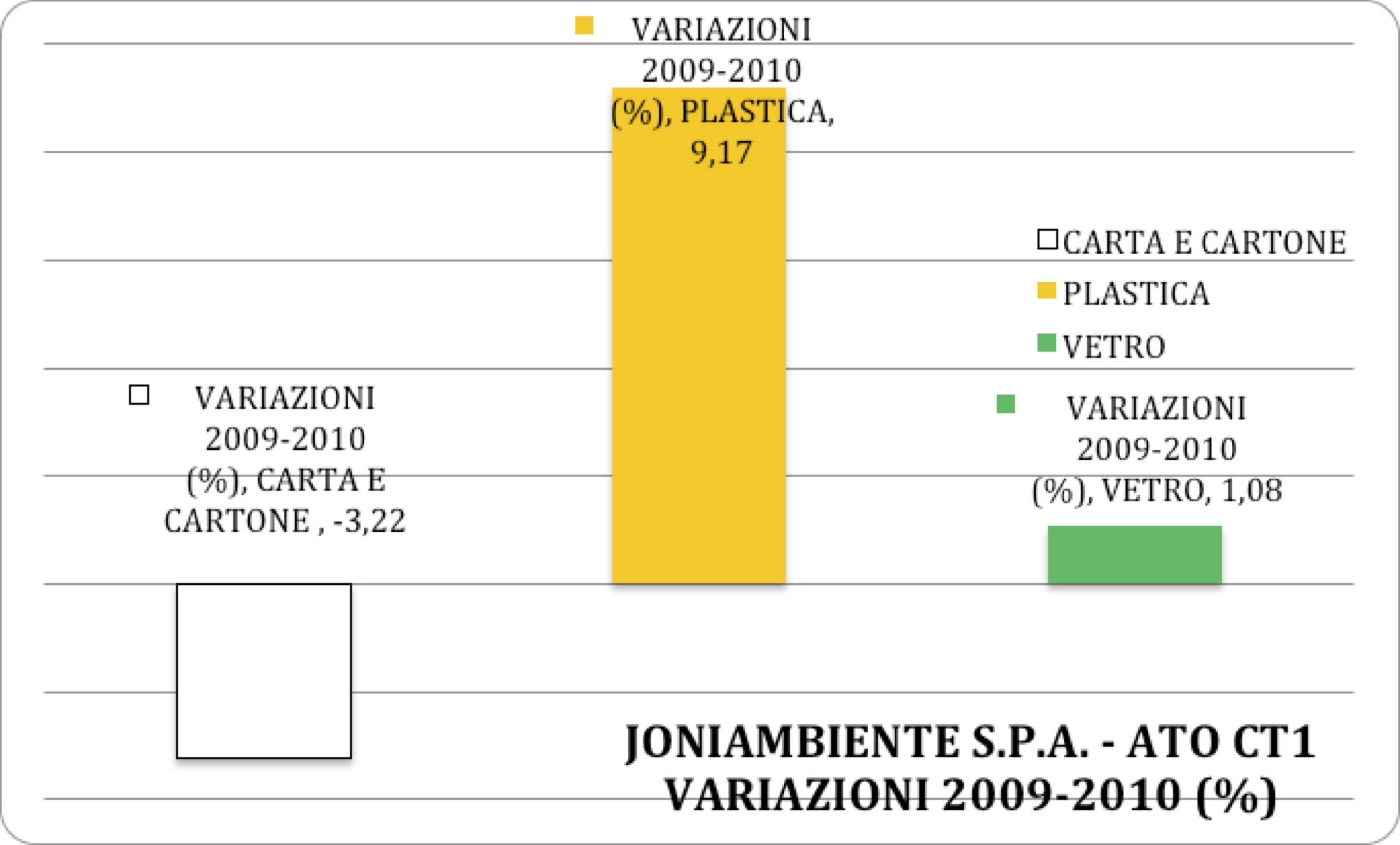
Dallo stesso si evidenzia, rispetto all’anno 2009, un incremento pari al 9% circa per quanto riguarda la plastica e dell’1% per quanto riguarda il vetro. Il cartone e la carta hanno avuto una leggera flessione, pari a circa il 3%.
La flessione di carta e cartone è determinata dal numero crescente di attività commerciali che si avvalgono per l’espletamento del servizio di ditte esterne, in conformità a quanto previsto dall’art. 195 lett. e) del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., Per quanto attiene il vetro, l’incremento è stato minimo a causa del blocco dei ritiri da parte di COREVE (analisi del materiale risultato non conforme ai parametri previsti dagli allegati tecnici della Convenzione). Il blocco non ha consentito di conferire presso la piattaforma il vetro che è rimasto stoccato nei cassoni all’interno dei nostri CCR/isole ecologiche. Con il sblocco dei ritiri da parte di COREVE nell’anno 2011 si avrà un incremento più consistente.
E’ stata riconfermata anche per l’anno 2011 la bandiera blu per il Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
La raccolta della frazione organica presso le utenze non domestiche è continuata anche nel 2010, con un incremento del 20% circa.
E’ continuata la raccolta degli ingombranti, attraverso le prenotazioni presso il numero verde. Con questo servizio è stato contenuto il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di tali rifiuti sul territorio. Sono stati avviati a recupero circa 750 tonnellate di rifiuti.
Nonostante i dati di cui sopra, per poter incrementare le percentuali di r.d. necessita un servizio che, oltre alla raccolta delle suddette frazioni merceologiche, comprenda anche la frazione organica presso le utenze domestiche.
Nelle more dell’espletamento della prima gara d’appalto, poi andata deserta, Joniambiente, al fine di verificare eventuali criticità di quanto progettato, ha proceduto ad una sperimentazione di tale sistema di raccolta in due Comuni (Maletto e Calatabiano).
I risultati si evincono dai seguenti grafici.
Oltre ad una notevole diminuzione dei conferimenti in discarica, si evidenzia che anche la frazione secca differenziata (carta, cartone, plastica e vetro) ha avuto un incremento rilevante dovuto, essenzialmente, all’eliminazione dei cassonetti stradali.
Da quanto sopra, si ritiene la raccolta integrata dei rifiuti con il metodo “porta a porta” il sistema più idoneo per raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigenti normative, ma anche l’unico che, a medio e lungo termine, consentirà un contenimento dei costi.
E’ doveroso a conclusione dell’anno un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato con la Società, dai nostri tre Dirigenti che da soli hanno guidato le linee programmatiche della Società, ai loro collaboratori che li hanno sostenuti materialmente e quotidianamente nelle varie attività.
Sono riusciti a dimostrare brillantemente che in pochi si può gestire una società con coscienza e semplicemente facendo il proprio dovere quotidiano.
Un ringraziamento particolare al Collegio Sindacale della Società che ci hanno controllato ma anche guidato e sostenuto nelle nostre decisioni più complicate evitandoci spesso di spingerci nel terreno dei facili entusiasmi dettati dalla buona volontà e dalla voglia di fare.
Infine sento il dovere di ringraziare anche la ditta che gestisce il servizio che, seppur tra mille incomprensioni e contrasti anche quotidiani, ha permesso di garantire una continuità di gestione nonostante alcuni dei nostri soci non hanno versato regolarmente le quote di partecipazione per evidenti difficoltà interne, a volte anche storiche.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 53.415 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
| Descrizione |
Costo storico es. pr. |
Rivalutaz. es. pr. |
Svalutaz. es. pr. |
F.do ammort. es. pr. |
Valore Finale |
| Piano di Comunicazione (Finanziamento Regionale) |
53.415 |
0 |
0 |
0 |
53.415 |
| Totali |
53.415 |
0 |
0 |
0 |
53.415 |
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.857.739 (2.114.230 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
| Descrizione |
Costo |
| C.c.r. raccolta differenziata finanziamento regionale |
1.324.343 |
| Attrezzatura finanziamento regionale |
992.716 |
| Altri beni |
159.598 |
| Totali |
2.476.657 |
| Fondo ammortamento |
– 618.918 |
| Totale immobilizzazioni materiali (II) |
1.857.739 |
| Evoluzione prevedibile della gestione |
Come accennato succintamente in premessa, è fondato presumere che entro il primo semestre del 2011 i comuni della provincia approveranno lo schema di statuto che dovrà adottare la nuova società di regolamentazione dei rifiuti, (S.R.R.), che gestirà il servizio per l’intera provincia. Non appena costituita la nuova S.R.R. , ad essa verranno effettuate le consegne e tutta la gestione del servizio rimarrà affidata a quest’ultima in ottemperanza al comma 1 dell’art.19 della L.r. 9/2010 del 08/04/2010, il quale statuisce che la società posta in liquidazione continua a svolgere il relativo servizio, nelle more di nuove disposizioni che disciplinino il passaggio al nuovo soggetto giuridico (S.R.R.).
Sin dalla sua costituzione, per la Joniambiente S.p.A, le attività di comunicazione hanno assunto una indiscussa centralità, riscontrabile direttamente nel territorio dei 14 comuni dell’A.T.O. CT 1.
Giova ricordare alcune iniziative svolte nel corso del 2011:
- Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione della cittadinanza sono stati realizzati e distribuiti, a tutte le utenze non domestiche, gli Istituti Scolastici, gli URP, tutti gli uffici comunali e i cittadini richiedenti, gli Ecocalendari 2011 (nelle versioni lavagna, da muro e da tavolo): strumenti utili e di facile consultazione tesi a perfezionare le modalità di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti dell’ambito;
- E‘ stato periodicamente aggiornato sul sito della società, per una più ampia consultazione, il Prontuario dei rifiuti con possibilità di ricerca alfabetica degli stessi per conoscere la loro destinazione ultima;
- E’ stato mantenuto il Numero Verde 800.911.303 per fornire informazioni sul servizio di raccolta differenziata, sulla società e sul ritiro gratuito degli ingombranti;
- E’ stata condotta l’indagine telefonica di customer satisfaction rivolta ai cittadini, destinata a verificare l’effettiva esecuzione del servizio di ritiro a domicilio degli ingombranti, al fine di migliorare ed ottimizzare il servizio e scongiurare l’abbandono dei rifiuti ingombranti e durevoli sul territorio;
- E’ stato allestito uno stand informativo presso la galleria del Centro Commerciale Conforama di Riposto in occasione del Salone dell’Ambiente dal 02.04.11 al 10.04.11;
- Presso l’Aula consiliare del Comune di Randazzo, è stato organizzato un Seminario sulle Tecnologie applicate nell’ambito del riciclo in occasione della visita di una delegazione giapponese interessata a conoscere la nostra realtà in materia di smaltimento e gestione rifiuti;
- E’ stato adeguatamente promosso e gradualmente avviato il Nuovo Servizio di Raccolta integrata dei Rifiuti in riferimento al quale sono stati predisposti i seguenti prodotti comunicativi: lettera informativa con allegato tagliando per il ritiro del kit per la raccolta differenziata recapitata a ciascun utenza, locandine pubblicizzanti i punti di distribuzione, adesivi illustrativi per contenitori, diffusione di spot radio e tv su emittenti locali, attività di sensibilizzazione telefonica condotta ad opera degli operatori del Numero Verde, formazione e sensibilizzazione dei volontari addetti alla distribuzione nonché loro dotazione di uniforme identificativa;
- In occasione del Natale, infine, è stato promosso presso le scuole dell’infanzia e le scuole primarie il progetto di sensibilizzazione ambientale “EcoAlbero”, finalizzato ad incrementare la pratica del riutilizzo all’interno degli istituti scolastici.
Con l’aggiudicazione della gara d’appalto relativa alla raccolta integrata dei rifiuti, si è avviato quel processo di innovazione del servizio, già da qualche anno auspicato e che, dopo le due gare deserte, ha potuto prendere avvio.
Il 5 dicembre 2011, infatti, è stato attivato il servizio di raccolta integrata dei rifiuti nel 1° Step comprendente Bronte, Maniace e Randazzo, oltre a Maletto, già oggetto di sperimentazione, insieme a Calatabiano, dal mese di luglio del 2010. A partire dal 5 marzo 2012 è stato avviato il servizio anche in nel 2° Step comprendente Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte, Fiumefreddo di S. e il già citato Calatabiano.
Di seguito si riportano i risultati conseguiti fino al mese di aprile 2012, raffrontati con lo stesso periodo dell’anno precedente.
I risultati raggiunti in così poco tempo ci soddisfano, ma soprattutto ci indicano che la strada intrapresa è quella giusta. Si sottolinea, che oltre alle “semplici” statistiche di percentuale di raccolta differenziata, il dato più importante è la diminuzione dei rifiuti da smaltire in discarica.
Già dopo pochi mesi si è già in linea con il Piano di Azione della Regione Siciliana, relativamente al Q.S.N. (quadro strategico nazionale) 2007-2013, che, con l’indicatore S.07 – “Kg. di rifiuti urbani da smaltire in discarica per abitante/anno”, indica il target da raggiungere nel 2013: kg. 230/pro-capite.
I nove Comuni dove è già stato attivato il nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti, lo hanno già raggiunto e, in alcuni casi, sono anche al di sotto di tale soglia, come dimostrano i precedenti grafici.
Un’altra normativa che si sta rispettando con il nuovo servizio è quella prevista dal D.L.vo n. 36/2005 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
L’art. 5 del suddetto decreto prevede che a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, 115 kg/anno per abitante entro otto anni e 81 kg/anno per abitante entro quindici anni.
Per quanto riguarda, invece, la raccolta differenziata della frazione secca, si ritiene opportuno evidenziare un dato negativo: la diminuzione della raccolta del cartone di imballaggio. Infatti, rispetto all’anno 2010, si è avuta una diminuzione dei conferimenti presso la piattaforma S.A.C.C.A. di circa 300 tonnellate e, di conseguenza, un minor introito dei Contributi CONAI. Ciò è dovuto a quanto già segnalato fin dal mese di settembre 2011 a tutti gli Enti Soci, evidenziando come la raccolta da parte di “soggetti” diversi dal servizio pubblico fosse in contrasto con le ordinanze sindacali emesse dai Sindaci e che “senza apposita autorizzazione e/o accordo da parte del produttore (utenza)” il prelievo si configurava come “ furto” di cartone.
Nel corso del 2011 sono state espletate le seguenti gare d’appalto:
- “Lavori di manutenzione presso l’isola ecologica del Comune di Randazzo sita in via cap. Castiglione”;
- Ditta aggiudicataria: Franco Raffaele;
- Importo: € 12.604,69oltre IVA;
- “Fornitura di n. 100 cassonetti da lt 1.100”;
- Ditta aggiudicataria: Tech Servizi s.r.l.;
- Importo: € 15.950,00 oltre IVA;
- “Servizi di igiene urbana nell’ATO-CT1”;
- Ditta aggiudicataria: Aimeri Ambiente s.r.l.;
- Importo: € 8.296.751,19 oltre IVA;
- “Fornitura contenitori per la raccolta integrata dei rifiuti nell’ATO-CT1”;
- Ditta aggiudicataria: ECOLMEC s.r.l.;
- Importo: € 730.188,36 oltre IVA;
La Società “Joniambiente S.p.A.” oggi in liquidazione, ha iniziato la gestione diretta dei servizi di igiene urbana nel territorio dell’ATO-CT1, il 01/02/2006.
Il servizio progettato in house da tecnici distaccati dai Comuni soci, è stato concesso in appalto con gara ad evidenza pubblica e si è concluso il 31/07/2011.
L’appalto era unico per tutti i 14 Comuni inclusi nell’ATO-CT1 aventi una popolazione complessiva di circa 123.000 abitanti.
In data 01/08/2011 ha avuto il via il nuovo servizio appaltato con gara ad evidenza pubblica in data 30/05/2011.
Il progetto redatto in house dai tecnici della stessa Società Joniambiente S.p.A. è frutto dall’esperienza acquisita in 5 anni di gestione dei servizi di igiene urbana nell’ATO-CT1.
Con il nuovo Progetto di gestione integrata dei rifiuti giunto, come da cronoprogramma di attivazione, alla sua ultima fase prima del definitivo avvio dei nuovi servizi in tutti e 14 i Comuni dell’A.T.O. CT1 (alla data odierna, di fatto, è stato già avviato in 9 di essi), le priorità assunte dalla Joniambiente S.p.A. per la sua formulazione, coerentemente con le direttive europee e la normativa nazionale e regionale, sono state quelle:
della prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti indifferenziati;
- del recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
- del recupero e compostaggio dei rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
- dello smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza, al fine ultimo di attuare una concreta politica ambientale, avente tra i suoi obiettivi principali quelli di seguito indicati:
- principio di chi inquina paga (responsabilità economica);
- principio delle priorità (riduzione dei volumi, riuso, riciclo e recupero [c.d. 4R]);
- dalla crisi dei rifiuti (emergenza) alla politica ambientale;
- consapevolezza sociale, sensibilità ambientale, cultura dei servizi pubblici;
- le potenzialità del riciclaggio e gli obiettivi per gli imballaggi;
- obiettivi per materiali (immesso/riciclo), per imballaggi e per rifiuti pericolosi;
- incentivazione del compostaggio di qualità con individuazione di sistema premiante;
- crescente attenzione ai risultati finali e non alle modalità operative (ruolo gestore);
- coordinamento territoriale delle frazioni merceologiche;
- gestione omogenea delle raccolte differenziate (riciclabili/pericolose);
- analisi capacità impiantistiche di smaltimento e soluzioni gestionali;
- adeguamento tassa-tariffa ambientale e valutazioni economiche;
- verifica possibilità d’integrazione servizi;
- la prevenzione dei rifiuti;
- governance “forte” con programmazione e controllo sul sistema dei rifiuti.
Si tratta, ovviamente, di indicazioni di principio da cui si è partiti, affrontate nel merito per ricercare le possibili soluzioni di attuazione, in maniera da proporre, infine, un progetto efficace, realizzabile e di lunga durata nel tempo. Appare opportuno rappresentare, come prima ancora di proporlo con la nuova gara ad evidenza pubblica del maggio 2012, lo stesso è stato avviato in modo sperimentale, già nell’anno 2010, nei c.d. 2 Comuni pilota di “Calatabiano” (per i Comuni a valle) e “Maletto” (per Comuni della fascia pedemontana), ove si sono raggiunti risultati soddisfacenti. Questa sua applicazione pratica, inoltre, ha permesso di definire alcune delle più importanti scelte gestionali adottate, riprese e inserite nella sua stesura finale.
Il precedente sistema di gestione dei rifiuti urbani dell’A.T.O. CT1, è innegabile, presentava forti criticità, per cui si è ritenuto necessario adottare dei “rilevanti interventi di ristrutturazione”, al fine di garantire, per un lungo periodo, non solo la conformità alle disposizioni di legge vigenti, che sarebbe stata fine a se stessa, ma anche la sostenibilità e la solidità tecnico-ambientale.
Le analisi condotte nel corso della predisposizione di questo progetto, arricchito dalle informazioni ricevute nell’ambito pratico della sua applicazione sperimentale, hanno mostrato la fattibilità di questo percorso, anche in termini di sostenibilità economica, delineando opportunità di intervento volte a:
- invertire concretamente l’attuale tendenza alla crescita della produzione di rifiuti;
- massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo delle raccolte differenziate (prioritariamente con sistemi domiciliari), finalizzate sia al reinserimento nei cicli produttivi di materie prime da esse derivate, sia alla produzione di “compost” con valorizzazione del contenuto organico del rifiuto in termini agronomici;
- minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al tendenziale annullamento del flusso di rifiuti così destinati.
Il progetto così formulato, a regime, oltre a quanto precedentemente evidenziato sulla normativa dei conferimenti in discarica, dovrebbe riprendere e confermare gli obiettivi di raccolta differenziata definiti a livello regionale dalla L.R. 08-04-2010 n. 9:
- anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento;
- anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento.
Con le fasi di progetto già attuate era stato previsto ancora:
- l’educazione e la formazione del personale operaio impiegato nell’ambito dei servizi;
- diverse azioni di informazione al cittadino, concretizzatesi con conferenze presso le scuole; la distribuzione di appositi volantini e depliant; impiego dei mass media; comitati consultivi degli utenti, in corso di distribuzione dei KIT per uso domestico; etc..
- coinvolgimento delle locali Associazioni di volontariato aventi tra gli scopi sociali la salvaguardia dell’ambiente, che dopo opportuni corsi di formazione hanno contribuito in modo determinante all’avvio del servizio partecipando alla distribuzione dei Kit per la raccolta e all’informazione capillare della popolazione.
| Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio |
Vi segnaliamo che dopo la chiusura dell’esercizio si sono verificati i seguenti eventi:
L’Assemblea Regionale Siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 ha modificato, in talune parti, la legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9, per assicurarne la piena e generale effettività e garantire una rapida transizione verso il nuovo sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia come delineato nella legge di riforma.
Con l’art. 11 comma 66 della suddetta legge regionale n. 26/12, si è attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, individuano bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, stabilendo che non possono superare il numero massimo di otto.
Meritano particolare attenzione, altresì, le previsioni di cui al comma 2 bis dell’art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 introdotte dal comma 64 dell’art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dalle quali si evince inequivocabilmente la volontà del legislatore di dare piena e immediata attuazione al nuovo modello di organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, governato dalle S.R.R.
Il legislatore regionale, con l’obiettivo di separare definitivamente la delicata attività di liquidazione dei Consorzi e/o delle Società d’ambito, dalla altrettanto complessa attività di gestione del servizio, pone espressamente il divieto, per i liquidatori dei Consorzi e delle Società d’ambito, di compiere qualsiasi atto di gestione dopo il 30 settembre 2012, attribuendone la competenza, da quella data, ai nuovi soggetti gestori, le S.R.R.
Quindi i liquidatori potranno, solo entro e non oltre il citato termine, porre in essere atti di gestione, i cui effetti comunque dovranno cessare entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà avvenire, sempre ai sensi del citato comma 2 bis, l’estinzione dei Consorzi e delle Società d’ambito.
| Evoluzione prevedibile della gestione |
L’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti dal quadro precedente alla situazione prevista a regime, si sta concretizzando con una progressiva attuazione degli interventi previsti, come da cronoprogramma di attivazione.
I risultati fino ad oggi conseguiti, come sopra rappresentato, dimostrano la bontà delle scelte progettuali adottate. L’avvio dei servizi ha prodotto significativi risultati, di gran lunga superiori sia quelli precedenti, che alle aspettative ipotizzate.
Nell’anno 2012 è stato avviato, con diversi step, il nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti. Parecchie le difficoltà che si sono dovute affrontare già a partire dai primi mesi dell’anno (sciopero degli autotrasportatori, blocco dei forconi, assemblee sindacali e sciopero per il mancato o ritardato pagamento degli emolumenti ai dipendenti Aimeri). A distanza di un anno, sembra opportuno una verifica su quanto accaduto.
Come precedentemente detto, pur con tantissime difficoltà, il servizio sembrava essersi avviato verso un suo consolidamento, così come da progetto, ed i risultati del 1° semestre erano più che lusinghieri sia nel 1° che nel 2° step.
Purtroppo l’avvio del 3° step, per motivi non certamente imputabili a questa Società, ha provocato problemi di carattere organizzativo che hanno vanificato nel secondo semestre quanto di positivo era stato ottenuto nel primo semestre (vedi grafico).
Oltre alle semplici percentuali di raccolta differenziata, il dato più significativo è stata la diminuzione dei conferimenti in discarica, come si evince dalla allegata tabella.
| RIEPILOGO DISCARICA (RIFIUTI E COSTI) |
| ANNO 2011 |
ANNO 2012 |
| R.S.U. (Kg) |
COSTO DISCARICA |
R.S.U. (Kg) |
COSTO DISCARICA |
| |
|
|
|
| 62.887.870 |
6.967.176,35 |
45.321,442 |
5.023.381,41 |
Ciò ha comportato anche un notevole risparmio sui conferimenti in discarica.
Un altro dato confortante è il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica per abitante/anno.
Infatti, come può desumersi dai grafici, in parecchi Comuni del 1° e 2° step, pur con le difficoltà sopraelencate, si è già in linea con il Piano di Azione della Regione Siciliana, relativamente al Q.S.N. (quadro strategico nazionale) 2007-2013, che, con l’indicatore S.07 – “Kg. di rifiuti urbani da smaltire in discarica per abitante/anno”, indica il target da raggiungere nel 2013: kg. 230/pro-capite.
Alcuni sono già al di sotto di tale soglia, altri sono prossimi all’obiettivo.
Sulla scorta di quanto sopra, si è dell’avviso che il percorso intrapreso sia quello giusto e che quanto di positivo ottenuto nel primo periodo debba essere la base di partenza per il futuro servizio di raccolta integrata dei rifiuti.
Un dato negativo rispetto a quanto sopra evidenziato è la diminuzione della raccolta del cartone di imballaggio, con conseguente minore introito dei contributi CONAI.
Il fenomeno è accentuato soprattutto nei Comuni del terzo step, dove nell’anno 2012 è stato raccolto solo per il 13,85% del totale degli imballaggi in cartone. Il 21,97 è stato raccolto nel 2° step, mentre i maggiori quantitativi sono stati raccolti nel 1° step con il 64,18% del totale.
Da una comparazione con gli anni antecedenti al fenomeno di raccolta cartone da parte di ditte “esterne”, il danno economico per la Società può essere quantificato in circa € 90.000 per l’anno 2012.
Nel corso dell’anno 2012 l’attività della società è stata, essenzialmente, rivolta e incentrata all’avvio in tutto l’ATO CT1 del nuovo Servizio di Raccolta integrata dei Rifiuti, già partito il 5 dicembre 2011 per i Comuni del 1° step Bronte, Randazzo, Maniace e Maletto.
In conseguenza è stato redatto e predisposto il progetto di gestione sperimentale ex art. 3 dell’ordinanza n. 151 del 14.11.2011 del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti in Sicilia.
In ossequio al mandato Assembleare, e con un rilevante sforzo organizzativo, di concerto con le amministrazioni comunali coinvolte, è stato pianificato l’avvio, in tempi brevi, del medesimo servizio sul territorio dei restanti Comuni dell’ambito, (Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Riposto e Sant’Alfio).
Essenziale nella fase di start up del progetto, è stata la collaborazione operosa delle associazioni di volontariato e delle associazioni aventi nel proprio statuto come scopo la cura dell’ambiente che, opportunamente edotti tramite dei corsi di formazione, e successivamente coordinati e seguiti dal nostro personale tecnico direttamente sul territorio, dopo aver stipulato apposita convenzione, si sono occupati della distribuzione dei kit, ed essendo a stretto contatto con gli utenti hanno contribuito in maniera rilevante, a fornire una adeguata informazione sulle modalità di conferimento.
Nel mese di Marzo è partito ufficialmente il nuovo servizio di raccolta “porta a porta” nei Comuni appartenenti al 2°step nello specifico Linguaglossa, Piedimonte, Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia e Calatabiano.
L’avvio del servizio riguardo al 3° step, previsto per il mese di Maggio, si è poi rivelato al quanto ostico, inevitabilmente, anche per via degli spiacevoli episodi accaduti alla ditta Aimeri Ambiente e dopo il susseguirsi di diversi tavoli tecnici, con tutte le difficoltà del caso a ridosso praticamente della stagione estiva, è stato attivato nel mese di Luglio nei Comuni di Milo, Sant’Alfio, Giarre, Mascali e Riposto.
Nonostante l’avvio del 3° step abbia conseguito buoni risultati rispetto ai target prefissati, nei Comuni del 1° e 2° step, tale avvio ha generato i disagi che si sono ripercossi sul buon andamento del servizio nel suo complesso, che è divenuto via via sempre più inefficiente ed inefficace.
I motivi di tale grave empasse, trovano la loro causa principalmente nell’impiego, da parte della ditta Aimeri Ambiente, di una quantità di automezzi insufficiente e non adeguata ai programmi di lavoro predisposti e alle necessità minime. Peraltro, cosa molto grave, in tal modo la stessa ditta Aimeri ha violato quando statuito dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Nemmeno la fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata si è rivelata idonea e sufficiente rispetto alle quantità indicate nel Piano di organizzazione dei servizi.
Infine, il mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori dipendenti della ditta aggiudicataria ha ulteriormente aggravato la situazione, in quanto ha generato continui scioperi, che hanno fatto precipitare definitivamente la qualità e l’efficienza del servizio.
Ovviamente, tutto ciò ha comportato come diretta conseguenza, la doverosa applicazione delle sanzioni a carico della ditta appaltatrice. Giovi a questo fine porre mente che solo per il periodo da Luglio a Dicembre, ossia dall’avvio del 3° step, sono state elevate penali per un importo pari a € 2.441.658,05.
Nel corso del 2012 sono state espletate le seguenti gare d’appalto:
- “Servizi di estirpazione erbacce, rovi e piante infestanti lungo i marciapiedi, i muri ed i cigli nelle strade urbane ricadenti nel territorio dell’ATO CT1”
- Ditta aggiudicataria: Grasso Servizi di Toscano Maria Luisa.
- Importo di aggiudicazione del servizio: € 59.966,22 oltre IVA
- “Fornitura distributori automatici sacchi per la raccolta differenziata nell’ATO CT1”
- Ditta aggiudicataria: CO.M.E.S.I. Group srl.
- Importo per la fornitura: € 165.602,40 oltre IVA
- “Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata nell’ATO CT1”
- Ditta aggiudicataria: Lady Plastik srl.
- Importo per la fornitura: € 133.951,84 oltre IVA
Nell’ottica della continuità operativa e del costante miglioramento dei risultati, nell’anno 2012 la Joniambiente S.p.A. ha dato attuazione a diverse campagne di comunicazione tese, da una parte, ad educare e sensibilizzare attraverso il coinvolgimento attivo i cittadini di oggi e di domani e, dall’altra, a promuovere e sostenere la raccolta differenziata senza con questo dimenticare di dare la giusta visibilità alla società quale soggetto deputato alla gestione dei rifiuti.
Alla base di ogni strategia comunicativa condotta da Joniambiente e rivolta ai diversi target c‘è sempre stata la sinergia con tutti gli attori dell’ambito territoriale: primi fra tutti gli Enti Soci, la ditta aggiudicataria del servizio, le istituzioni locali (scolastiche e non), le associazioni di volontariato e di categoria, le utenze commerciali nonché i Consorzi di Filiera.
Tra gli interventi giova anzitutto ricordare quelli posti in essere contestualmente alle operazioni di avvio del nuovo Servizio di Raccolta Integrata.
Considerato che il passaggio al Sistema di Raccolta Integrata dei Rifiuti ha comportato un cambiamento radicale nelle abitudini degli utenti, è stata predisposta una comunicazione ad hoc, in grado di sottolineare in modo funzionale i vantaggi personali e collettivi, di veicolare, con estrema chiarezza, le modalità, i tempi del nuovo servizio assieme agli obiettivi ambientali e finanziari; pertanto, questa Società ha ritenuto opportuno predisporre un apposito Piano Integrato preoccupandosi, da subito, di concordarne l’indirizzo assieme alla ditta aggiudicataria in occasione di numerosi incontri propedeutici all’avvio del nuovo servizio.
Tutte le riunioni e i tavoli tecnici si sono basati sul dialogo e sul confronto tra gli ”attori” principali, ovvero i rappresentanti dei Comuni, dell’azienda aggiudicataria, i tecnici, gli esperti di comunicazione e ai rappresentanti delle associazioni di volontariato al fine di concordare tempi, modi e strumenti atti a garantire una pianificazione condivisa e partecipata tanto in fase di start-up che di follow-up.
Su questi presupposti sono stati definiti e realizzati gli interventi che seguono:
1- A seguito di apposita convenzione stipulata con Poste Italiane, si è provveduto al recapito di n. 51.037 lettere informative a tutte le utenze con allegato il tagliando per il ritiro gratuito del kit per la raccolta differenziata;
| COMUNI SOCI |
N. LETTERE RECAPITATE |
| BRONTE |
7.699 |
| CALATABIANO |
2.326 |
| CASTIGLIONE DI SICILIA |
1.529 |
| FIUMEFREDDO DI SICILIA |
3.935 |
| GIARRE |
10.855 |
| LINGUAGLOSSA |
2.194 |
| MALETTO |
1.595 |
| MANIACE |
1.439 |
| MASCALI |
5.669 |
| MILO |
496 |
| PIEDIMONTE ETNEO |
1.865 |
| RANDAZZO |
4.710 |
| RIPOSTO |
6.049 |
| SANT’ALFIO |
676 |
|
|
2- la realizzazione di n. 71.500 pieghevoli informativi con le istruzioni su come effettuare correttamente la raccolta differenziata e le modalità di svolgimento del servizio di raccolta sulla base della zona di appartenenza distribuiti dai volontari delle associazioni che hanno stipulato apposita convenzione con questa società per collaborare alla consegna dei kit per la raccolta differenziata; |
| 3- la collocazione, in punti strategici (punti di maggior afflusso pubblico quali farmacie, punti vendita, rivenditori di tabacchi, uffici pubblici, ecc), di n. 1.000 locandine personalizzate per ciascun comune, per pubblicizzare i punti di consegna dei kit.
Lo dimostra il fatto che entro il 05 dicembre 2011, data di avvio del servizio di raccolta, aveva già partecipato alle operazioni di ritiro:
l’83% dei cittadini di Bronte (ovvero 6.414 utenze su 7.696);
il 96% dei cittadini di Randazzo (ovvero n. 4.504 utenze su 4.710);
il 92% dei cittadini di Maniace (ovvero n. 1320 utenze su 1.439); |
| 4- l’apposizione di un messaggio sui tradizionali cassonetti per avvisare della loro prossima rimozione con il rimando al Numero Verde e al sito internet della società per qualsiasi ulteriore informazione; |
| 5- la realizzazione di adesivi per i contenitori di prossimità indicanti le tipologie di rifiuto da potervi conferire; |
| 6- lo svolgimento di un apposito corso di formazione per i volontari curato dal dirigente del Servizio Raccolta Differenziata Antonino Germanà, le cui lezioni si sono tenute secondo il calendario di seguito indicato:
| DATA |
ORA |
SEDE |
| Lunedì 3 ottobre 2011 |
9.30-12.30 |
Saletta conferenze Comune di Randazzo |
| Lunedì 17 ottobre 2011 |
16.00-18.30 |
Saletta conferenze Comune di Randazzo |
| Martedì 18 ottobre 2011 |
16.00-18.30 |
Aula consiliare Comune di Bronte |
| Venerdì 21 ottobre 2011 |
16.00-18.30 |
Saletta conferenze Comune di Randazzo |
| Martedì 25 ottobre 2011 |
16.00-18.30 |
Aula consiliare Comune di Bronte |
Durante il corso sono stati trattati e sviluppati con il necessario approfondimento, i seguenti argomenti:
– Rifiuti e loro classificazione;
– Raccolta Differenziata;
– Disposizioni legislative in materia di RD;
– Tipologie e modalità di espletamento del servizio RD;
– Materiali oggetto di RD;
– Imballaggi;
– Convenzioni con i Consorzi CONAI;
– Controlli di qualità;
– C.C.R./ Isole ecologiche,
– Nuovo servizio di raccolta integrata dei rifiuti: modalità consegna kit e loro corretto utilizzo.
|
| 7- la realizzazione di badge e divise per i volontari tali da consentire all’utente una chiara identificazione dell’operatore incaricato alla consegna tramite apposito cartellino di riconoscimento con foto e indicazione della qualifica. Solo nei comuni del primo step hanno collaborato con questa Società 11 associazioni diverse per un totale di n. 115 volontari che hanno prestato il loro prezioso servizio sul campo.
| COMUNE |
ASSOCIAZIONE |
N. VOLONTARI |
| BRONTE |
RANGERS SICILIA |
16 |
| BRONTE |
ASS. NAZ. GIACCHE VERDI |
6 |
| BRONTE |
CONFR. DI MISERICORDIA |
15 |
| BRONTE |
ASS. IRIDE |
14 |
| BRONTE |
CHARITAS UNITALSI |
15 |
| BRONTE |
GRUPPO S. GIUSEPPE COOP. SOCIALE |
10 |
| MANIACE |
ASS. IALITE ONLUS |
5 |
| RANDAZZO |
VOLONTARI PER LA PROT.CIVILE |
6 |
| RANDAZZO |
AROT |
9 |
| RANDAZZO |
ASS. IRIDE |
7 |
| RANDAZZO |
CONFR. DI MISERICORDIA |
12 |
|
|
8- l’allestimento di postazioni dedicate alla consegna kit gestite dai volontari con il coordinamento di Joniambiente. La fase di distribuzione si è svolta comunque tenendo conto delle specifiche esigenze rilevate attraverso 3 sistemi:
– consegna presso le postazioni dedicate;
– consegna a domicilio laddove necessario e funzionale, per far fronte alle richieste inoltrate tramite il Numero Verde o ai Comuni da parte di cittadini impossibilitati al ritiro quali anziani, disabili, ecc..
– consegna presso taluni uffici comunali ai quali ne è stata destinata una riserva.
Presso ciascuna postazione, inoltre, è stato consegnato ai volontari un manuale informativo da poter consultare per rispondere nel modo più completo e pertinente ai dubbi e alle perplessità degli utenti.
Si annovera, inoltre, l’opera di sensibilizzazione a 360 gradi che le associazioni hanno portato avanti anche presso la propria sede fungendo da prezioso supporto ai cittadini soprattutto nelle prime fasi di avvio della raccolta;
|
| 9- la realizzazione di una campagna di informazione telefonica rivolta a tutte le utenze titolari di un abbonamento fisso nonché l’aggiornamento costante degli operatori del Numero Verde su tutte le novità introdotte.
Considerato che una comunicazione integrata presuppone la predisposizione di mezzi e strumenti che consentano un feedback è stato scelto questo strumento che, oltre a completare la funzione svolta dalla lettera informativa inviata per posta, ha stabilito e promosso un’interazione e un dialogo quanto mai proficuo rispondendo nell’immediato agli eventuali dubbi o curiosità di ciascun utente ricordando la possibilità di contattare, per qualsiasi necessità o segnalazione, il Numero Verde societario (si stima che siano sono state contattate almeno 9800 utenze per ben 3 volte); |
| |
| 10- la diffusione di spot tv sulle principali emittenti televisive locali. Nelle fasce orarie di maggiore ascolto, le emittenti tv locali hanno trasmesso, ad intervalli frequenti, gli spot televisivi a spiccata impronta didattico-didascalica realizzati appositamente per l’avvio del nuovo servizio.
La messa in onda di tali spot è stata programmata su una piattaforma trimestrale coinvolgendo le seguenti emittenti locali:
– La Società Cooperativa Ciclope Bronte, che ha trasmesso gli spot sul nuovo servizio ben 15 volte al giorno, e soltanto nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 13, ha trasmesso comunicazioni ed informazioni sul nuovo servizio esattamente ogni 20 minuti;
– L’emittente TV “TGR” Telegiornale Randazzo, che registra un bacino di utenza di 35.000 abitanti, ha mandato in onda gli spot televisivi ben 18 volte al giorno, inserendoli nei momenti di maggiore ascolto del palinsesto;
– L’emittente Televideorandazzo che raggiunge l’utenza dei seguenti comuni: Bronte, Maletto, Maniace, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa e Piedimonte Etneo, ha previsto 12 passaggi giornalieri;
– L’emittente Prima TV, con i suoi 35 mila contatti giornalieri registrati e un bacino d’utenza che si estende da Giarre, passando per la fascia etnea, fino a Taormina, ha trasmesso gli spot 12 volte al dì;
si annovera, inoltre, la registrazione di diversi redazionali inerenti il nuovo servizio, in particolare sono state registrate vere e proprie lezioni sulla raccolta differenziata ad opera dal personale della Joniambiente, ripetutamente diffuse dalle emittenti televisive negli orari di maggiore ascolto e comunque non meno di 2 volte al giorno;
|
| 11- la messa in onda di messaggi informativi sul nuovo servizio in forma grafica e testuale per comunicare tutti gli avvisi attinenti l’avvio del nuovo servizio e le sue fasi propedeutiche. All’interno della grafica informativa sul nuovo servizio sono stati inseriti tutti i comunicati redatti. L’emittente TV “TGR” Telegiornale Randazzo, ad esempio, ha previsto addirittura 60 di questi passaggi al dì;
|
| 12- la diffusione di spot di sensibilizzazione via radio tramite la principali emittenti radiofoniche presenti sul territorio dell’ATO.
– La Società Cooperativa Ciclope Bronte ha diffuso lo spot ben 15 volte al giorno oltre a riservare appositi spazi alle comunicazioni della società;
– Radio Studio 7 ha previsto 20 passaggi al giorno oltre a 4 spazi interamente dedicati alla società.
13- la redazione e la diffusione di comunicati stampa numerosi, costanti, puntuali e dettagliati.
Un’informazione puntuale e aggiornata è stata garantita anche attraverso il Gazzettino di Giarre, settimanale di informazione diffuso nella fascia territoriale che si estende da Acireale e l’acese in genere, passando per i territori compresi tra Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia, Calatabiano (solo in queste porzioni territoriali registrano 4 mila copie distribuite) e raggiungendo i Comuni etnei fino alle zone dell’Alcantara. Sono state 5 le pagine speciali, organizzate nell’ambito di una campagna pubblicitaria dedicata al servizio di raccolta integrata dei rifiuti, modulando gli spazi a disposizione sulla scorta dell’esigenza di fornire il maggior numero di dettagli: modi e tempi del nuovo servizio; destinazione dei rifiuti suddivisa per tipologia, stato della distribuzione dei kit sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.
|
| 14- numerosi incontri didattici e di sensibilizzazione nelle scuole sono stati tenuti, su iniziativa della società, dal dirigente Antonino Germanà. Si annovera, inoltre, il progetto di sensibilizzazione EcoAlbero che, in occasione delle festività natalizie, ha coinvolto le scuole dell’infanzia e primarie dell’ATO CT1 rappresentando un ulteriore motivo di incontro atto a promuovere l’imminente avvio del servizio di raccolta integrata;
15- l’aggiornamento costante e la promozione del sito internet quale moderno strumento di dialogo con gli utenti, con la predisposizione di un apposito format sulla home page per consentire l’ inoltro di messaggi e segnalazioni e la possibilità di consultare e scaricare il Prontuario sul corretto conferimento dei rifiuti;
|
|
Tra le altre iniziative realizzate nel corso dell’anno meritano, inoltre, di essere annoverate:
– l’attività di collaborazione con Tetra Pak Italia con invio di gadget da distribuire agli alunni delle scuole coinvolti nei vari progetti di sensibilizzazione;
– la partecipazione al Salone dell’Ambiente svoltosi dal 13 al 22 aprile presso la galleria del centro commerciale Conforama di Riposto con distribuzione di materiale informativo;
– la sponsorizzazione delle manifestazioni: “Tuttoinunanottegiarrese” promossa dalla Proloco di Giarre in occasione della ricorrenza del 2 giugno e “Riposto we care” promossa dal CNGEI Riposto per la pulizia dei nostri litorali.
|
DELIBERE ASSEMBLEA DEI SOCI
ASSEMBLEA DEI SOCI 13 settembre 2004
Ordine del Giorno:
- Dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nomina componente Consiglio di Amministrazione riservato alla Provincia Regionale (art. 2458 codice civile)
Sono presenti in proprio:
Il Sindaco del Comune di Giarre
Il Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
Sono presenti per delega:
Il Sindaco del Comune di Bronte
Il Sindaco del Comune di Randazzo
Considerato che il capitale rappresentato dai presenti è esiguo ed insufficiente e, poiché manca la necessaria informazione sugli oggetti posti all’ordine del giorno, la seduta viene rinviata al 18 settembre 2004
ASSEMBLEA DEI SOCI 18 settembre 2004
Ordine del Giorno:
Ripresa lavori della seduta precedente del 13 Settembre 2004, ovvero:
- Dimissioni Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Nomina componente Consiglio di Amministrazione riservato alla Provincia Regionale (art. 2458 codice civile)
Sono presenti in proprio:
Il Sindaco del Comune di Bronte
Il Sindaco del Comune di Giarre
Il Sindaco del Comune di Maletto
Il Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
Il Sindaco del Comune di Randazzo
Il Sindaco del Comune di Sant’Alfio
Sono presenti per delega:
Il Sindaco del Comune di Linguaglossa
Il Sindaco del Comune di Mascali
Il sindaco del Comune di Milo
Il Consiglio preso atto delle dimissioni irrevocabili del Presidente del Consiglio, Mario Spampinato, accoglie la proposta del Sindaco di Giarre, di voler eleggere nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mario Carmelo Zappia.
La votazione ha il seguente esito:
si esprimono a favore del dott. Mario Carmelo Zappia:
L’Amministrazione Provinciale
I Comuni di: Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Sant’Alfio.
Si astiene il Comune di Bronte
Nessun voto contrario
Quale componente del Consiglio di Amministrazione, viene designato, con determina del Presidente della Provincia Regionale di Catania On. Raffaele Lombardo, depositata in sede di Assemblea dall’Assessore della Provincia Calanducci, Francesco Rubbino.
La superiore nomina del componente del Consiglio di Amministrazione avviene contestualmente alla seduta ratificata dall’Assemblea.
Eletto nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione: Zappia Mario Carmelo, nato a Catania il 19 luglio 1962.
Nominato componente del Consiglio di Amministrazione: Rubbino Francesco, nato a Randazzo il 02 gennaio 1948.
ASSEMBLEA DEI SOCI 07 DICEMBRE 2007
Ordine del Giorno
Parte straordinaria:
- Proposta aumento del capitale sociale ad € 1.000.000,00 (Euro un milione/00)
- Modifica Statuto
Parte ordinaria:
- Nomina componenti Consiglio di Amministrazione
Sono presenti in proprio o per delega tutti i quindici Soci.
E’ presente l’Organo Amministrativo:
Dott. Mario Carmelo Zappia, Presidente Consiglio di Amministrazione.
Caruso Antonio, Vice Presidente
Cardillo Mario, Consigliere
Di Bella Giambattista, Consigliere
Grasso Mario, Consigliere
Parrinello Nunzio, Consigliere
Rubbino Francesco, Amministratore Delegato
E’ presente il Collegio Sindacale:
Bonaccorsi Roberto, Presidente
Barbagallo Salvatore, Sindaco effettivo
Caprino Campana Gaetano, Sindaco effettivo
L’Assemblea modifica l’art. 17 dello statuto sociale, in modo tale che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto di tre membri;
Considerato che la nomina di uno dei componenti, ai sensi dell’art. 2458 del codice civile, è riservata alla Provincia, l’Assessore Orazio Pellegrino nomina componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Nunzio Parrinello.
In rappresentanza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, viene proposto e nominato componente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Antonio Caruso.
L’Assemblea con i voti dei soci rappresentanti i Comuni di Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maniace, Milo, Randazzo e della Provincia Regionale, pari al 55,44% delle azioni, con l’astensione dei rappresentanti i Comuni di Bronte, Calatabiano, Maletto, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant’Alfio, nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mario Zappia.
A questo punto si eleggono il Presidente e il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Con i voti dei Soci rappresentanti i Comuni di Castiglione di Sicilia, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maniace, Milo, Randazzo e della Provincia Regionale, pari al 55,44% delle azioni, con l’astensione dei rappresentanti i Comuni di Bronte, Calatabiano, Maletto, Mascali, Piedimonte Etneo, Riposto, Sant’Alfio, viene nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mario Zappia, quale vice Presidente del C.d.A. il Consigliere Parrinello Nunzio, quale componente il sig. Antonio Caruso.
ASSEMBLEA DEI SOCI 03 AGOSTO 2009
Ordine del Giorno:
- Revoca Consiglio di Amministrazione, ex art. 2383 del codice civile; (su proposta dei seguenti Soci: Provincia Regionale di Catania, Comune di Bronte, Comune di Piedimonte Etneo, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Mascali, Comune di Maletto, Comune di Randazzo);
- Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione (su proposta dei seguenti soci: Provincia Regionale di Catania, Comune di Bronte, Comune di Piedimonte Etneo, Comune di Castiglione di Sicilia, Comune di Mascali, Comune di Maletto, Comune di Randazzo);
- Nomina Collegio Sindacale;
- nomina dei sindaci effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- Esame dei rilievi presentati da alcuni Soci nell’Assemblea del 03 luglio 2009;
- Bilancio al 31/12/2008, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione dei sindaci e deliberazioni relative.
Sono presenti:
- Provincia Regionale di Catania – Bulla Giovanni;
- Comune di Bronte – Sindaco Senatore Giuseppe Firrarello;
- Comune di Calatabiano – Sindaco Antonio Petralia;
- Comune di Castiglione di Sicilia – Sindaco Claudio Scavera;
- Comune di Fiumefreddo di Sicilia – Sindaco Sebastiano Nucifora;
- Comune di Giarre – Sindaco Teresa Sodano;
- Comune di Maletto – Sindaco Giuseppe De Luca;
- Comune di Maniace – Assessore Luigi Marino Grammazza;
- Comune di Mascali – Sindaco Filippo Monforte;
- Comune di Milo – Sindaco Giuseppe Messina;
- Comune di Piedimonte Etneo – Sindaco Giuseppe Pidoto;
- Comune di Randazzo – Sindaco Ernesto Del Campo;
- Comune di Riposto – Sindaco Carmelo Spitaleri;
- Comune di Sant’Alfio – Sindaco Salvatore Russo;
E’ presente l’organo amministrativo in persona del Presidente dott. Mario Carmelo Zappia e dei consiglieri signori: Caruso Antonio e Rubbino Francesco;
E’ presente il collegio sindacale in persona del Presidente Bonaccorsi Roberto e dei componenti sindaci: Barbagallo Salvatore e Caprino Campana Gaetano;
Il presidente Zappia dà inizio alla seduta esprimendo le proprie perplessità riguardo la richiesta di convocazione dell’Assemblea per la revova del C.d.A., decisione, secondo lo stesso, singolare, in quanto mossa da soci morosi nei confronti di un’amministrazione che comunque ha continuato a garantire un servizio di gestione rifiuti fra i migliori prestati nell’ambito della Regione siciliana, nonostante gli sforzi affrontati a causa del consistente debito maturato dalla maggioranza dei soci.
Il presidente informa, altresì, l’Assemblea che, su richiesta della stessa Joniambiente S.p.A., con decreto del Direttore dell’A.R.R.A. è stato nominato un Commissario ad acta nella persona del dott. Francesco Lo Cascio, il quale ha già potuto verificare la sana gestione della Società da parte del C.d.A. e dei vertici aziendali, nonostante la pesante situazione debitoria di alcuni enti locali soci.
Dopo quanto reso noto all’Assemblea, il presidente informa che, non essendoci giusta causa nella richiesta di revoca del C.d.A., non si esimerà dal richiedere un congruo risarcimento del danno da destinare a fini benefici.
Dopo le dichiarazioni del presidente seguono gli interventi di alcuni sindaci, che confermano, secondo quanto ribadirà sempre in seduta il dott. Zappia, il proprio convincimento che la richiesta non trova fondamento in ragioni tecniche, bensì in ragioni politiche.
Completati gli interventi, il Presidente mette ai voti la proposta di revoca del C.d.A., mediante voto palese ed appello nominale.
Ultimate le operazioni di voto, risultano favorevoli alla revoca del C.d.A. i comuni soci di: Bronte, Maletto, Mascali, Randazzo, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia e la Provincia Regionale di Catania, per un totale di azioni pari a 49.545;
Contrari alla revoca i comuni soci di: Giarre, Fiumefreddo di Sicilia, Sant’Alfio, Milo, Calatabiano e Maniace, per un totale di azioni pari a 35.739;
Astenuto il comune di Riposto, per un totale di azioni pari a 10.725;
Visto l’esito del voto, accertato e proclamato dal Presidente, l’Assemblea delibera di APPROVARE la revoca del Consiglio di Amministrazione.
Assume, a questo punto, la presidenza dell’Assemblea il dott. Bonaccorsi Roberto, presidente del Collegio Sindacale, il quale invita l’Assemblea a voler trattare gli ulteriori punti all’ordine del giorno.
Fa ingresso anche il rappresentante del comune di Linguaglossa;
Sono presenti di persona o per delega tutti i 15 soci, per un totale di n. 100.003 di azioni, pari al 100% dell’intero capitale sociale.
2° punto all’ordine del giorno: “Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione”.
I sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti indicano il loro candidato all’Assemblea, nella persona del signor Giuseppe Cardillo, nato a Mascali (Ct) il 17/09/1963;
La Provincia Regionale di Catania indica il proprio candidato, nella persona del signor Francesco Rubbino, nato a Randazzo il 02/01/1948.
Il sindaco di Riposto propone all’Assemblea, come terzo componente del consiglio di Amministrazione, il signor Antonio Caruso, nato a Koln (Germania) il 02/01/1970;
Il sindaco di Giarre propone all’Assemblea che venga eletto, come terzo componente del Consiglio di Amministrazione, la signora Calcabotta Rosaria.
Il sindaco di Fiumefreddo di Sicilia, ascoltate le superiori proposte, riferisce che, considerato che tra le proposte per il nuovo Consiglio di Amministrazione ci sono due dei componenti in carica al momento della mozione di sfiducia, la stessa è da ritenersi di natura politica, in quanto indirizzata solo al Presidente Zappia, seppur abbia operato sempre nel migliore dei modi, evitando qualsiasi interruzione del servizio anche in circostanze critiche, non imputabili allo stesso.
Si passa, quindi, alla votazione, che vede eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Rubbino Francesco, Cardillo Giuseppe e Caruso Antonio.
Si passa all’elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Sindaco di Maletto propone, quale Presidente, il signor Rubbino Francesco e quale vice Presidente il signor Antonio Caruso.
Il Sindaco di Fiumefreddo di Sicilia propone di nominare quale Presidente il signor Rubbino Francesco e quale vice Presidente il dott. Giuseppe Cardillo.
Si passa ai voti la prima proposta e a seguire la seconda, con il seguente risultato:
eletti al Consiglio di Amministrazione, fino alla data di approvazione del bilancio 2011:
- Rubbino Francesco, Presidente
- Caruso Antonio, vice Presidente
- Cardillo Giuseppe, componente
che dichiarano di accettare l’incarico.
Si passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno: “Nomina Collegio Sindacale”
I Sindaci dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti indicano all’Assemblea il dr Paparo Salvatore, nato a Calatabiano (Ct) il 13/09/1950;
La Provincia Regionale di Catania indica all’Assemblea il signor Capace Lorenzo, nato a Bronte il 12/05/1954;
Vengono eletti componenti effettivi del Collegio Sindacale il dott. Paparo Salvatore e il rag. Capace Lorenzo;
Quale terzo componente, il Sindaco di Giarre propone la dott.ssa Calcabotta Rosaria;
Il Sindaco di Maletto propone il dott. Bonaccorsi Roberto, già componente del Collegio Sindacale.
Espletata l’operazione di voto, viene eletto sindaco effettivo il Sig. Bonaccorsi Roberto.
Si passa, quindi, al voto, per le cariche specifiche del Collegio Sindacale, che vedono in lizza i signori:
Bonaccorsi Roberto;
Paparo Salvatore;
Capace Lorenzo;
Calcabotta Rosaria, Turnaturi Anna e Barbagallo Salvatore, quali Sindaci supplenti;
Dalle operazioni di voto viene eletto, fino alla data di approvazione del bilancio 2011, il Collegio Sindacale, di cui a seguire.
Bonaccorsi Roberto, Presidente; Paparo Salvatore, sindaco effettivo; Capace Lorenzo, sindaco effettivo; Turnaturi Anna, sindaco supplente; Barbagallo Salvatore, sindaco supplente;.
ASSEMBLEA DEI SOCI
06 MAGGIO 2010
Ordine del Giorno
Parte ordinaria:
- Trasferimento sede legale da Giarre – Strada 18 C.da Rovettazzo n. 14 a Corso Lombardia n. 101;
Parte straordinaria:
- Attuazione legge regionale n. 9 del 12 aprile 2010 art. 19 – Scioglimento e contestuale messa in liquidazione della Società;
- Numero dei liquidatori e regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità dei liquidatori;
- Nomina liquidatori con l’indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della Società;
- Criteri in base ai quali si deve procedere alla liquidazione.
Sono presenti di persona o per delega n. 10 Soci su 15.
E’ presente l’Organo Amministrativo, in persona di:
Rubbino Francesco, Presidente; Caruso Antonio, Consigliere; Cardillo Giuseppe, Consigliere.
E’ presente il Collegio Sindacale, in persona di: Bonaccorsi Roberto, Presidente;
Aperta la seduta dell’Assemblea e stabilita la necessità di deliberare il cambio della sede sociale della Società, come da ordine del giorno alla parte ordinaria, si passa alla disamina dei punti alla parte straordinaria.
Si delibera, pertanto, di
- Sciogliere la Società denominata Joniambiente S.p.A. e, conseguentemente, di metterla in liquidazione con effetto immediato;
- Di affidare la procedura di liquidazione ad un Organo Collegiale di tre membri, individuati nelle persone dei signori:
Rubbino Francesco, Caruso Antonio e Cardillo Giuseppe, già componenti dell’Organo Amministrativo;
- Di stabilire che il funzionamento del Collegio dei Liquidatori avverrà secondo le regole degli Organi Collegiali, con potere decisionale a maggioranza e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio del sig. Rubbino Francesco;
- Di conferire ai liquidatori tutti i più ampi ed opportuni poteri all’uopo occorrenti, ritenuti utili per la liquidazione della Società; Gli stessi dovranno adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico ottemperando a tutte le incombenze poste a loro carico (artt. 2490 e segg. Del codice civile); dovranno garantire il servizio di gestione integrata dei rifiuti fin quando il servizio non sarà affidato al nuovo soggetto giuridico di cui alla citata legge regionale n. 9/2010.
RASSEGNA STAMPA
 Loading...
Loading...




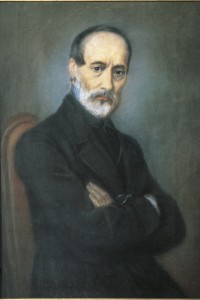




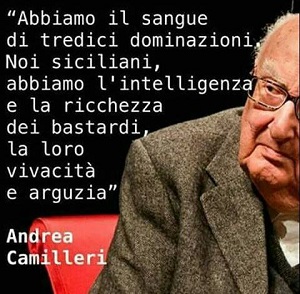

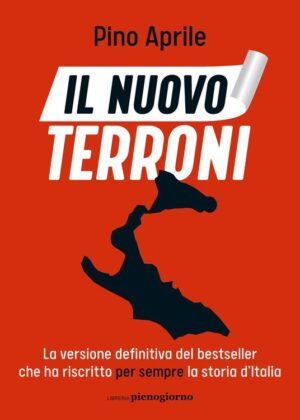
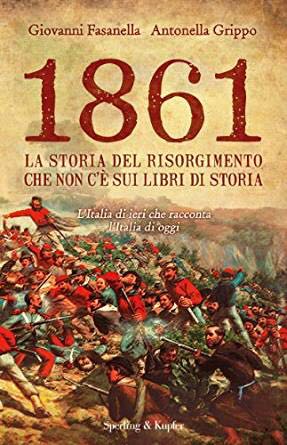
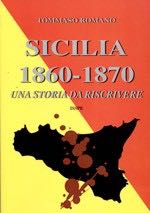
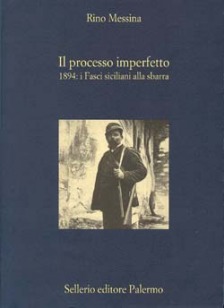
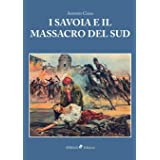
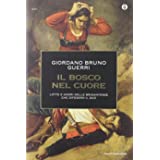
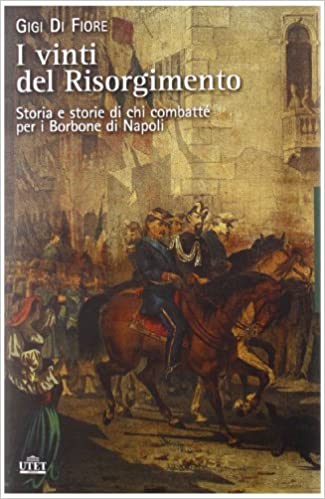
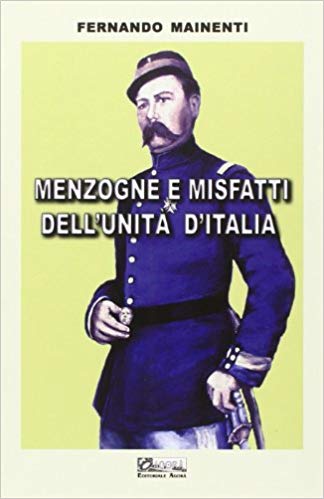
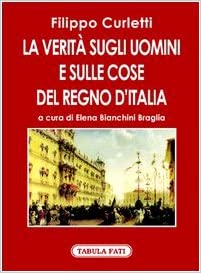
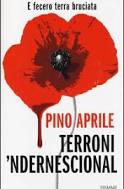
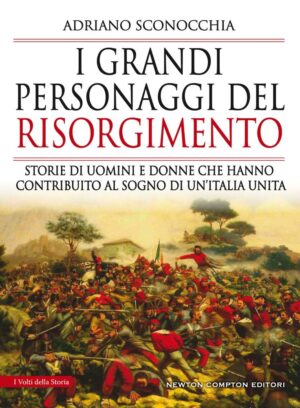
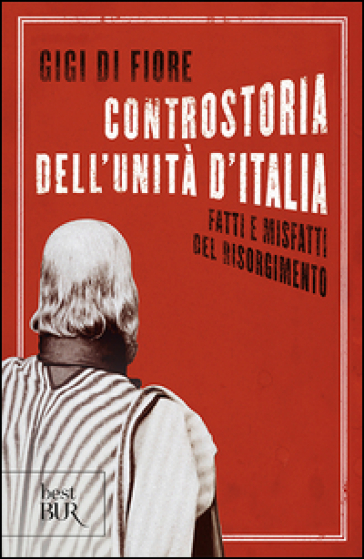
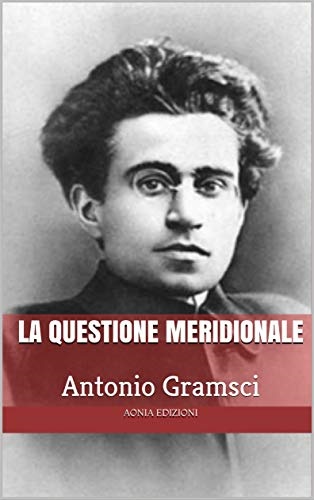
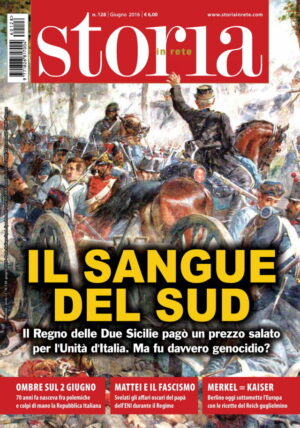


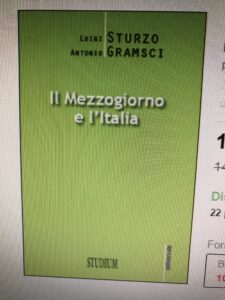
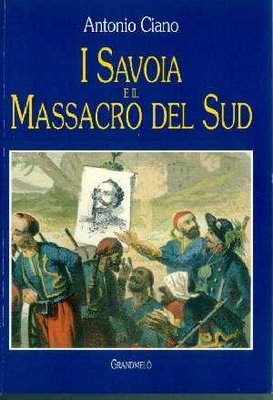
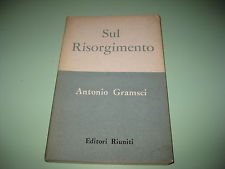
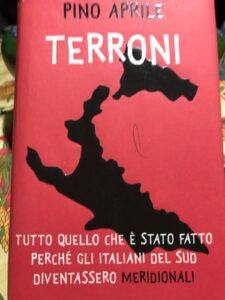


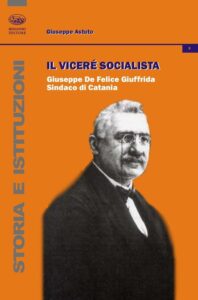
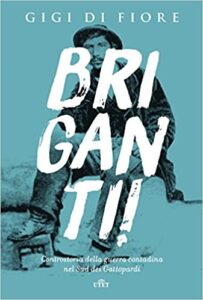
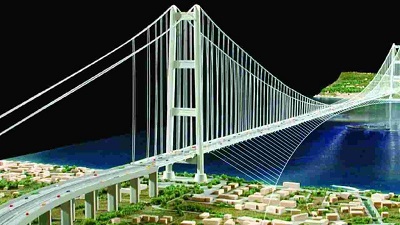



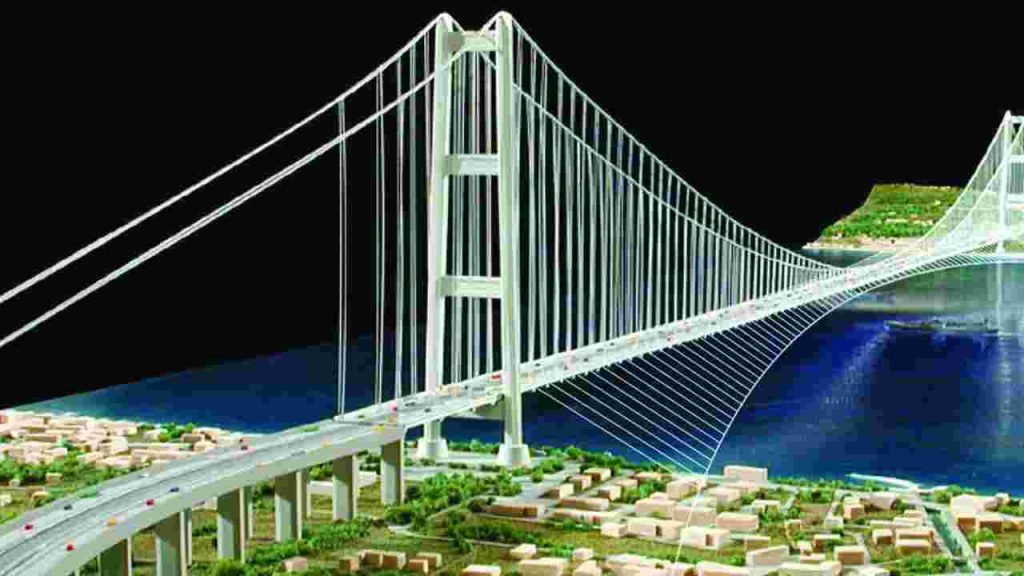





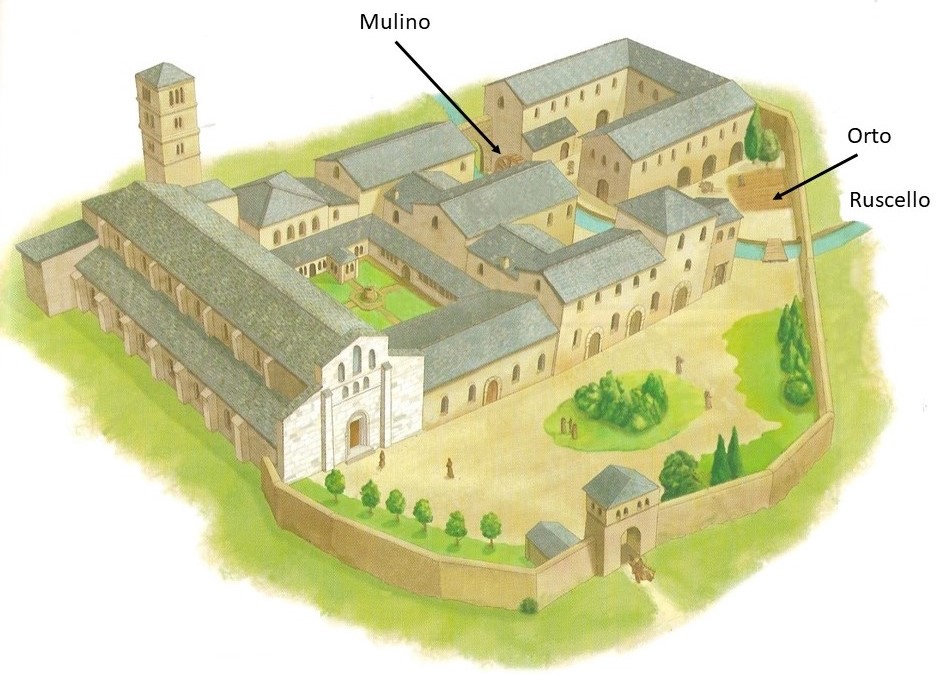
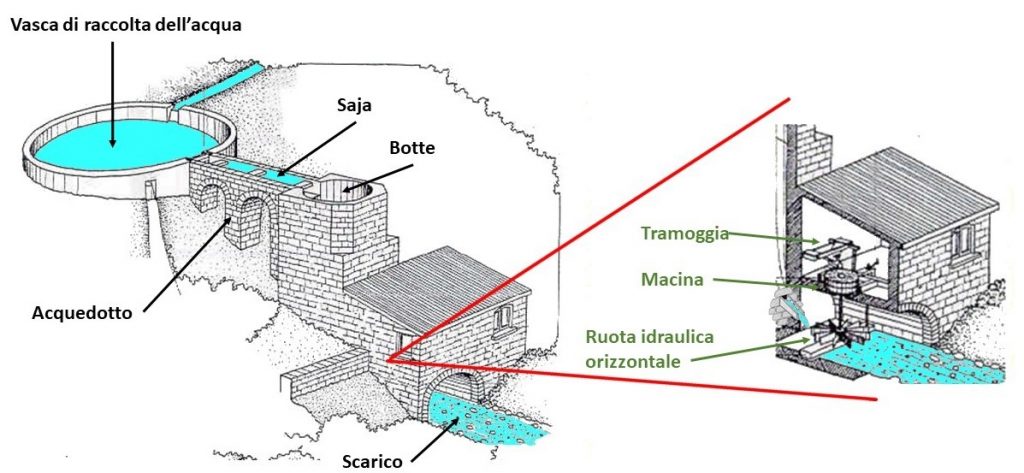




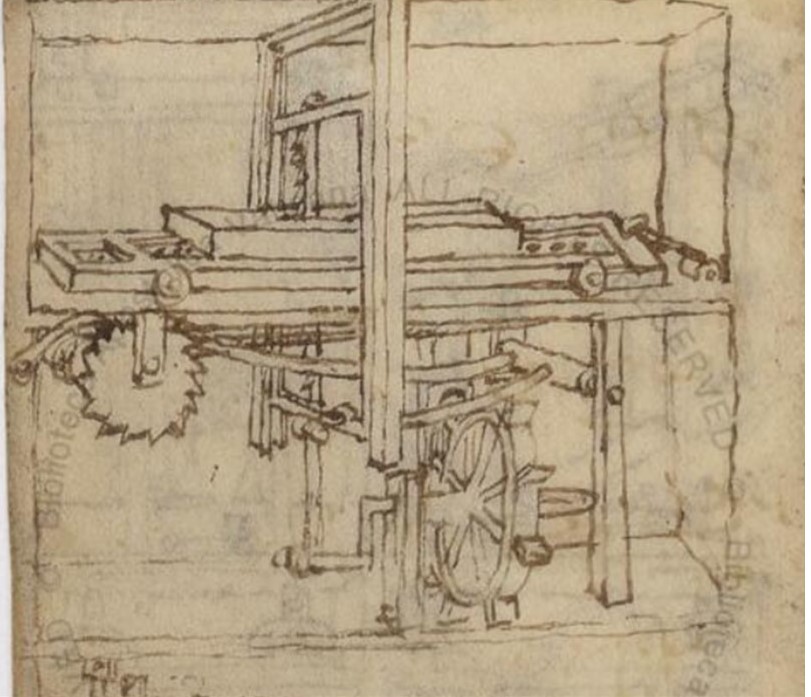
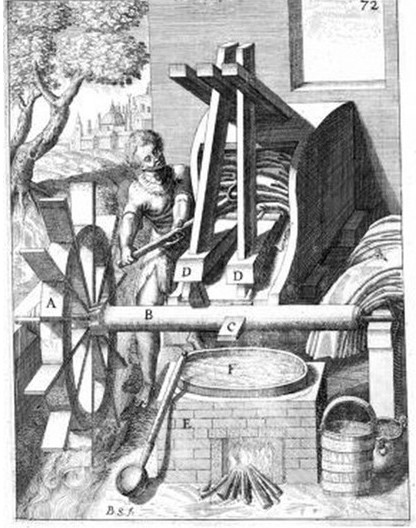
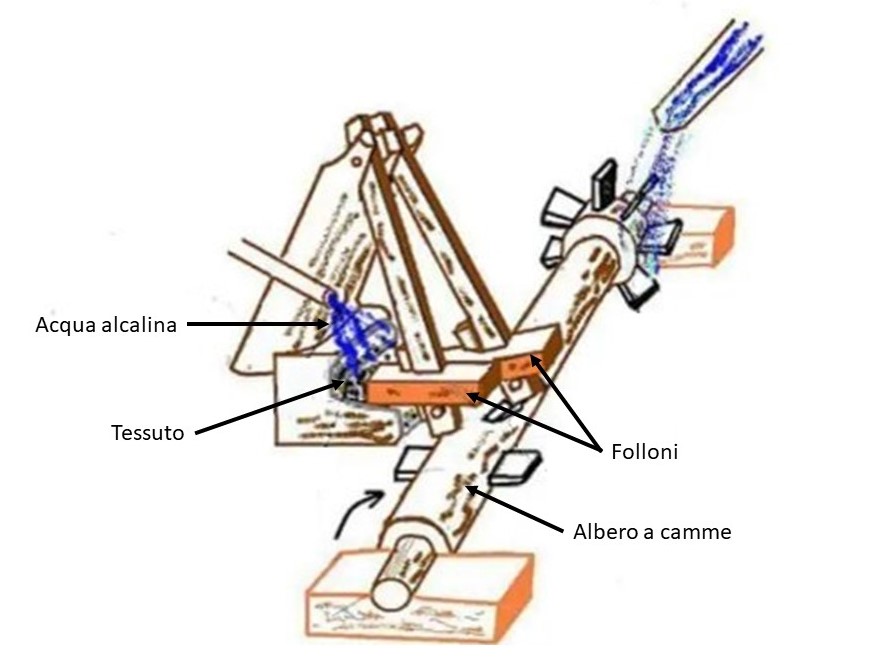
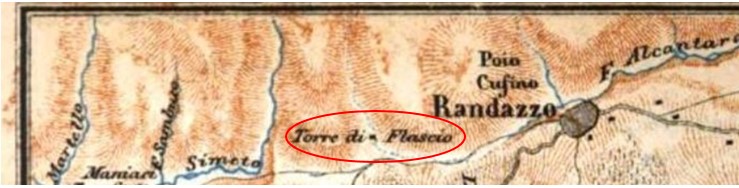
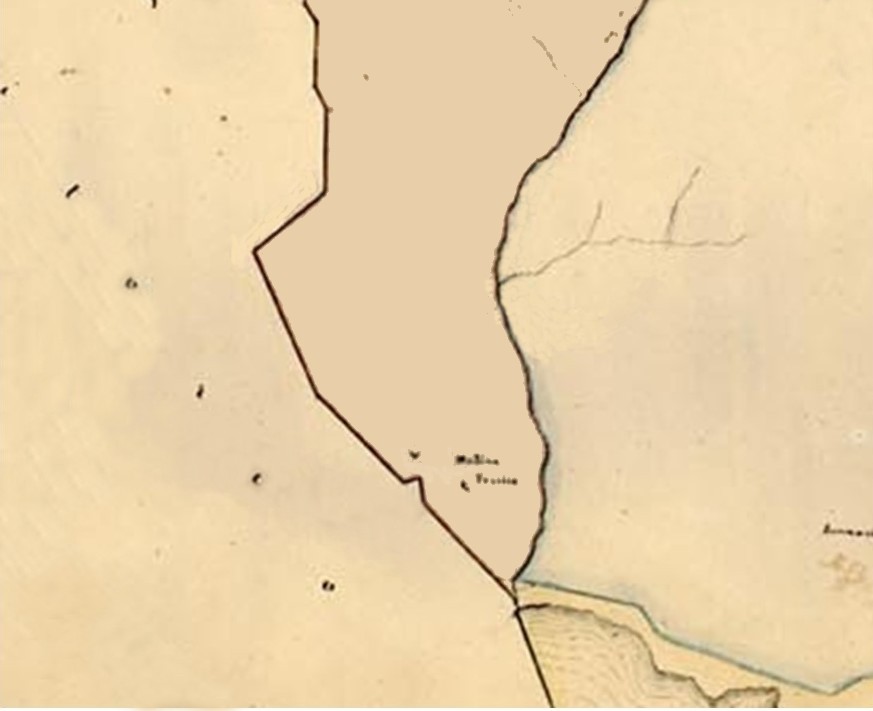



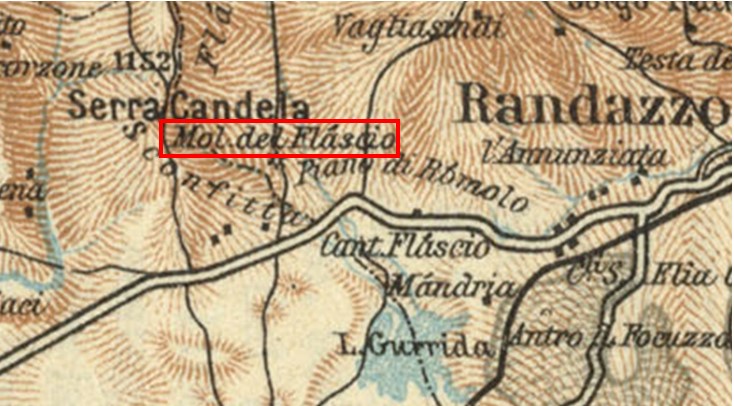



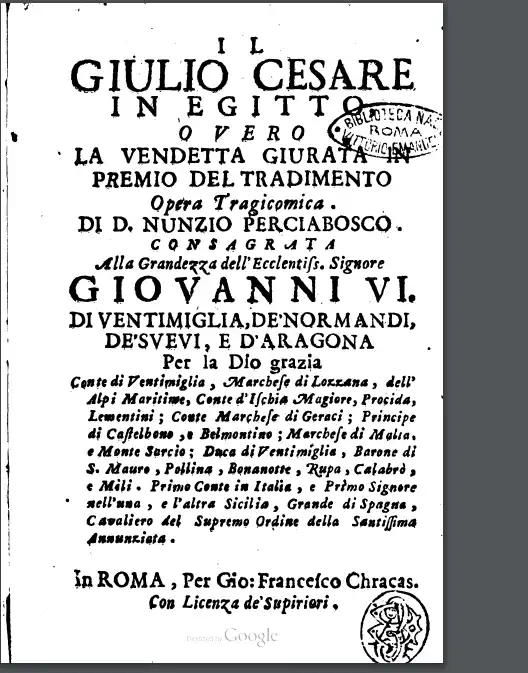
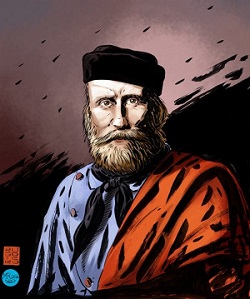
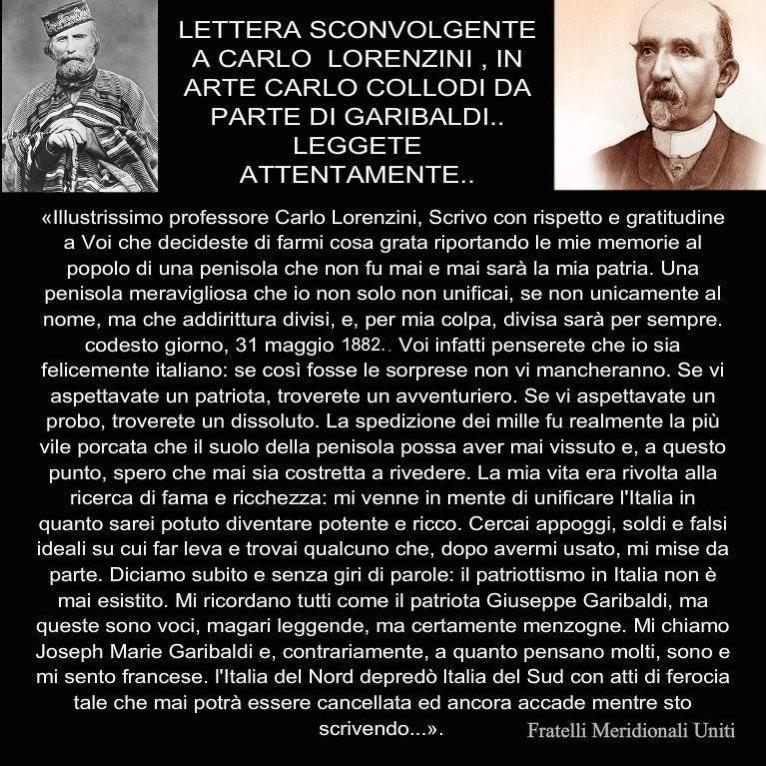

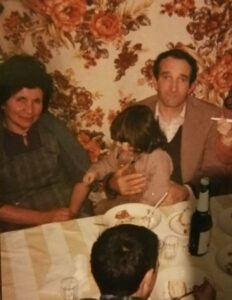






































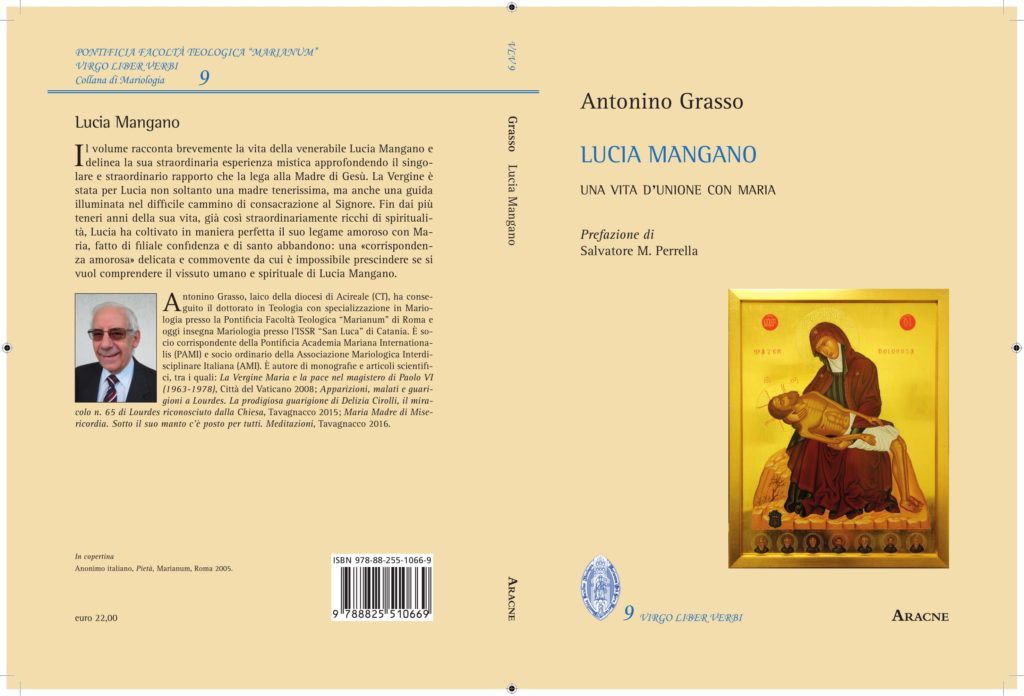




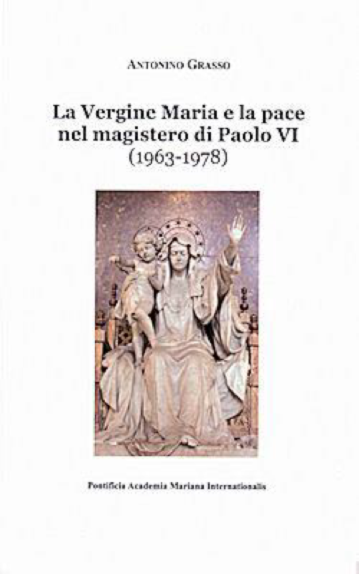

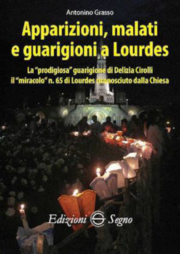
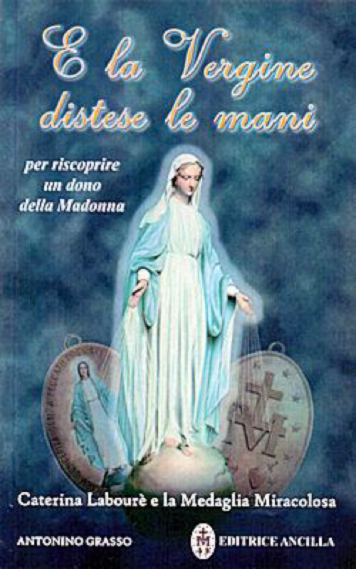
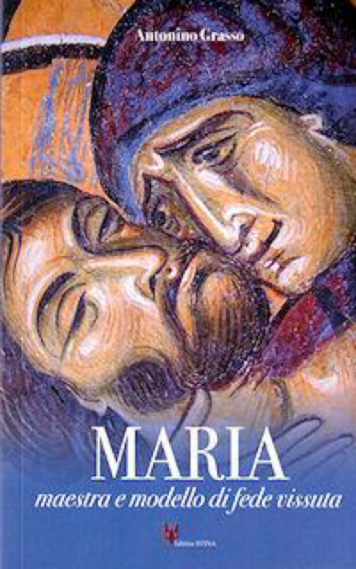
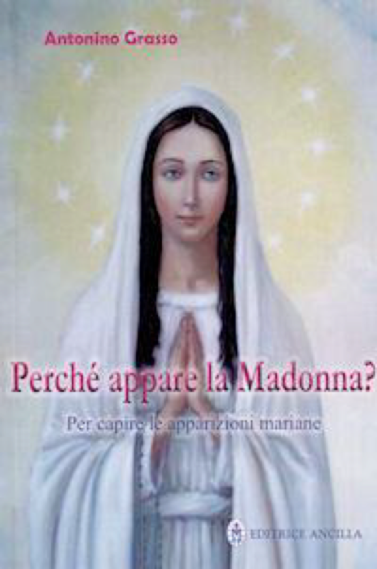
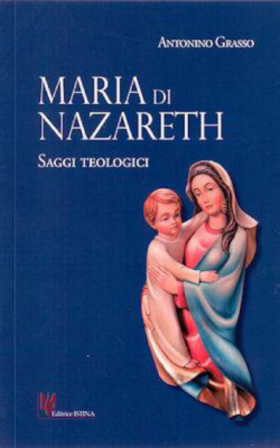
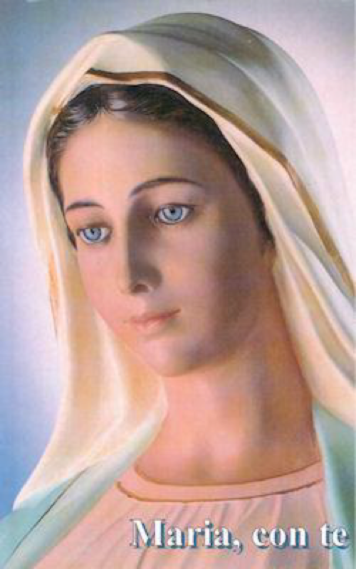









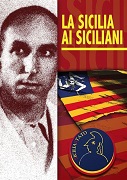
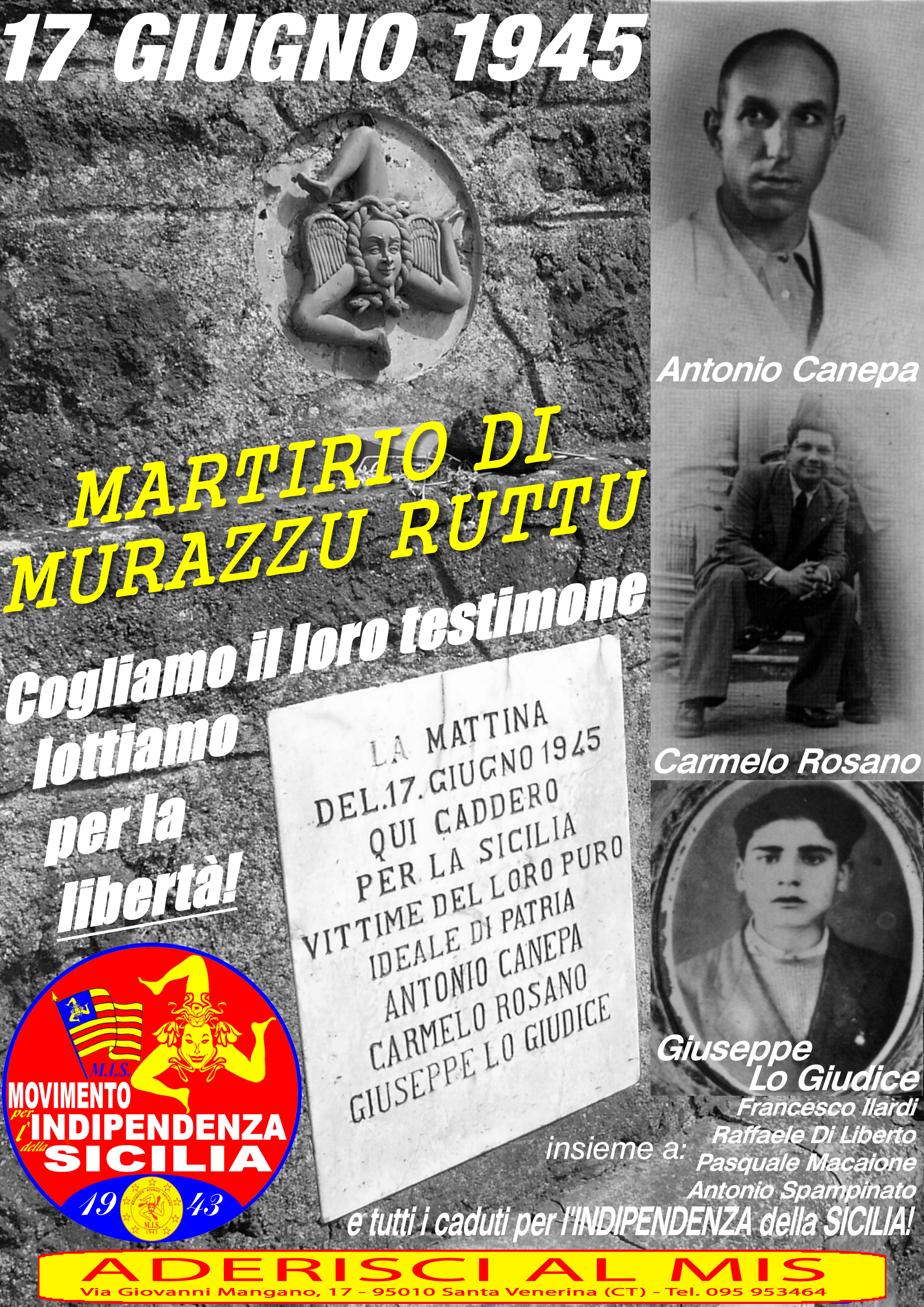

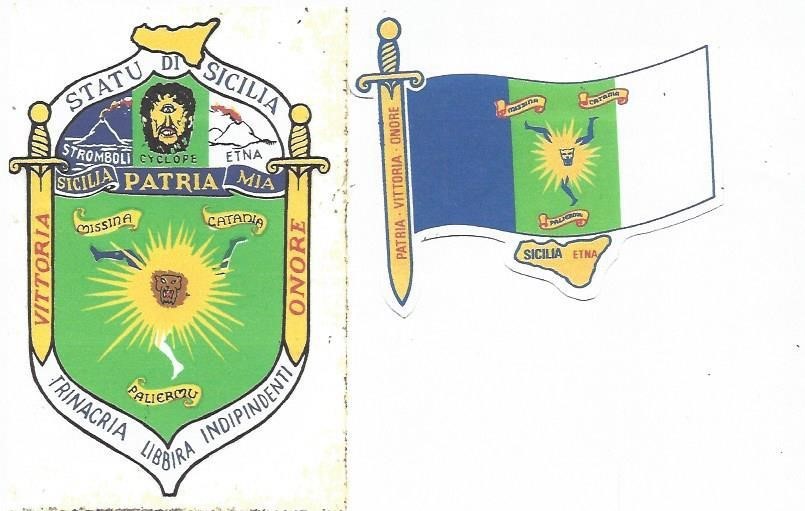


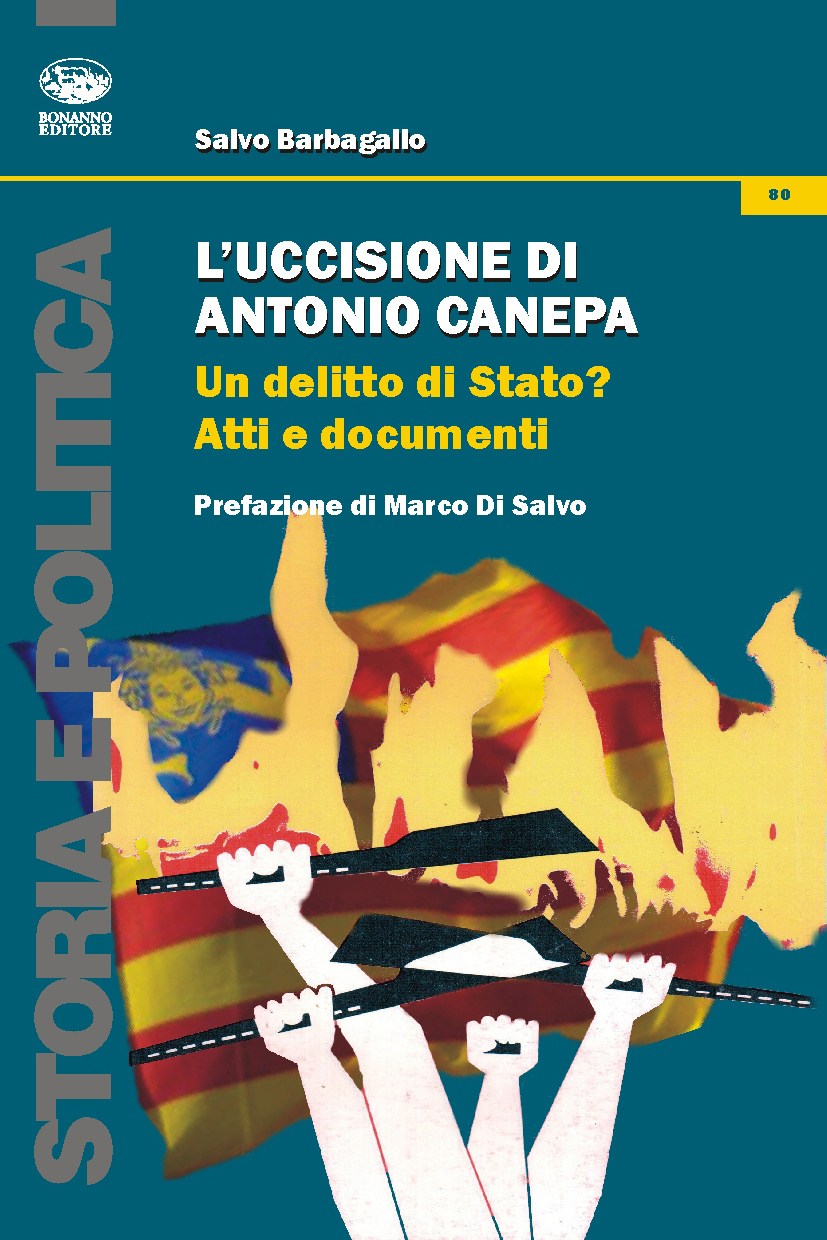

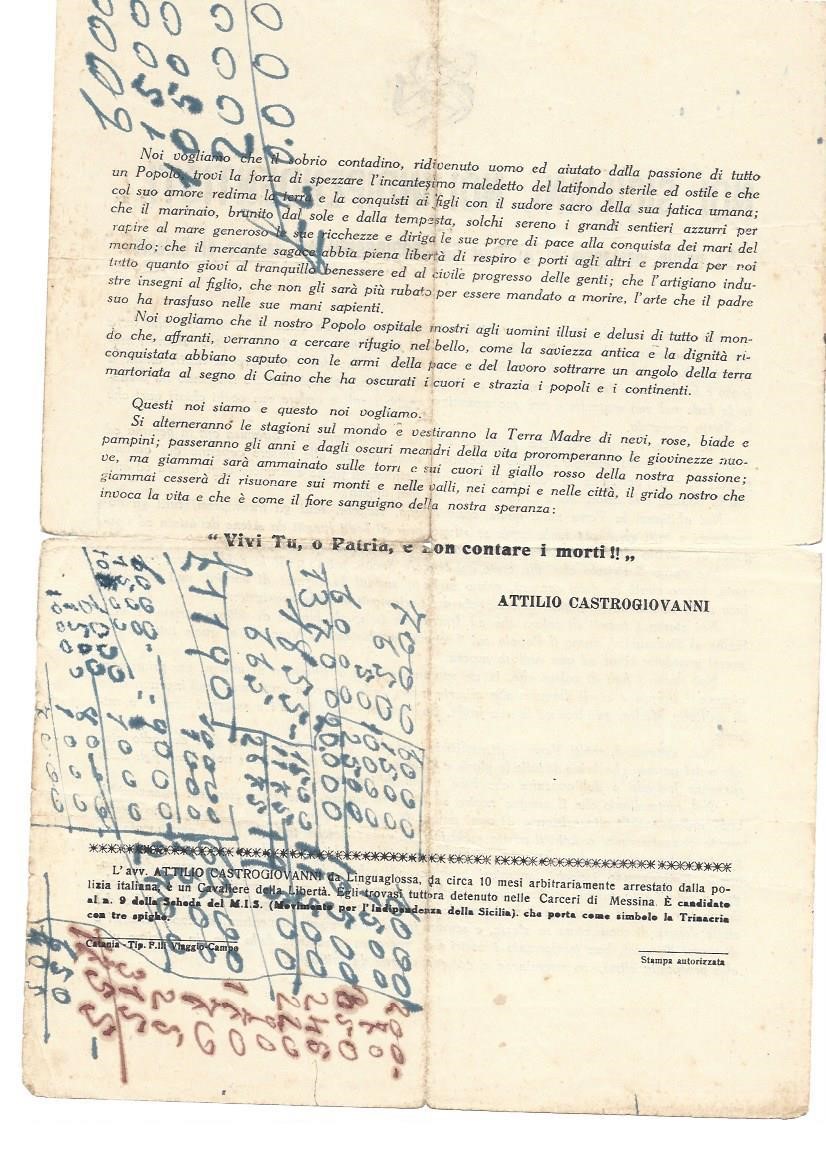 Il MIS continuò ad impegnarsi, come aveva sempre fatto, nell’organizzare i propri iscritti in sezioni territoriali, nell’ elaborare e nell’ approvare gli statuti interni del movimento.
Il MIS continuò ad impegnarsi, come aveva sempre fatto, nell’organizzare i propri iscritti in sezioni territoriali, nell’ elaborare e nell’ approvare gli statuti interni del movimento. 
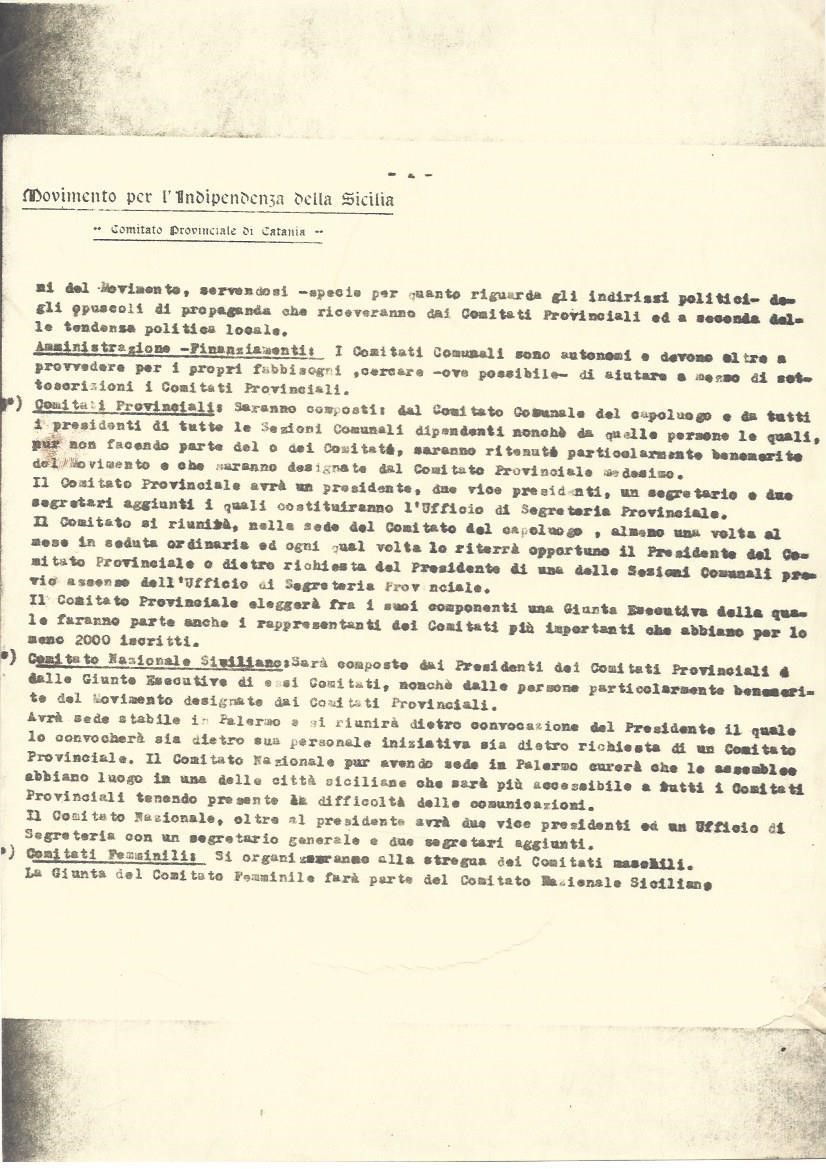
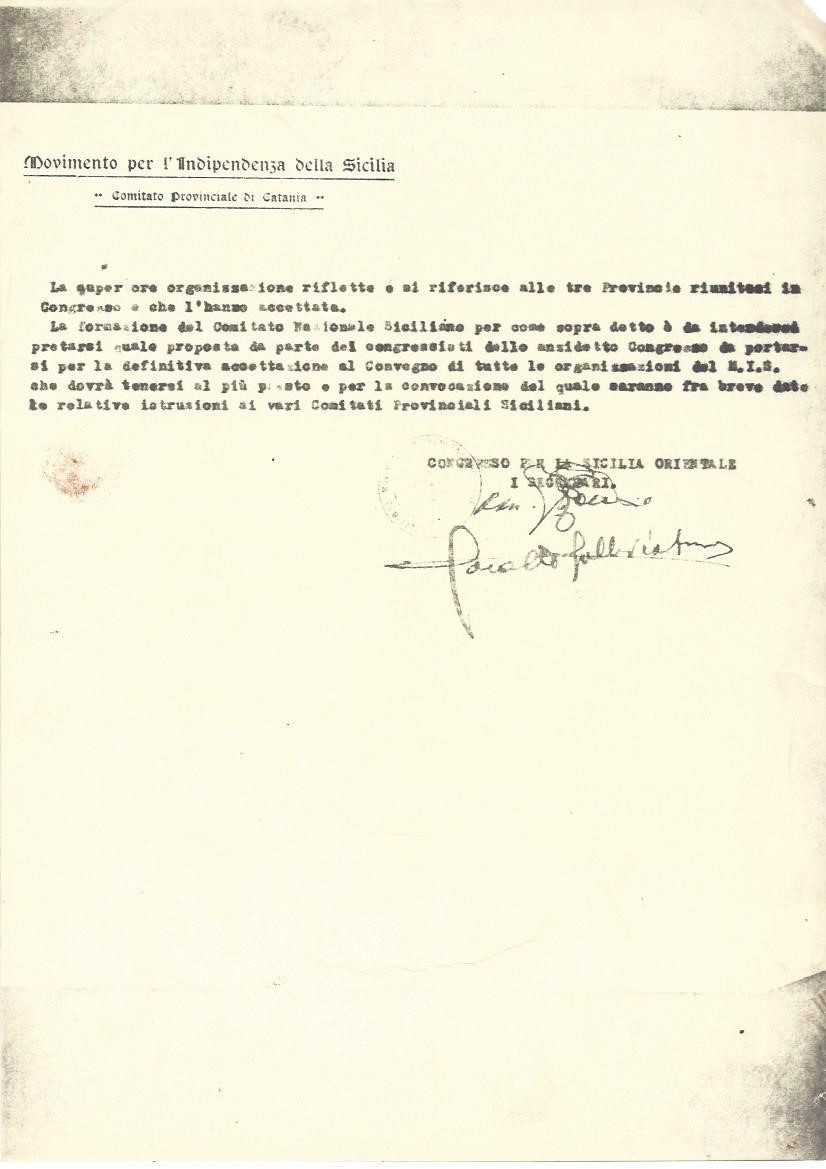


























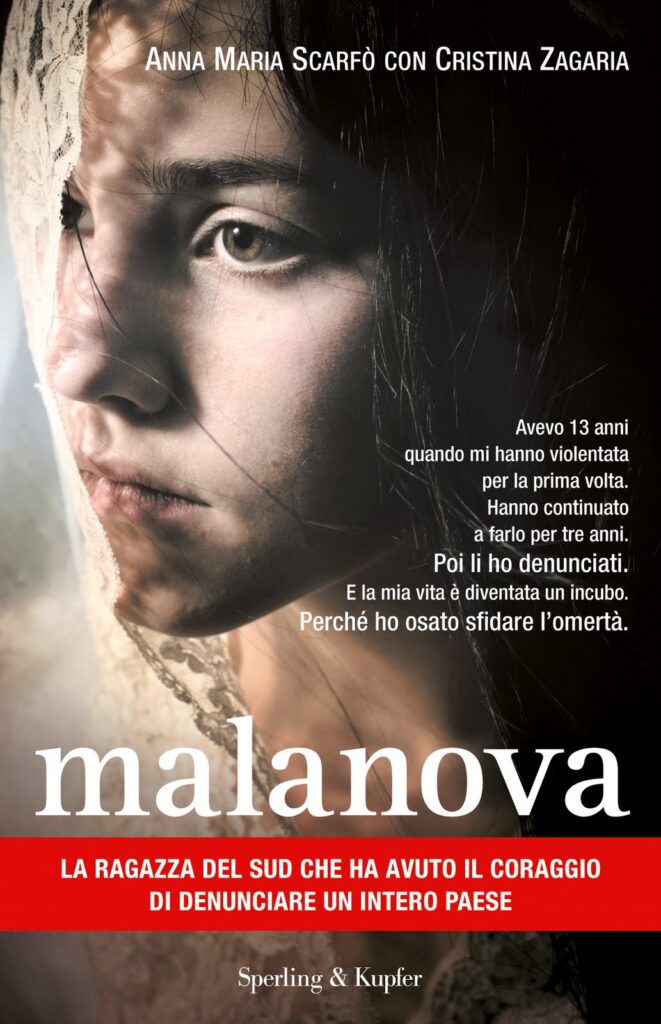











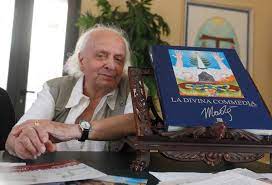



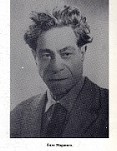



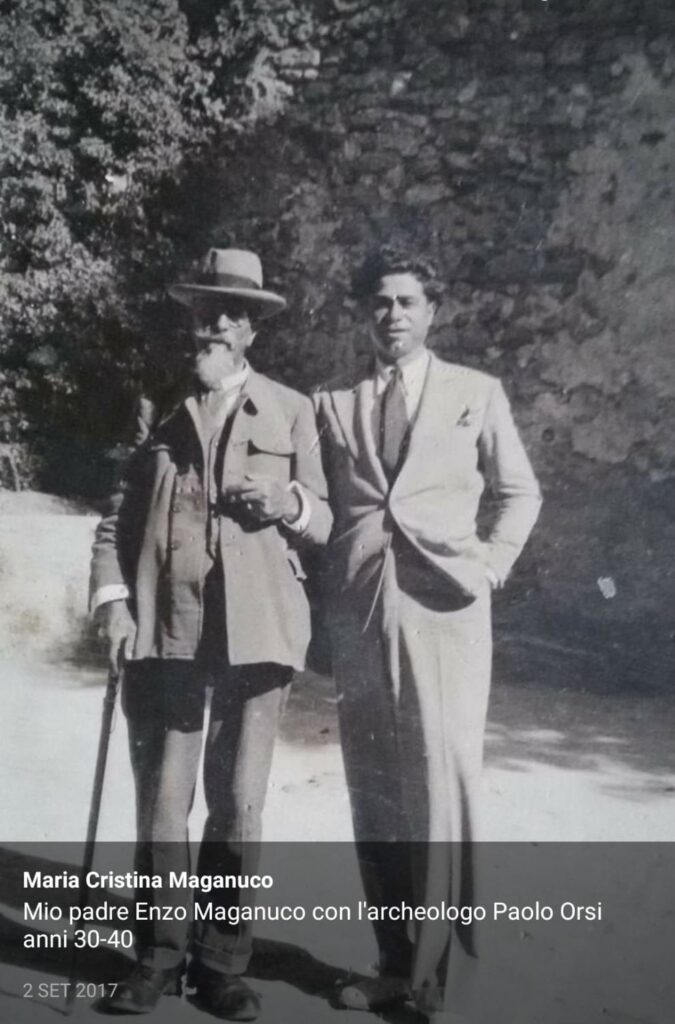

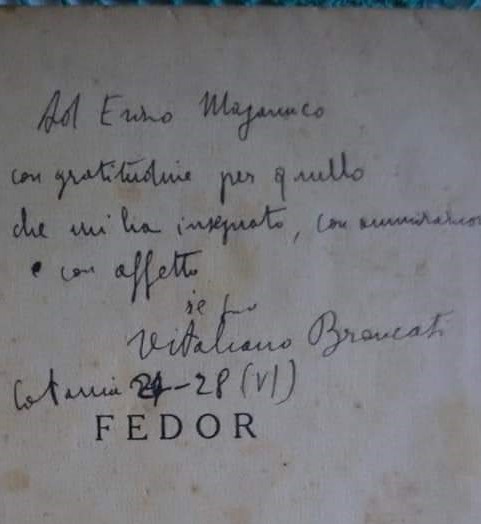




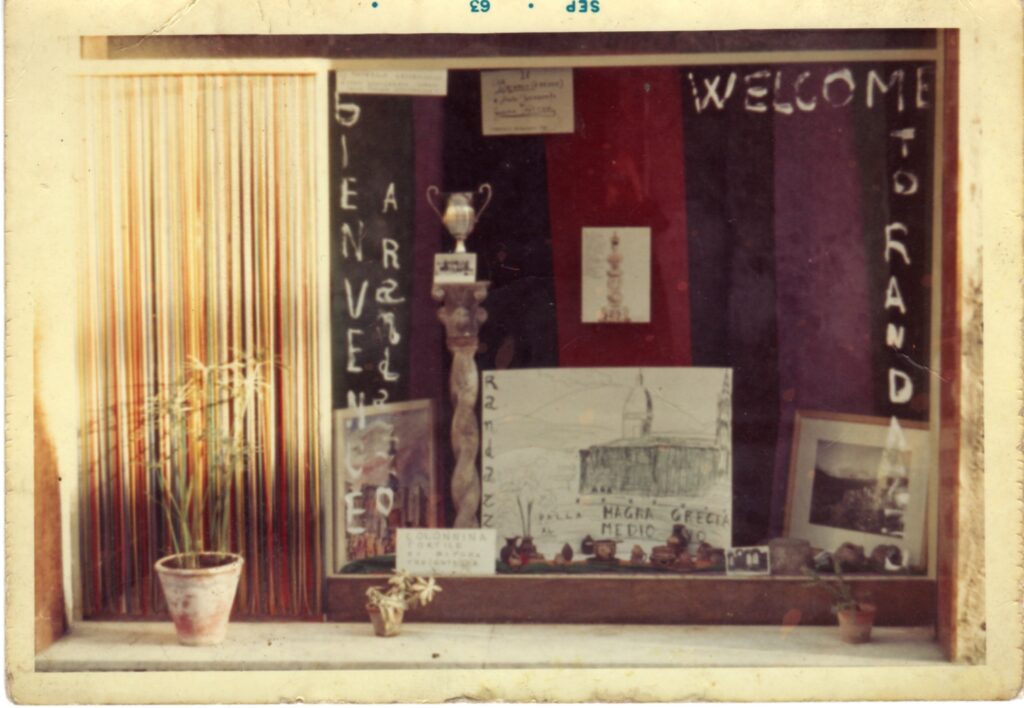






































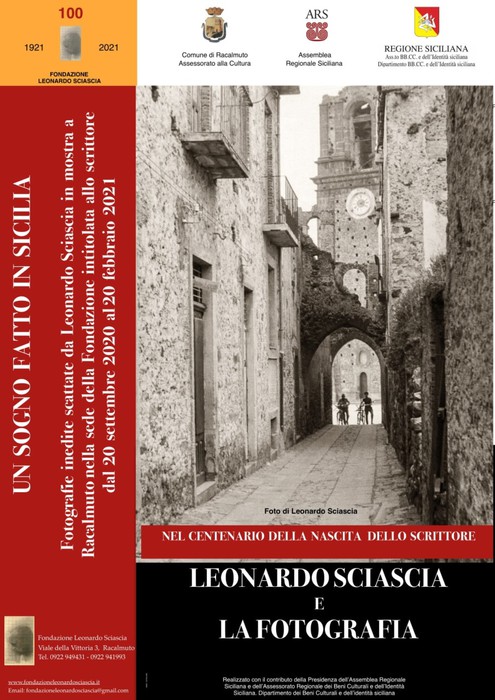


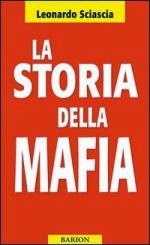

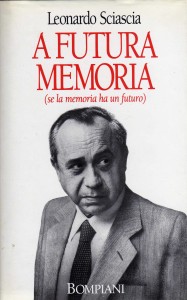
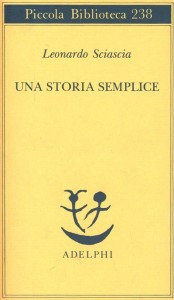
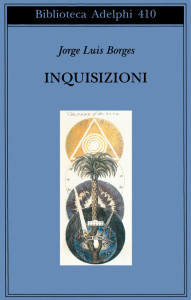
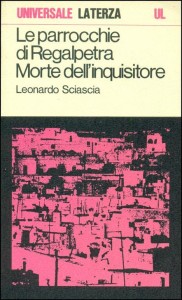
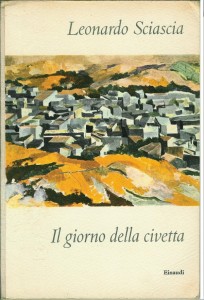





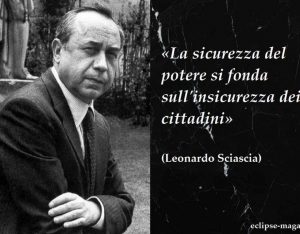
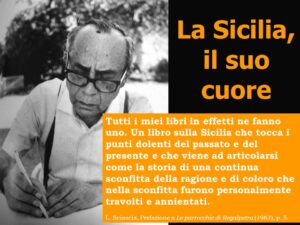



























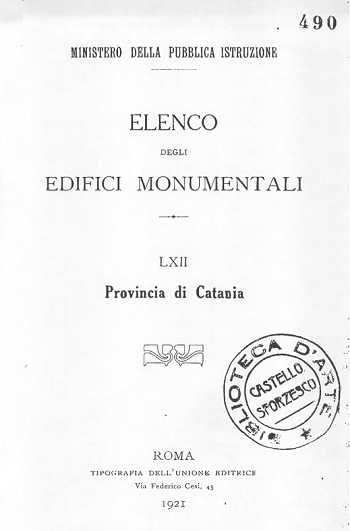







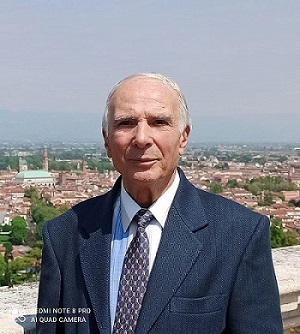







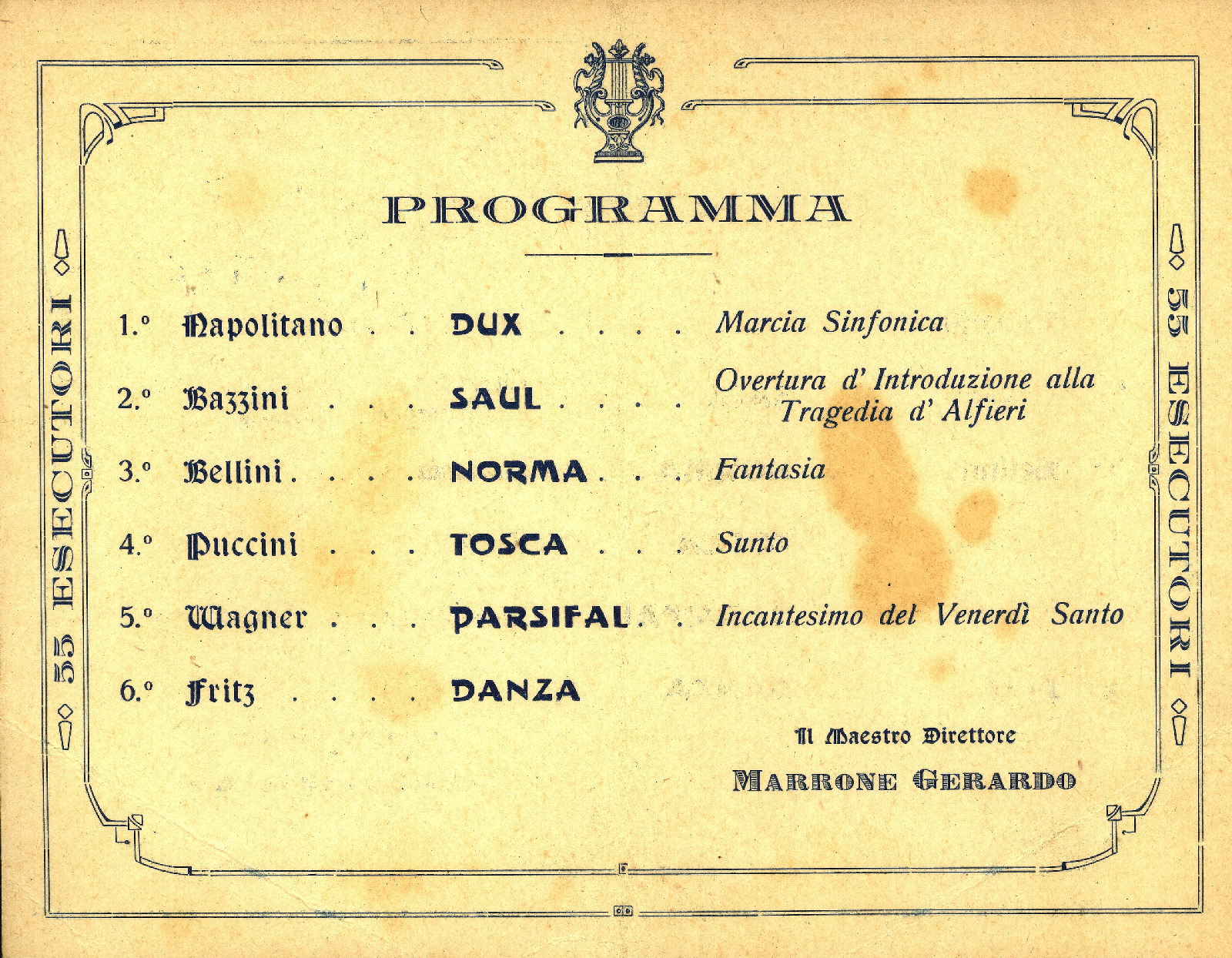



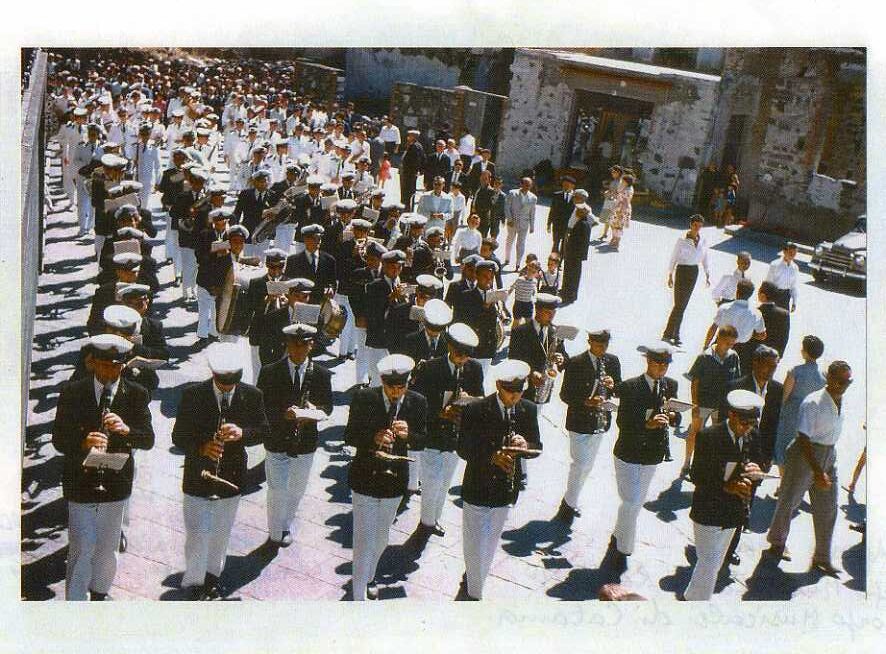






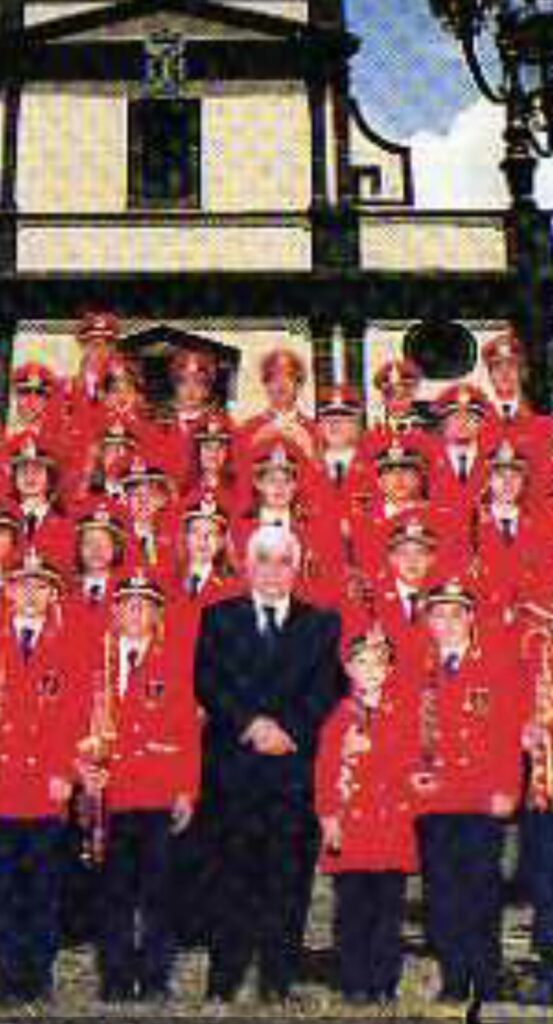

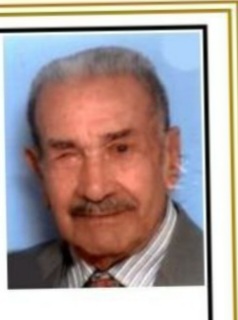

























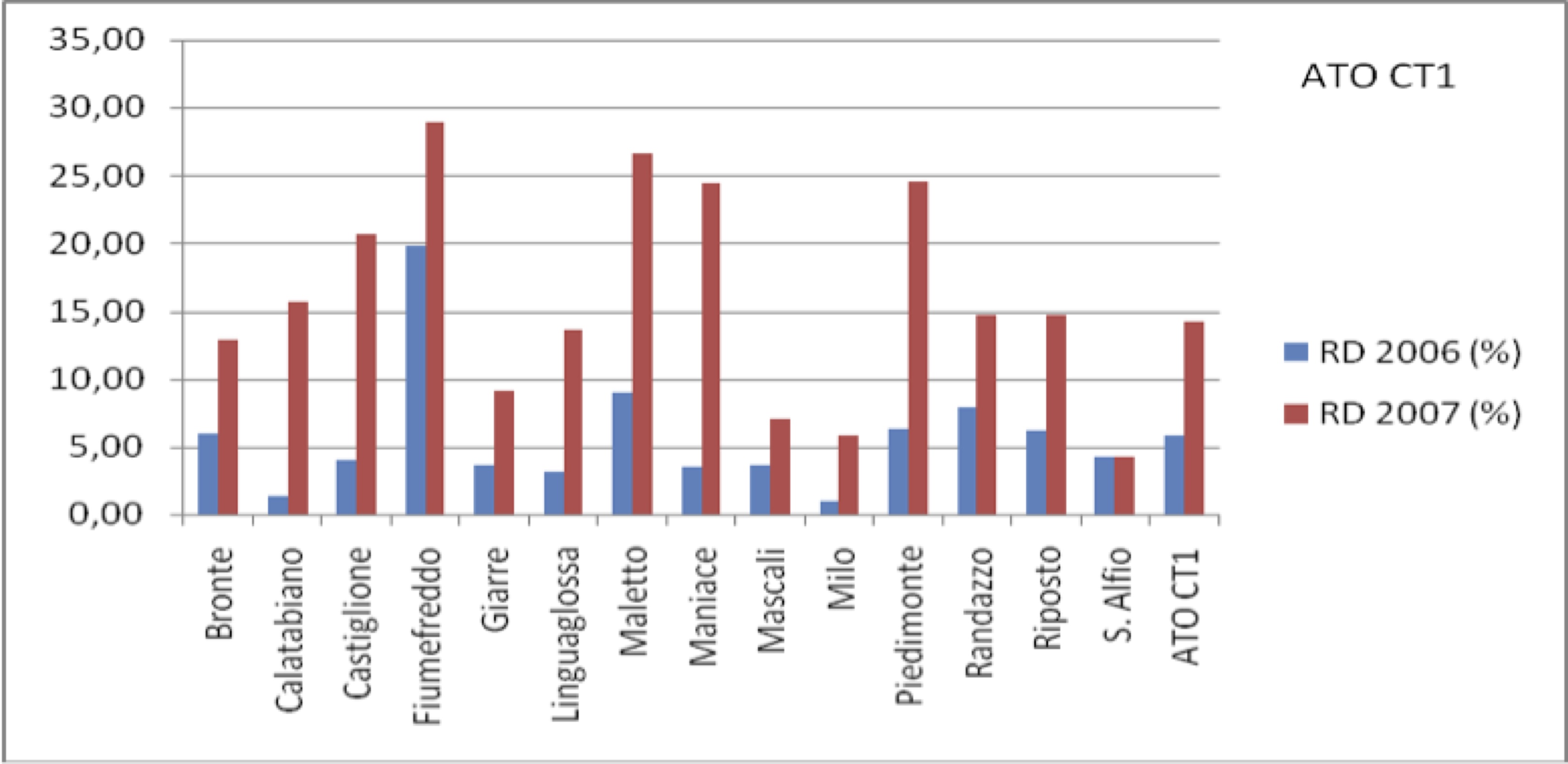
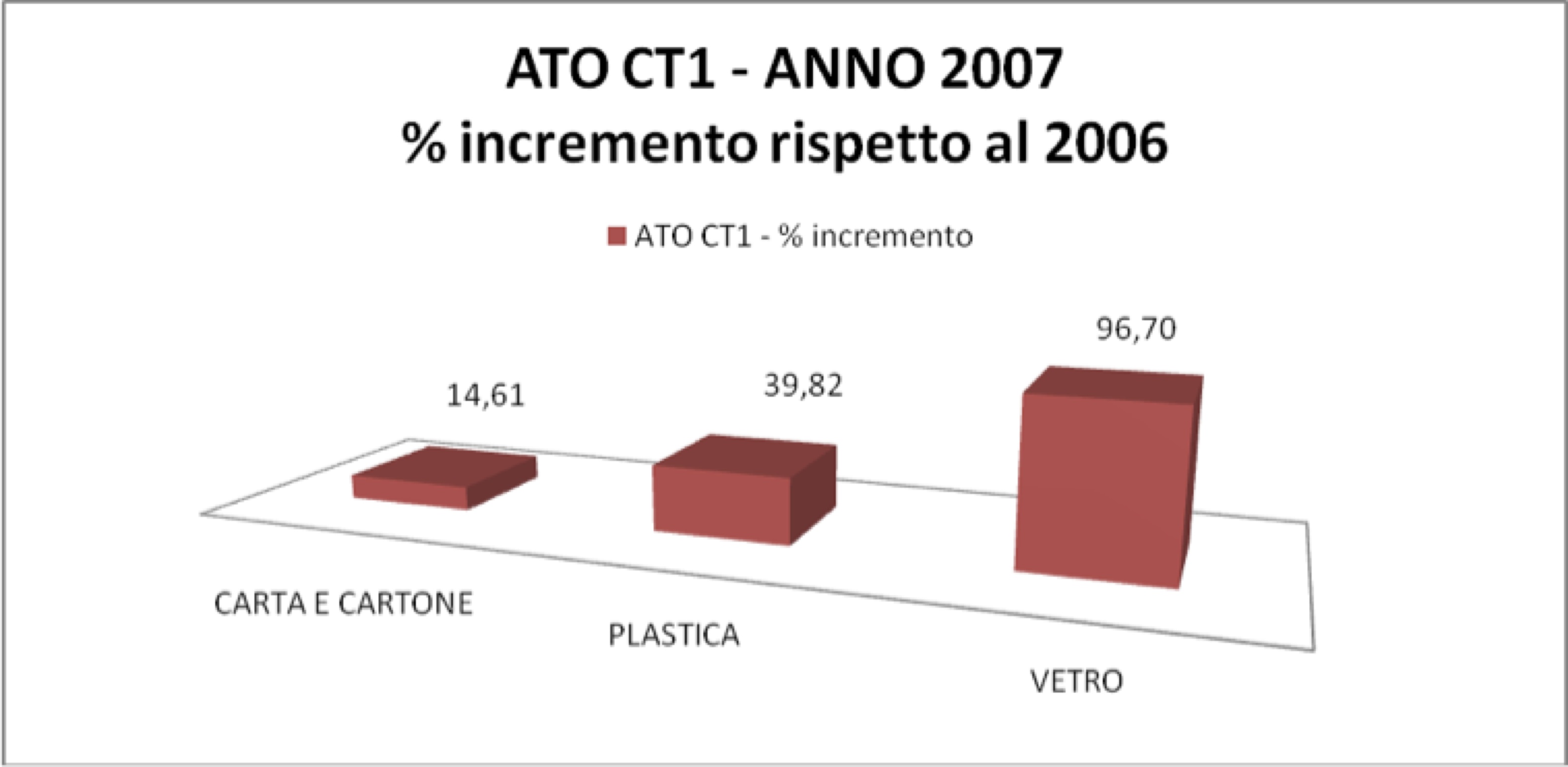
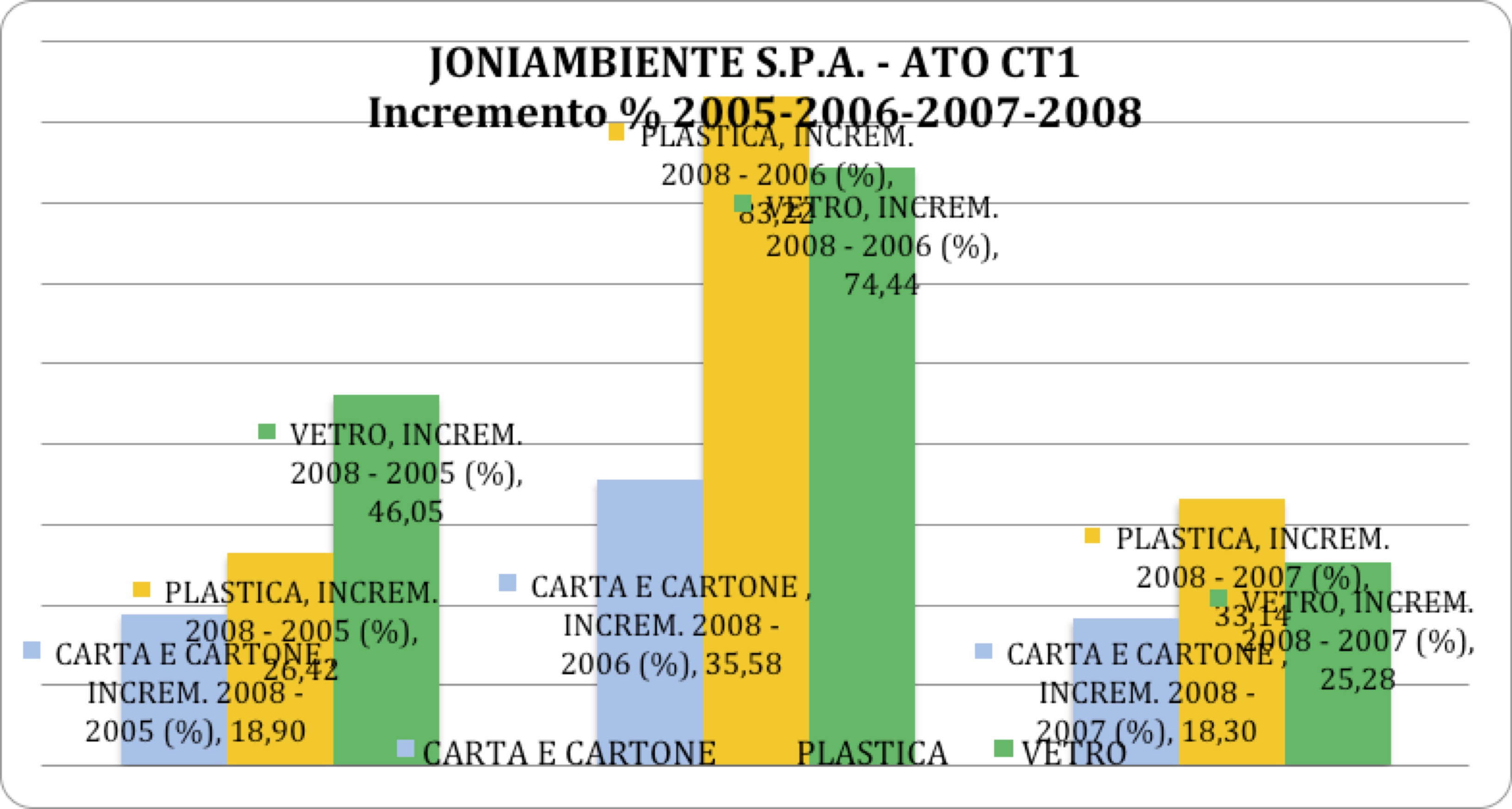
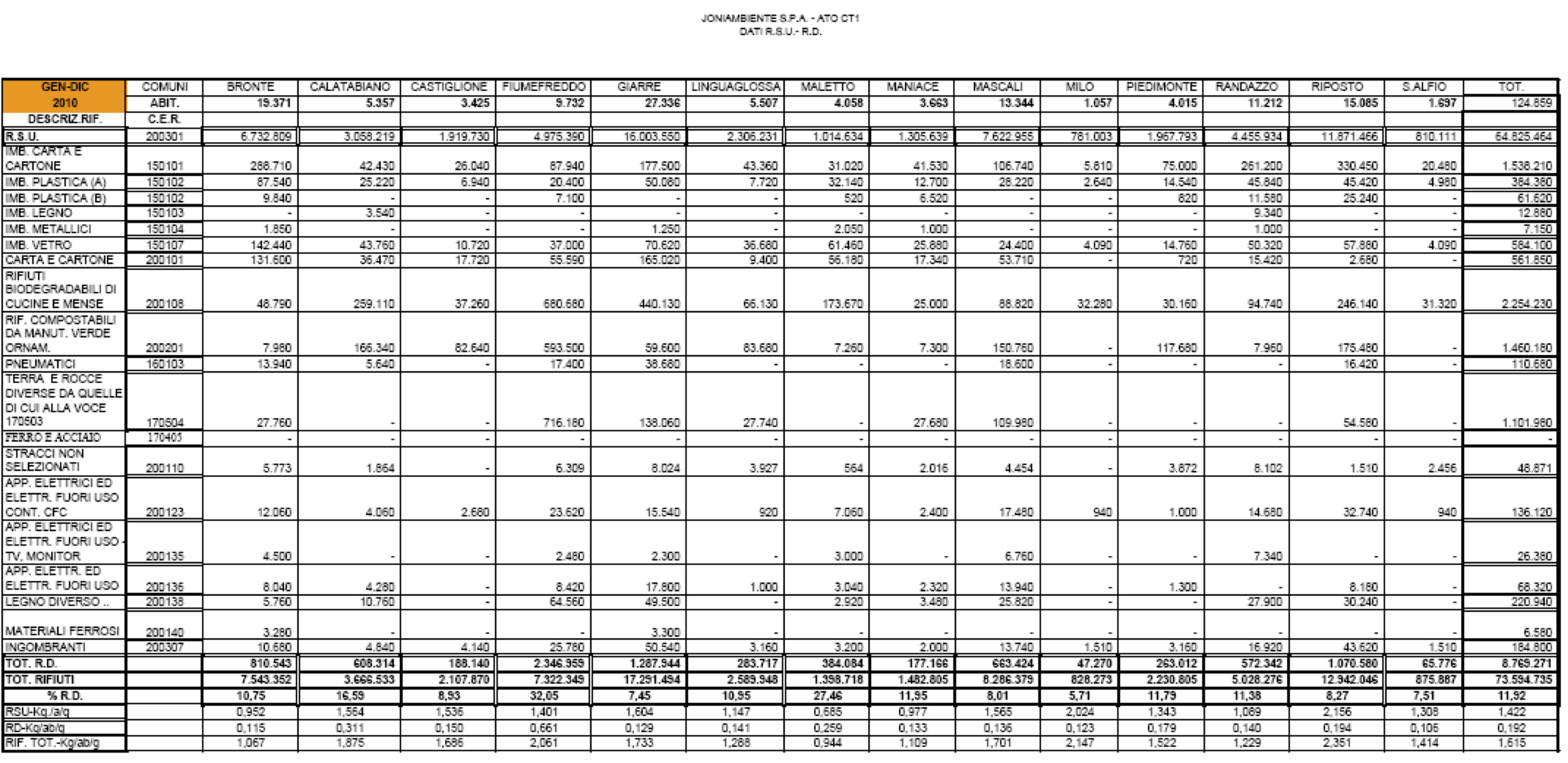
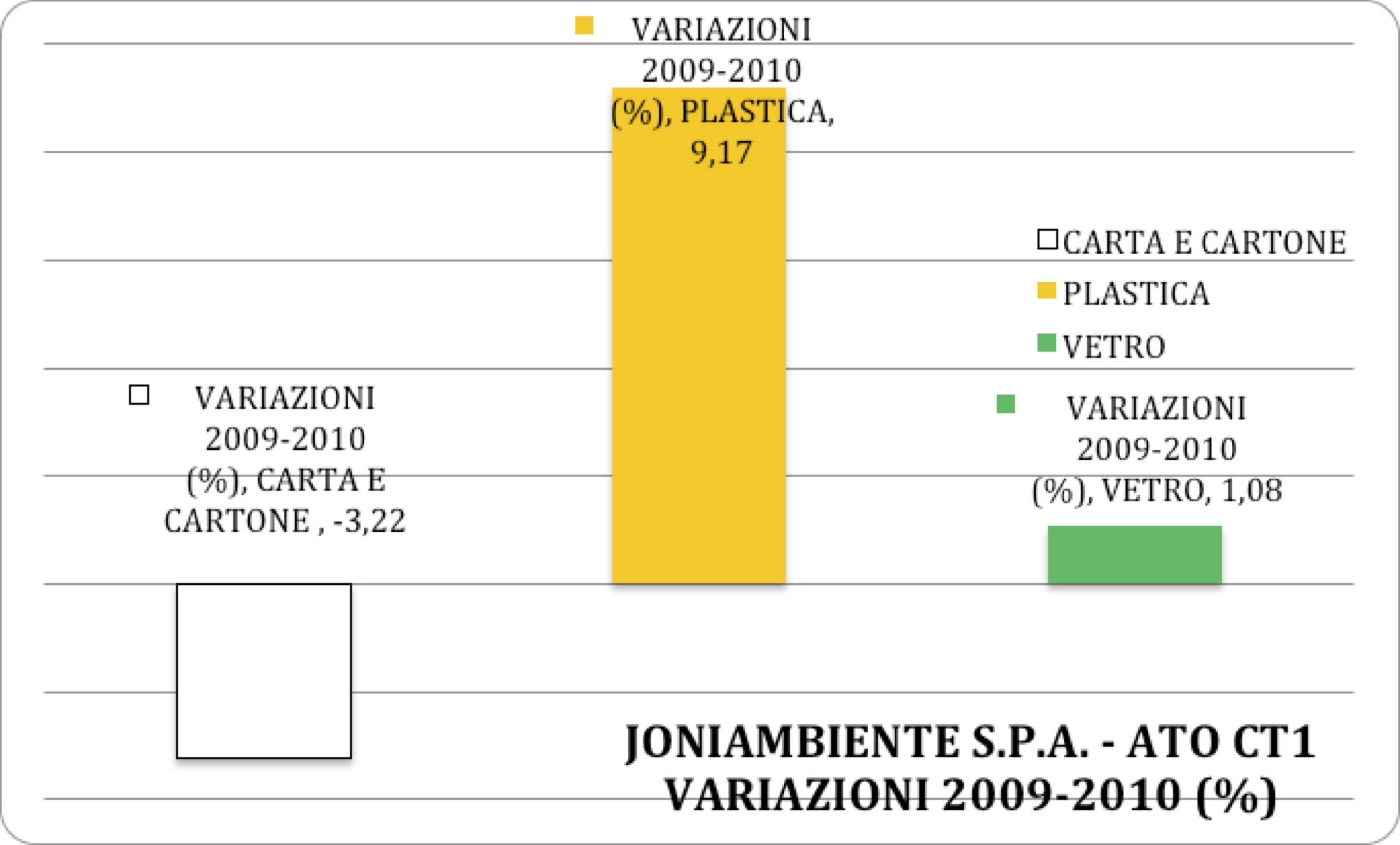







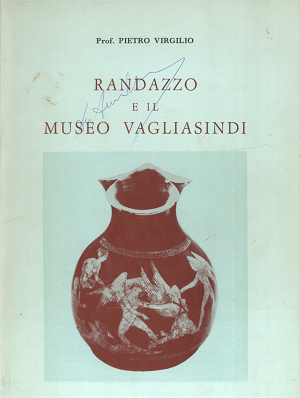






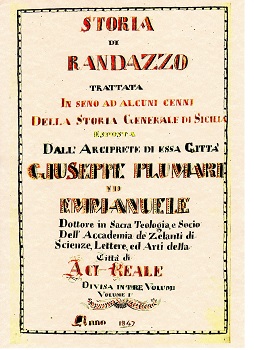
















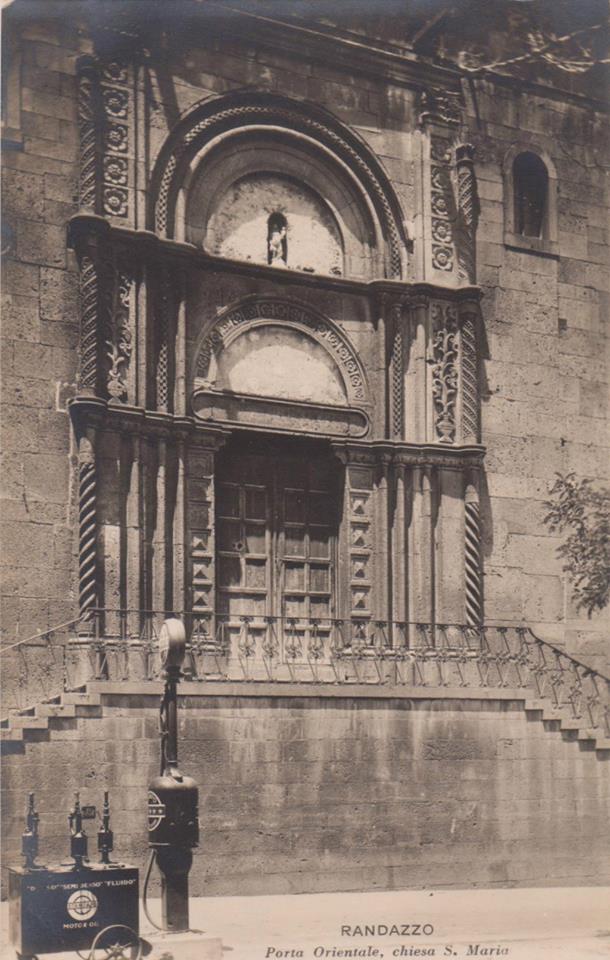









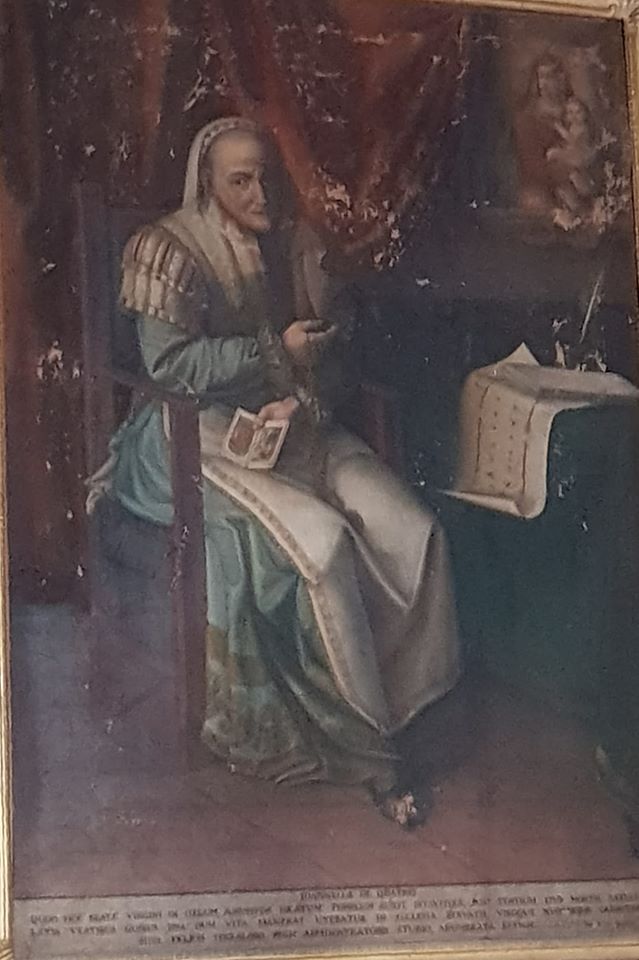


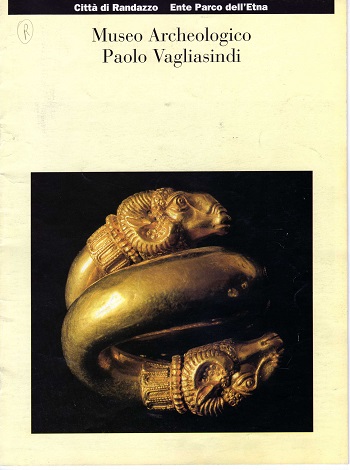




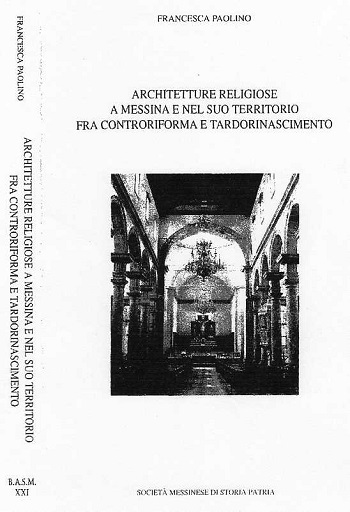
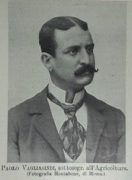


















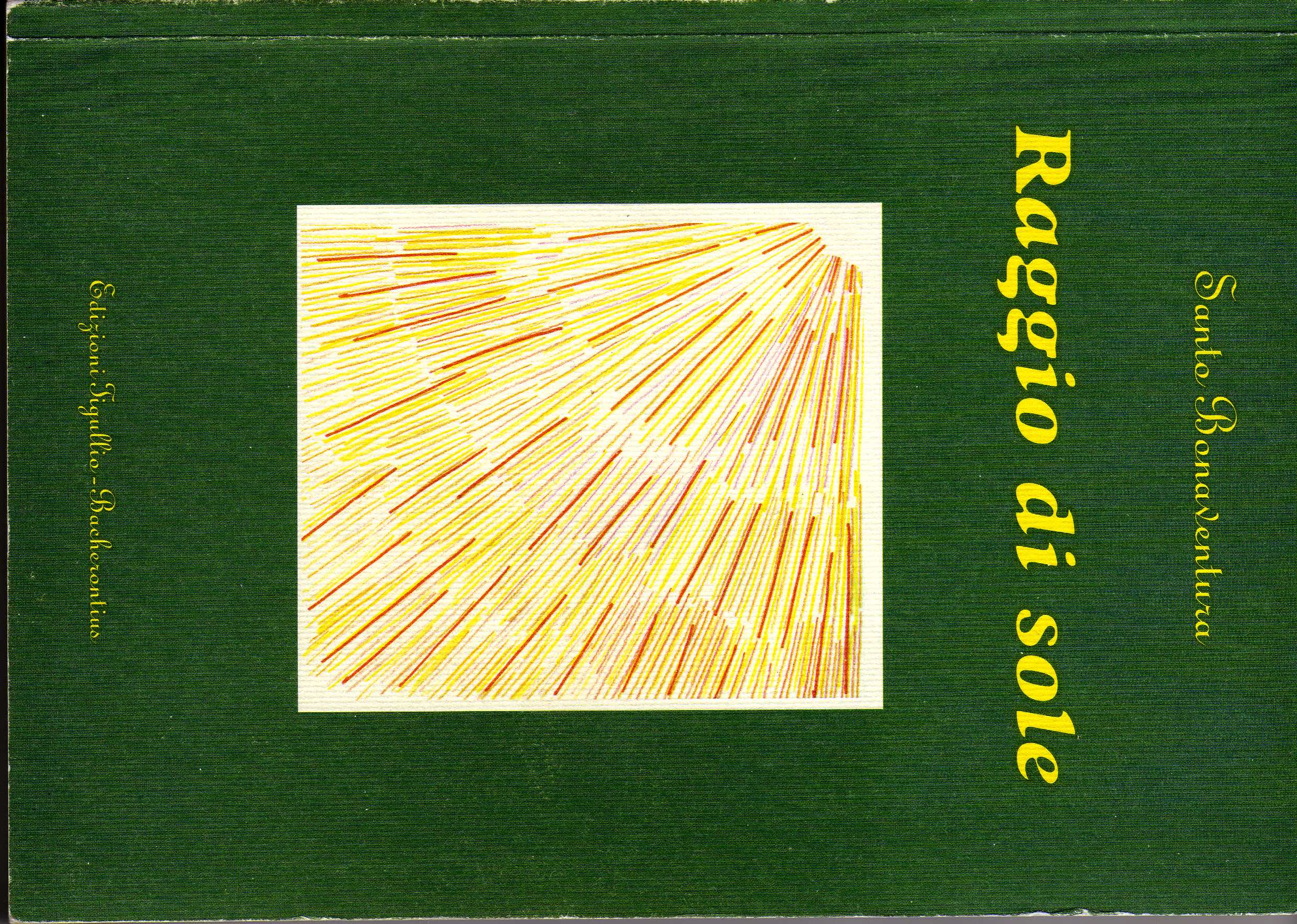
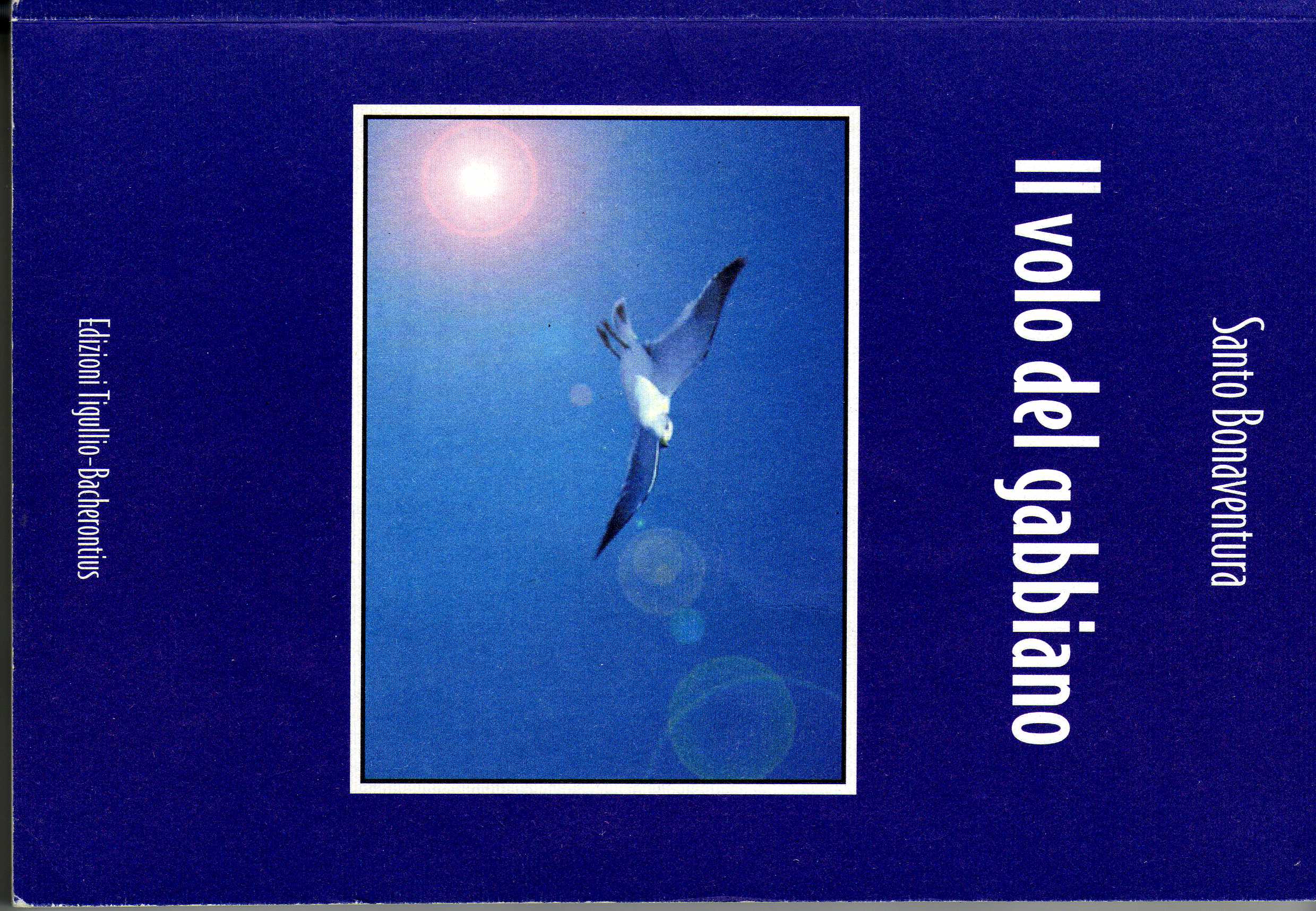





















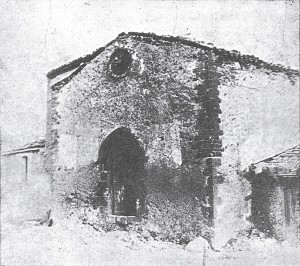

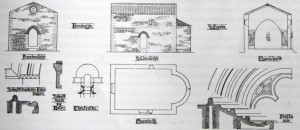


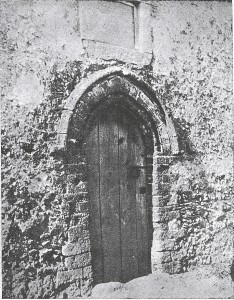


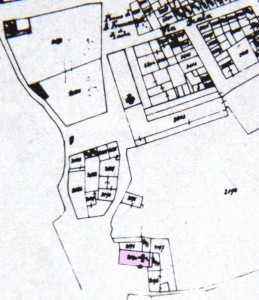
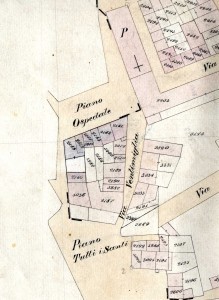

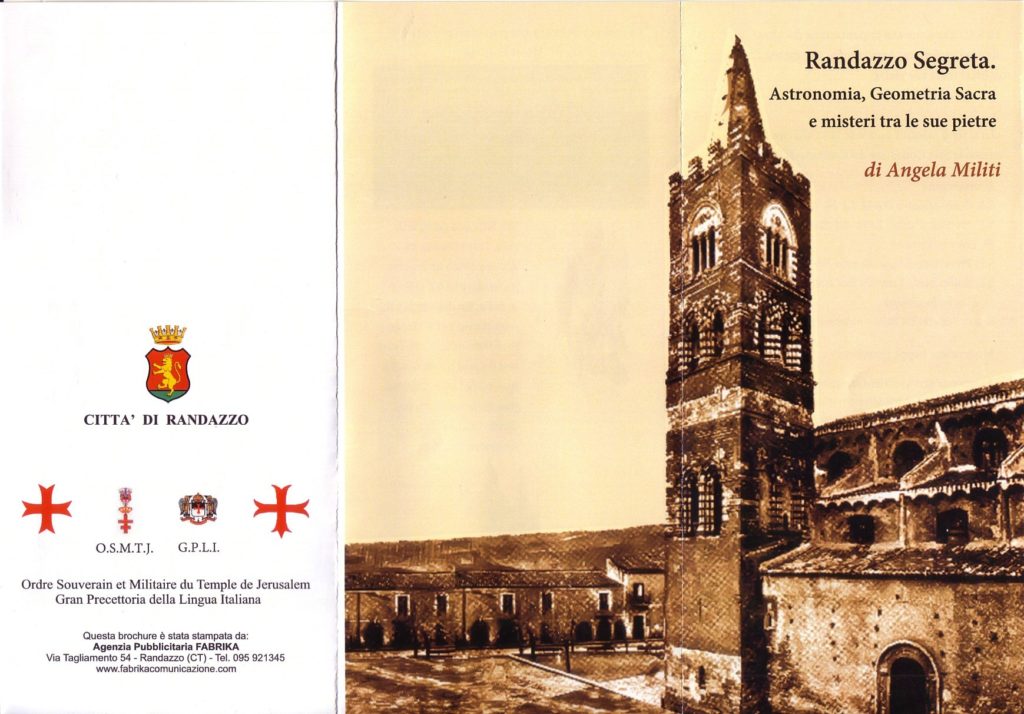





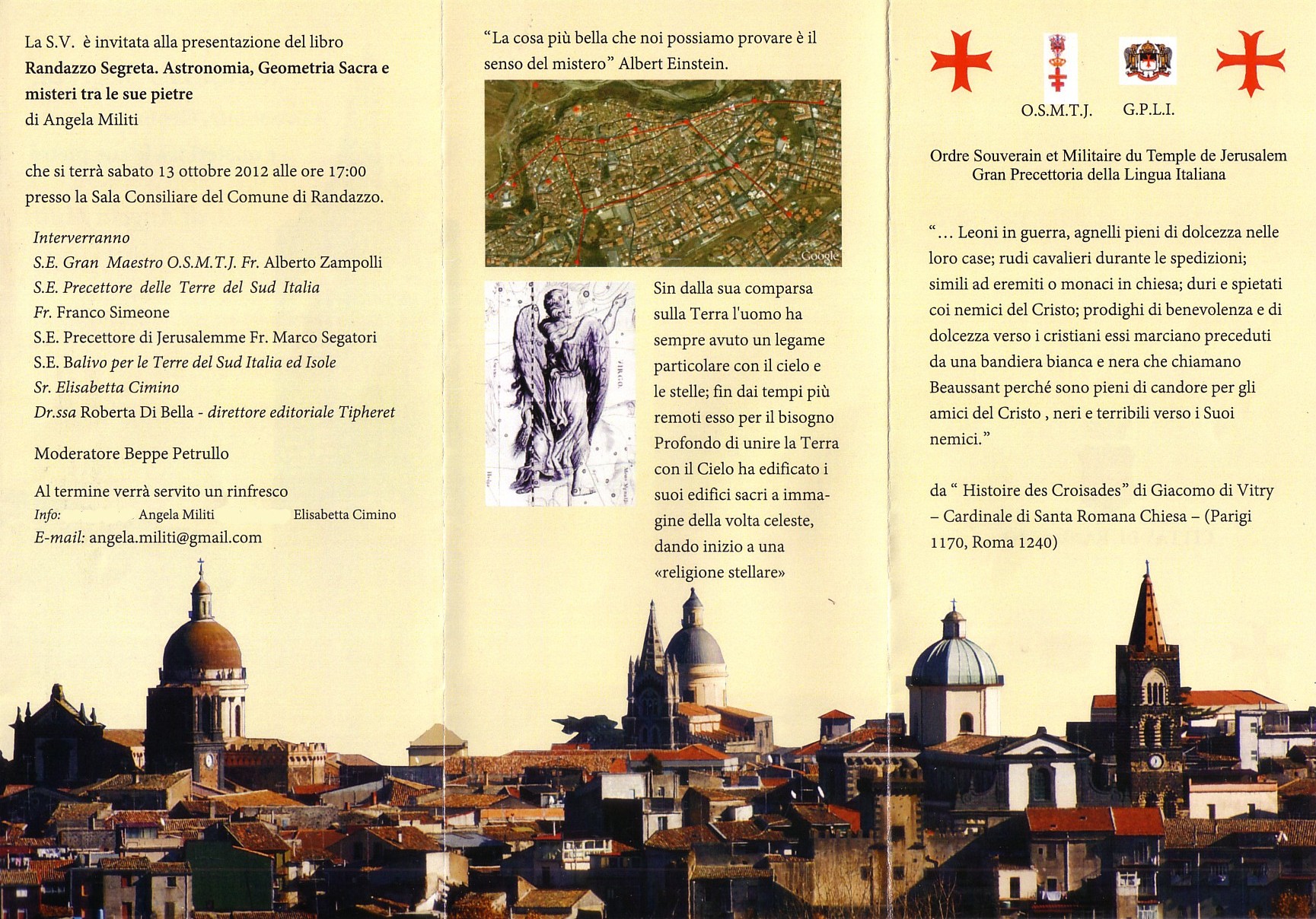





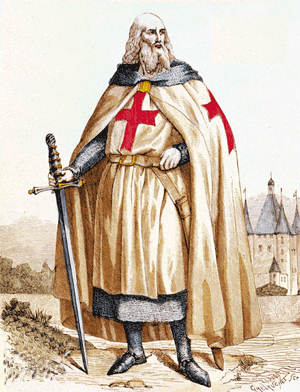

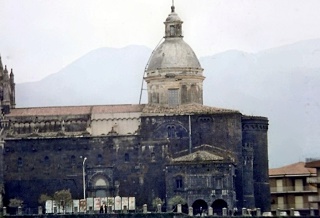
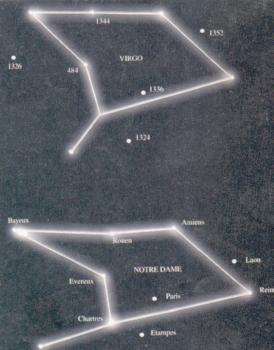



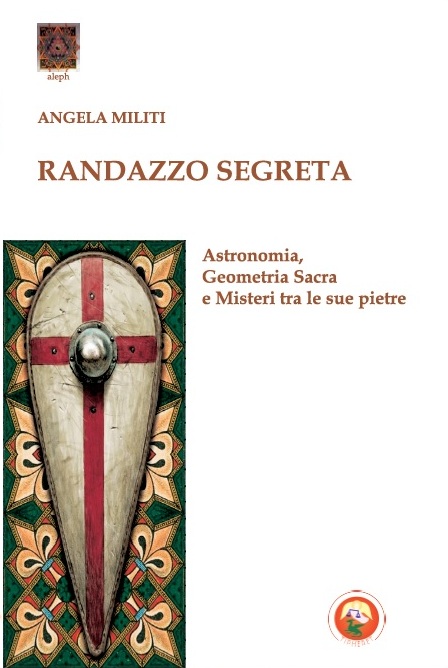
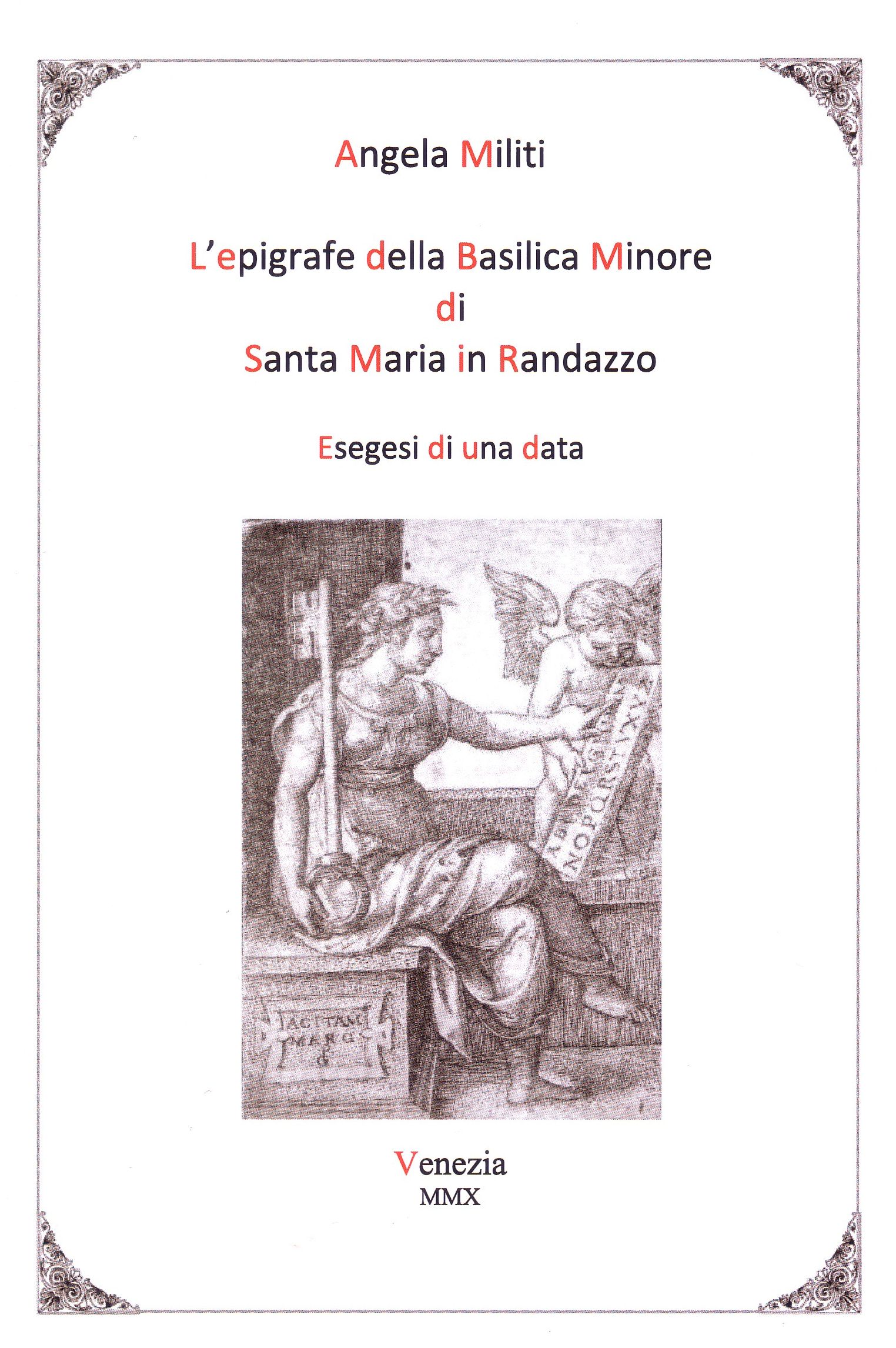











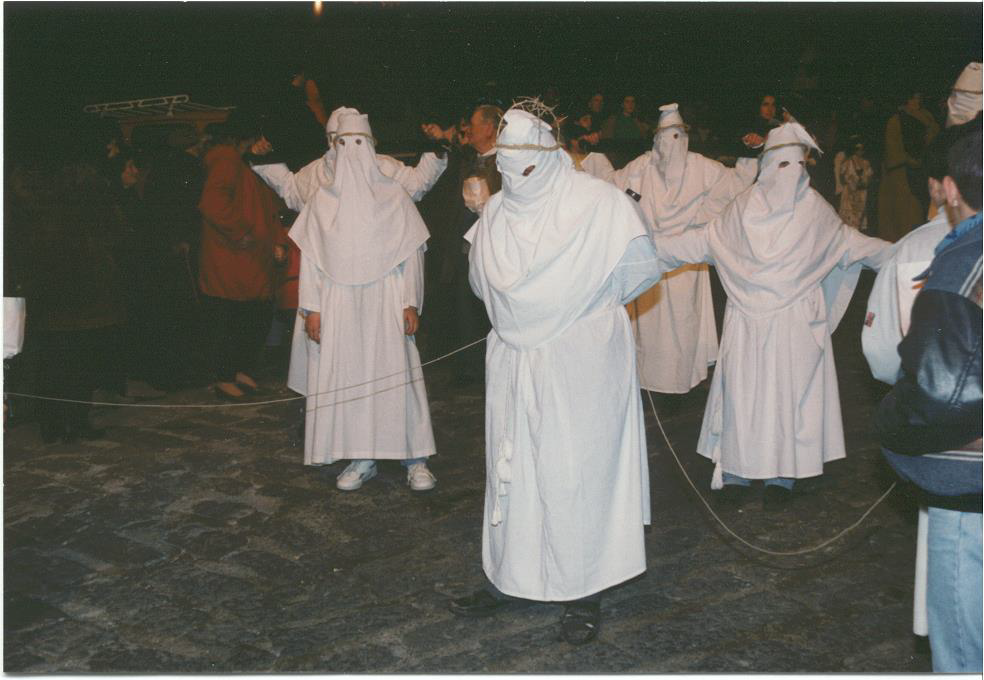
























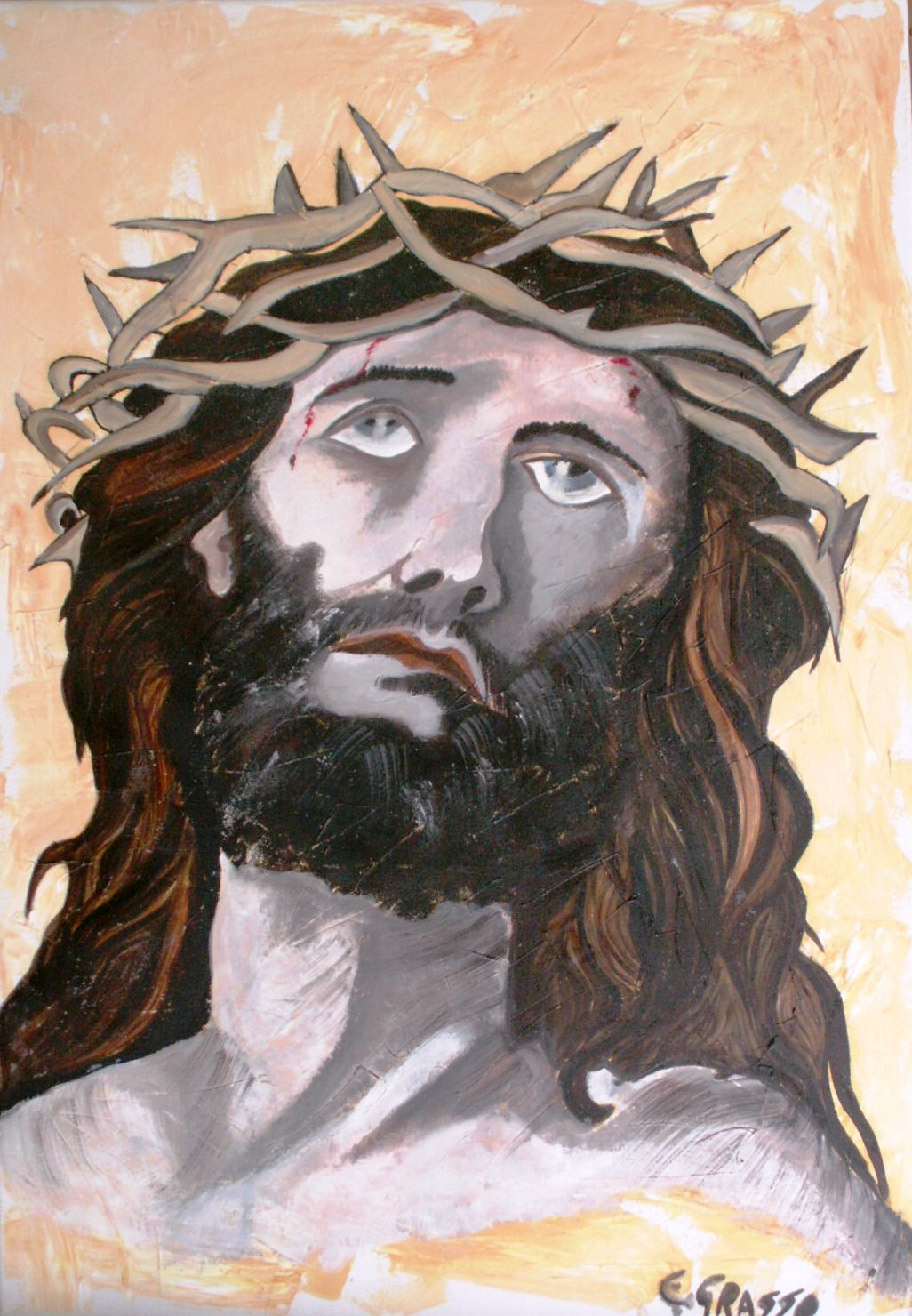
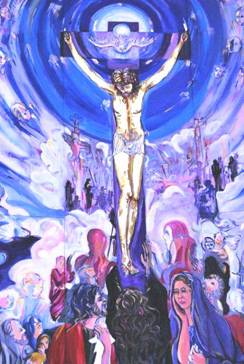

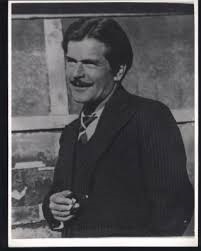















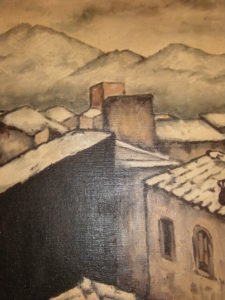









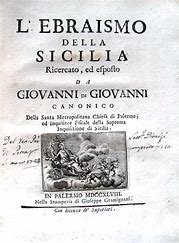














































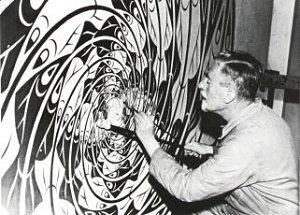



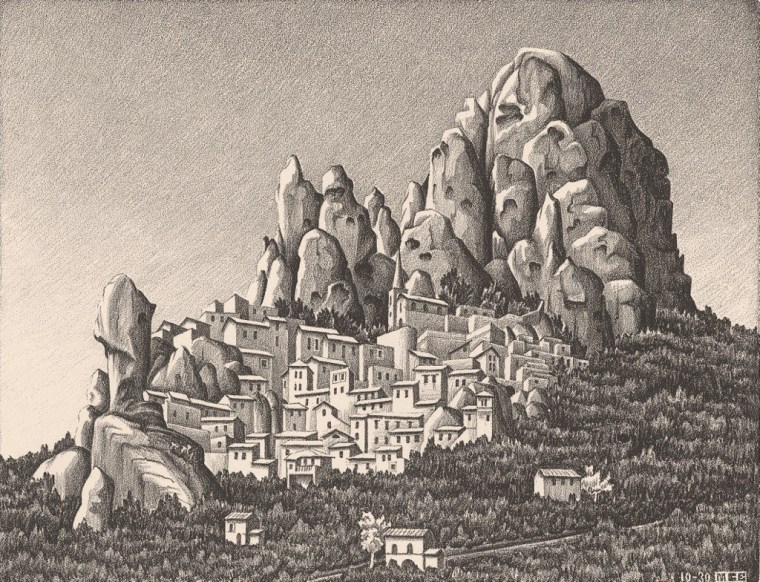





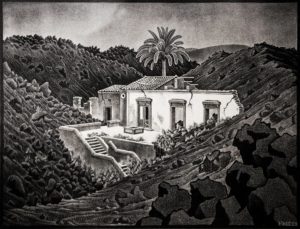



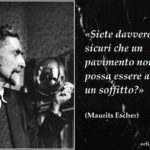

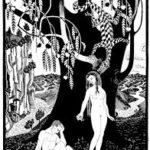










 Tornava in Sicilia per brevi periodi, durante le vacanze estive, per fermarsi nella natìa Randazzo, vi frequentava assiduamente la Basilica di S. Maria offrendo la propria collaborazione, senza tralasciare di recarsi ad Acireale, dai Frati Camilliani, dov’era avvenuta la sua prima formazione.
Tornava in Sicilia per brevi periodi, durante le vacanze estive, per fermarsi nella natìa Randazzo, vi frequentava assiduamente la Basilica di S. Maria offrendo la propria collaborazione, senza tralasciare di recarsi ad Acireale, dai Frati Camilliani, dov’era avvenuta la sua prima formazione.

























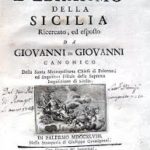
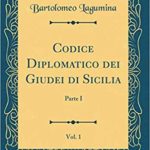












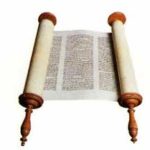
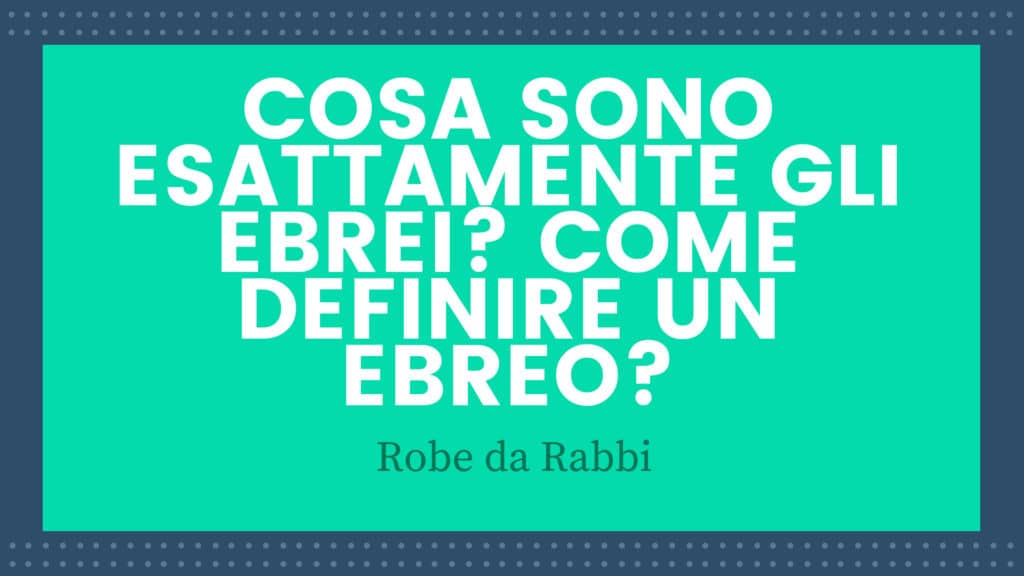
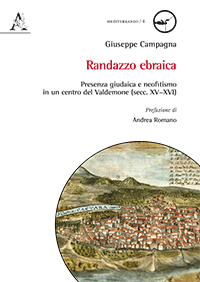

















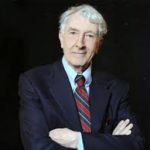






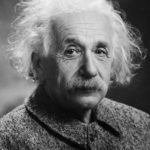


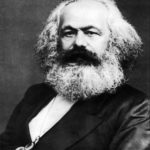












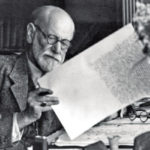




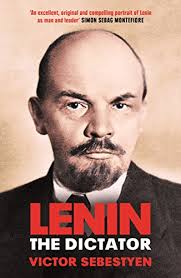





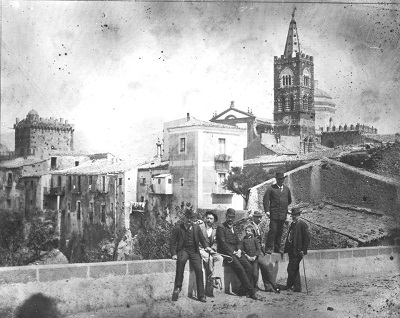

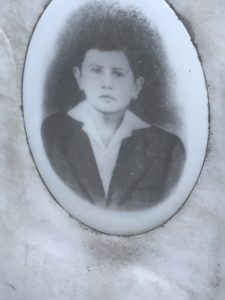









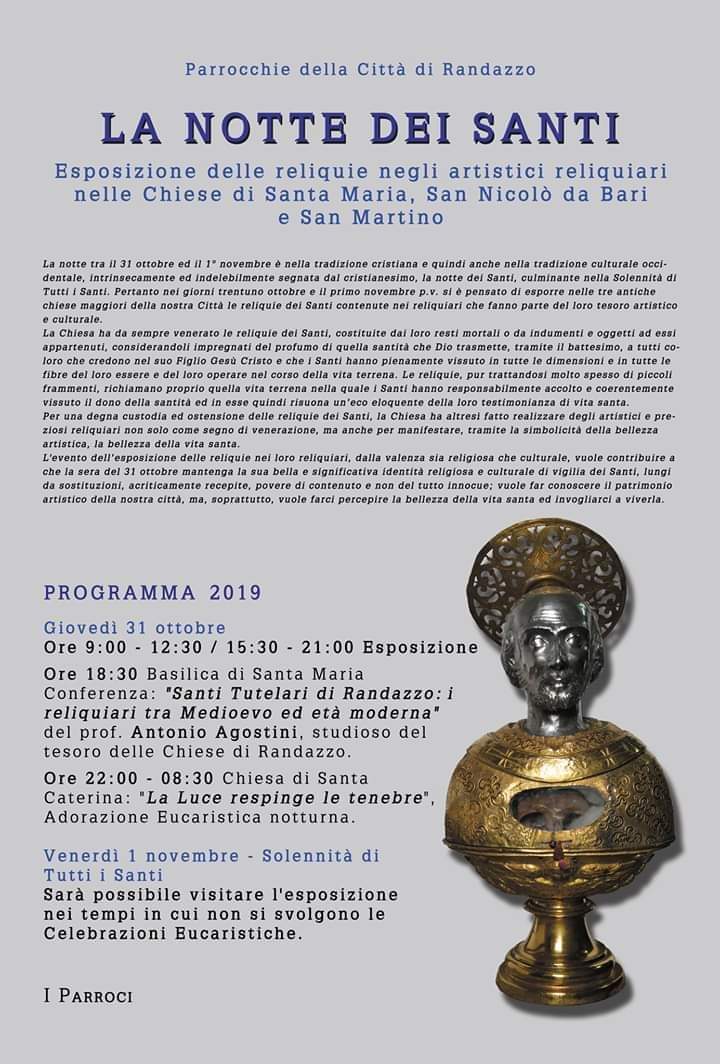


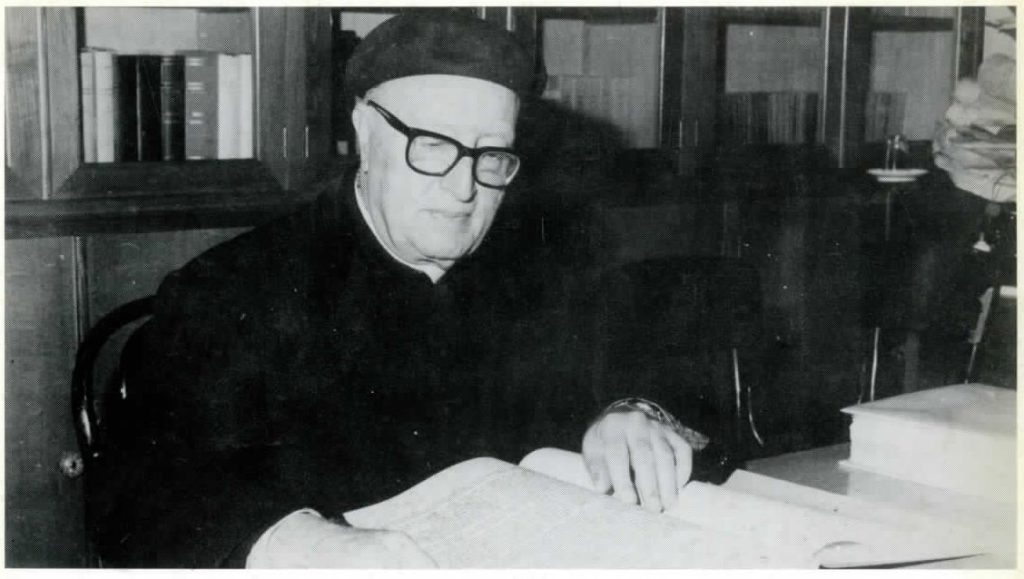


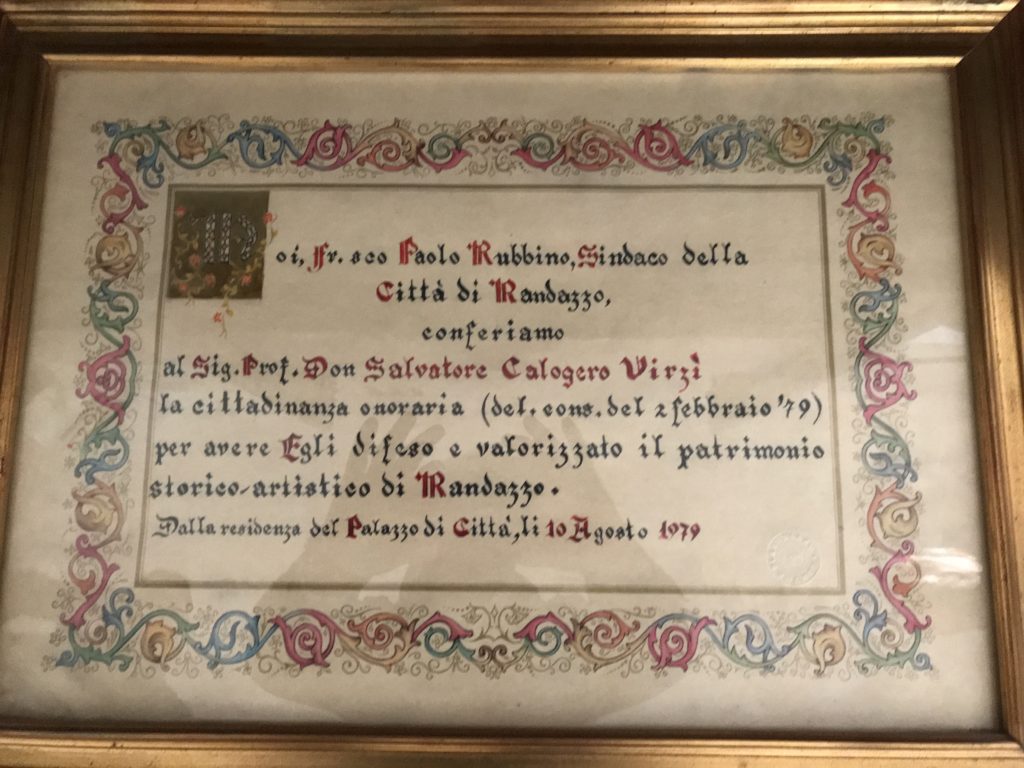



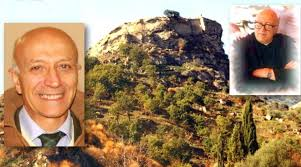




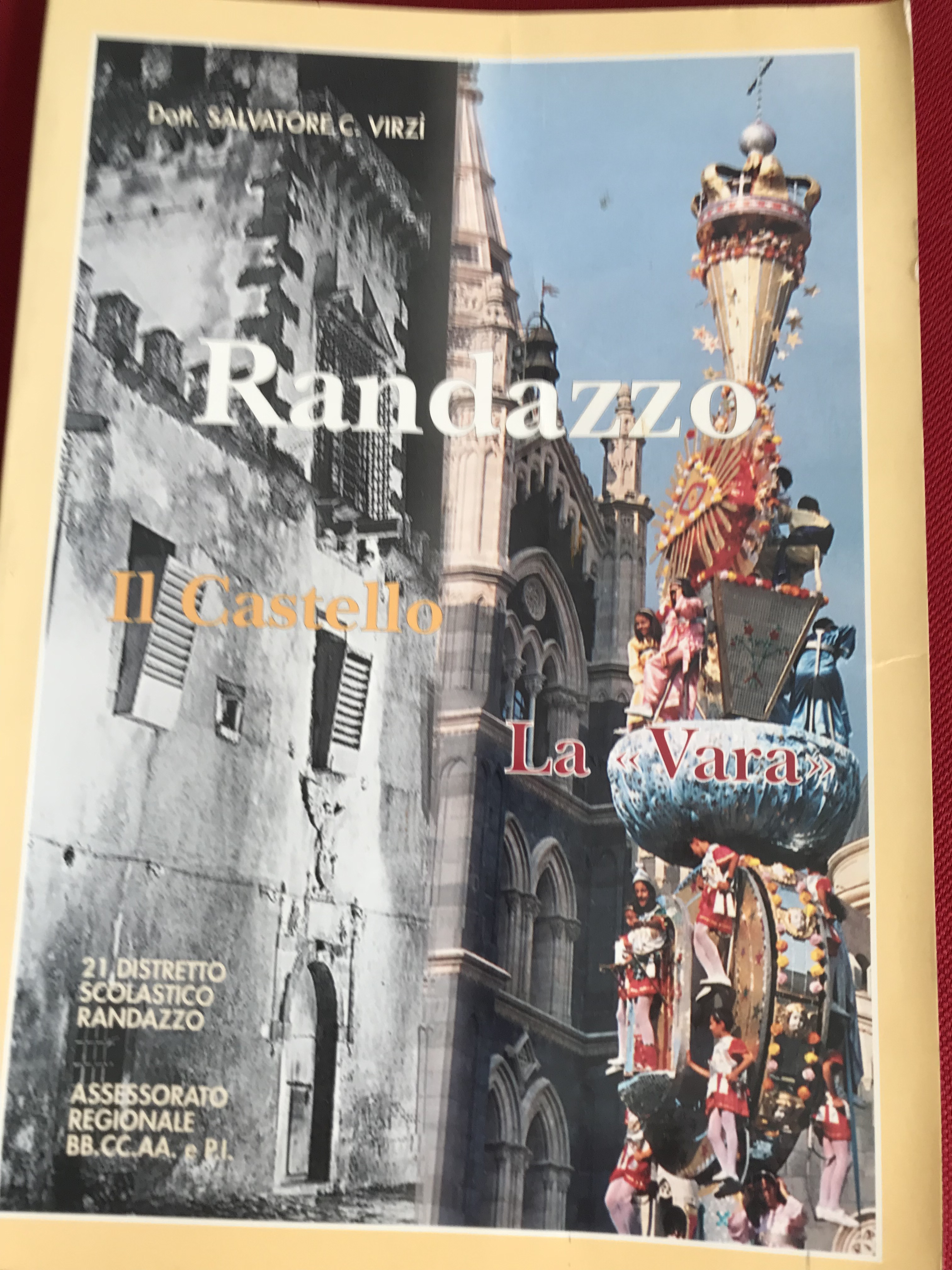
























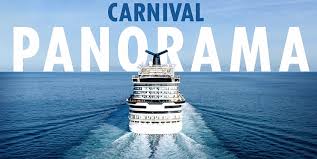









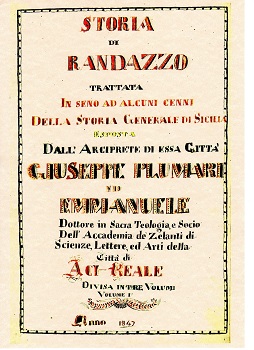





















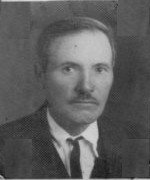










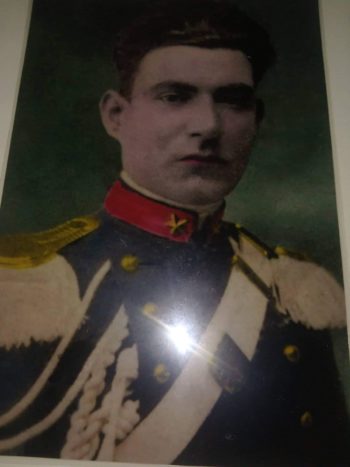























 http://cricatania.it/category/randazzo/
http://cricatania.it/category/randazzo/